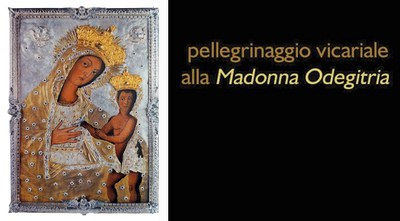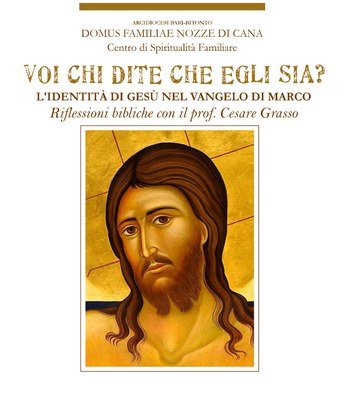Incontro Cei su Mediterraneo. Mons. Pizzaballa (Celra): “A Bari per dare un orientamento alle nostre comunità”
“Un incontro che si pone in continuità con quello, sempre a Bari, del 7 luglio 2018 con i capi delle Chiese e comunità cristiane del Medio Oriente, voluto da Papa Francesco. Questo promosso dalla Cei sarà un momento significativo di confronto tra i vescovi cattolici di 20 Paesi che si affacciano sul Mare Nostrum, utile a far conoscere le rispettive esperienze e ad avere qualche punto comune così da dare un orientamento alle nostre comunità. Lo scopo non è risolvere problemi ma indicare alle nostre comunità come vivere dentro le rispettive situazioni”.
 Ci sarà anche mons. Pierbattista Pizzaballa, arcivescovo, amministratore apostolico del Patriarcato Latino di Gerusalemme, tra i partecipanti al meeting “Mediterraneo, frontiera di pace”, che avrà luogo nel capoluogo pugliese dal 19 al 23 febbraio. “Un’assise unica nel suo genere – l’ha definita il presidente della Cei, card, Gualtiero Bassetti – basata sull’ascolto e sul discernimento comunitario; soprattutto, un incontro che, valorizzando il metodo sinodale, si prefigge di compiere un piccolo passo verso la promozione di una cultura del dialogo e verso la costruzione della pace in Europa e in tutto il bacino del Mare Nostrum”. A Bari mons. Pizzaballa rappresenterà la Celra (Conferenza dei vescovi latini delle Regioni arabe) di cui fanno parte il Nord e Sud Arabia, Qatar, Kuwait, Yemen, Libano, Iraq, Somalia, Siria, Terra Santa con Israele e Palestina, Giordania.
Ci sarà anche mons. Pierbattista Pizzaballa, arcivescovo, amministratore apostolico del Patriarcato Latino di Gerusalemme, tra i partecipanti al meeting “Mediterraneo, frontiera di pace”, che avrà luogo nel capoluogo pugliese dal 19 al 23 febbraio. “Un’assise unica nel suo genere – l’ha definita il presidente della Cei, card, Gualtiero Bassetti – basata sull’ascolto e sul discernimento comunitario; soprattutto, un incontro che, valorizzando il metodo sinodale, si prefigge di compiere un piccolo passo verso la promozione di una cultura del dialogo e verso la costruzione della pace in Europa e in tutto il bacino del Mare Nostrum”. A Bari mons. Pizzaballa rappresenterà la Celra (Conferenza dei vescovi latini delle Regioni arabe) di cui fanno parte il Nord e Sud Arabia, Qatar, Kuwait, Yemen, Libano, Iraq, Somalia, Siria, Terra Santa con Israele e Palestina, Giordania.
Eccellenza, si tratta di Paesi purtroppo noti alla cronaca per guerre e gravi conflitti sociali e politici. Quale contributo potrà dare la Celra all’incontro di Bari?
Innanzitutto, cercheremo di far conoscere la situazione dei nostri Paesi, non tanto dalla prospettiva politica ma da quella della vita delle nostre comunità. Racconteremo come vivono a causa delle guerre, descriveremo le loro sofferenze ma anche le loro motivazioni, poiché se sono ancora lì è perché hanno scelto di restare. E cercheremo insieme di capire qual è la nostra vocazione in questo contesto. Come ho già detto nell’omelia del 1° gennaio, non siamo chiamati a testimoniare solo come singoli credenti il nostro desiderio di dialogo. Esso deve essere innanzitutto testimonianza di tutta la Chiesa, nel suo insieme, intesa come comunità e non come istituzione. Questa oggi è la vocazione primaria della nostra Chiesa nelle nostre Terre.
Su cosa puntare affinché questa cultura del dialogo possa trovare una spinta decisiva?
Prima di parlare del dialogo e delle Chiese bisogna rafforzare il sentimento di appartenenza alla comunità.
Noi dialoghiamo come Chiese, come leadership, come singoli. Ma la prima cosa che un pastore deve fare è tenere unito e rafforzare il sentimento di comunità all’interno delle nostre situazioni politiche complicate, dove la politica è assente, con le società che si stanno sfaldando, dove ci sono tensioni religiose di ogni genere.
Abbiamo il dovere di costruire comunità riconciliate e ospitali, aperte, autentici spazi di fraternità condivisa e di dialogo sincero. Alla strategia della contrapposizione va contrapposta l’arte del dialogo. E la prima cosa da fare è
rafforzare il senso di comunità. Solo così si può stimolare la cultura del dialogo.
Dialogo che parte sempre dalla vita, non da idee astratte. Le nostre comunità devono continuare a dialogare e per fare questo devono ‘uscire’, essere presenti nella vita comune, scuole, parrocchie, varie attività. È qui che dobbiamo diventare tutti artefici di dialogo. Non si può vivere, per esempio, insieme ai musulmani senza parlare con loro.
In molti dei Paesi che lei rappresenta il dialogo “alla base” è, in qualche modo, già una realtà. Che cosa manca allora?
Una maggiore consapevolezza. L’incontro e il dialogo vanno vissuti con maggiore coscienza. Essere consapevoli che quello che si sta vivendo è una cosa grande e per questo non va vissuta passivamente. Sarebbe una grave mancanza di fede cedere ad atteggiamenti rassegnati. Il dialogo è innanzitutto un’attitudine spirituale e indica la capacità ad uscire da sé per ascoltare realmente le attese altrui.
Quale futuro vede per il bacino del Mediterraneo, che Giorgio La Pira definiva come una sorta di “grande lago di Tiberiade”?
La storia parla per noi. In questi più di 2000 anni di storia il Mediterraneo è sempre stato al centro. Non ci sono state solo guerre e tensioni ma anche scambi culturali, sociali, economici e commerciali. Nel futuro accadrà lo stesso. La domanda per me è: come cristiani dove saremo? La risposta non dipende dai numeri ma dal contenuto delle nostre idee, dallo spessore della nostra fede.
Non teme, quindi, l’esodo dei cristiani da questo bacino?
Questa area non resterà mai priva della presenza cristiana. Ci saranno zone più povere e altre più ricche. Oggi assistiamo a fenomeni migratori in tutte le direzioni. Ci sono cristiani che partono e altri che arrivano, penso all’Arabia Saudita, a Israele, tanto per fare qualche esempio. Non bisogna vivere tenendo il passato come riferimento, come una sorta di feticcio.
Non stiamo morendo, stiamo cambiando.
Ci sono mutamenti evidenti e su questi vogliamo avere qualcosa da dire…
Nel Mediterraneo Oriente e Occidente si toccano, ma sembrano dialogare poco…
Il problema dell’Occidente è che parla di noi e non parla con noi.
Piazze irachene e libanesi in fermento: che segnali sono?
Sono segnali belli e molto importanti. Non porteranno frutti immediati perché le manifestazioni non possono continuare in eterno. Tanto più se non saranno tradotte in decisioni concrete dalle rispettive leadership politiche. Il timore è questo. Ciò che è comune in tutto il Medio Oriente è proprio la debolezza delle leadership incapaci di prendere decisioni politiche che rispondano alle attese dei popoli. Nonostante ciò, le manifestazioni cui stiamo assistendo stanno provocando un forte cambio di mentalità, di pensiero, di cultura, di relazioni che certamente nei tempi medi daranno frutti.
Potrebbe essere questa la stagione di una nuova presenza cristiana anche in politica?
L’impegno dei cristiani in politica è una tradizione che esiste, soprattutto in Libano. Io credo che
come cristiani dobbiamo smettere di lamentarci e cominciare a costruire.
Come ho già avuto modo di dire, non si può tacere di fronte alle ingiustizie o invitare i cristiani al quieto vivere e al disimpegno. L’opzione preferenziale per i poveri e i deboli, però, non fa della Chiesa un partito politico. La Chiesa ama e serve la polis e condivide con le autorità civili la preoccupazione e l’azione per il bene comune, nell’interesse generale di tutti e specialmente dei poveri.
Daniele Rocchi
© www.agensir.it, giovedì 6 febbraio 2020