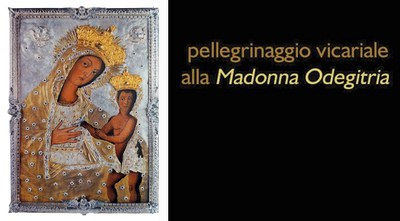La Gioconda? Non ha niente da ridere

Nel mondo magico delle arti visive, curiosamente, c’è ben poco da ridere. L’opera musicale, quella iniziata dai primi esperimenti di Claudio Monteverdi, ci mise pochissimo a passare dall’essere melodrammatica al diventare opera buffa. In fondo la gente ama divertirsi e già Rabelais, quello di Gargantua, aveva sostenuto che il ridere è lo specifico dell’essere umano («Le rire est le propre de l’homme»).
Dagli anni della serva padrona di Pergolesi l’opera comica emigrò da Napoli a Roma e poi a tutto il mondo, convertendo da Mozart a Rossini. Non per niente era nata a Napoli, luogo dove il buonumore era dottrina della vita quotidiana forse per riequilibrare la severità barocca di Caravaggio e dei caravaggeschi. Andate invece a trovare la stessa leggerezza ironica nella pittura e farete una bella fatica. La pittura storica ha sempre un qualcosa di serio, che sia religiosa o profana, e solo ai signori del Seicento lombardo venivano offerti i dipinti dei poveretti di Cerruti o del Todeschini da appendere nelle loro cucine per metterli di buon umore; i ricchi s’intende, non i poveri rappresentati con i vestiti a cenci. Bisogna aspettare l’approdo nel mondo della pittura dell’Inghilterra del Settecento per vedere apparire i primi sintomi d’una cosa nuova: il sense of humour o sense of humor che si sviluppa con la critica sociale di William Hogarth, quando il pittore inventa cicli interi di dipinti che sono il contrappunto alla commedia classica, quella che castigat ridendo mores.
Cicli come La carriera d’un libertino oppure il Matrimonio alla moda nascono per fare sorridere il pubblico e talvolta addirittura farlo ridere. Nella serie dedicata alle Elezioni, Hogarth prende in esame la carriera politica e la propaganda elettorale con una tale virulenza che lo spettatore si trova in una situazione ben più vitale addirittura di quella del teatro: a cena tutti ubriachi, compreso il parroco che perde la parrucca e rimane con il cranio rasato e brillante, oppure per strada quando i partiti opposti finiscono in rissa e il candidato viene messo in ballottaggio vero e proprio sulla portantina che lo trasporta. L’immagine ha rotto così il velario della serietà. Approda in Francia nel XIX secolo ma non ce la fa a reggere la severa pittura d’un mondo artistico costantemente impegnato nel dibattito politico, quello duro delle rivoluzioni successive. Si rifugia in quello che è la televisione d’allora, il modo di fare vedere lontano i fatti della vita elitaria, e cioè nella galassia di pubblicazioni cartacee nascono dalla rivista Charivari, un foglio tossico e antipolitico che nasce nel 1832 e durerà oltre un secolo. Vi collaborano da Gustave Doré, quello che illustra anche la Divina Commedia, a Daumier che già lavorava per La Caricature, dove aveva rappresentato il nuovo re costituzionale Luigi Filippo come un ciccione seduto con una lingua tirata fino a terra sulla quale salivano i suoi cortigiani per alimentarlo. Finì ovviamente per sei mesi in galera.
Era possibile far ridere ma a proprie spese e pericolo. E così sul finire del secolo apparirà il settimanale Le Rire, dove il ridere dei guai personali e di quelli della società diventa un obbligo. A tal punto che nel 1900 il serissimo filosofo Henri Bergson darà alle stampe un testo fondamentale sul ridere appunto. Nel frattempo il più eccentrico degli approdati a Parigi, il milanese Medardo Rosso, aveva rotto gli argini della scultura seria rappresentando ben tre diversi casi di riso: quello d’un fanciullo (facile e ovvio oggi da capire), quello d’una donna adulta e quello d’una vecchiaccia sdentata che nella realtà italica fu chiamata «La Ruffiana». C’era sempre poco da ridere col ridere.
I tedeschi s’erano svegliati pure loro con quella bella rivista che fu il Semplicissimus, carico d’un sense of humour bavarese allora tutt’altro che greve, anzi sottilmente pacifista e popolare. L’Italia aveva dato vita già dal 1892 a L’asino, che recava in sottotitolo «il popolo utile, paziente e bastonato». Era stato inventato da un carducciano, Guido Podrecca, e da un matematico con grande abilità da disegnatore, Gabriele Galantara. Ma ancora una volta era solo la politica a far ridere. Comunque se risulta evidente che il ridere difficilmente si declina con le arti visive, se non nella fase cartacea e satirica, il sorridere è ben altra cosa.
Il sorriso è carico di mistero, sin dalla notte dei tempi. Sorridono gli statuoni dell’antico mondo babilonese, anche se si fa fatica a capirne il perché, viste le loro barbe intrecciate. Sorridono gli dei greci prima della classicità, in modo particolare i kuroi dalle labbra enigmatiche e dagli occhi fissi. Sorridono i primi etruschi con un sorriso assai analogo, come testimonia l’Apollo di Veio. Anzi gli etruschi continuano a sorridere anche quando si fanno conquistare dai romani e diventano, nelle loro statue funebri, simpatici grassoni che mangiano per tutta la notte dei loro inferi. Il sorriso viene per lungo tempo poi dimenticato. Troppo seri sono i bizantini per affrontare la questione, troppo ieratici. Bisogna aspettare il Rinascimento perché torni il Sorriso dell’Ignoto Marinaio di Antonello da Messina, come scrive Vincenzo Consolo. E così tornano a sorridere i ritratti di Leonardo, primo fra tutti ovviamente quello misterioso della Gioconda.
La via è libera: anche le Madonne di Perugino e di Raffaello tornano a sorridere dolcemente. Il sorriso è ormai sdoganato nella pittura, purché non si tratti di raffigurare i regnanti. Quelli si sa che non sorridono mai. Sicché sorridono all’infinito le bambolotte che Renoir spaccia per signorine parigine. Sono ormai pronte per il coperchio delle scatole dei cioccolatini. Ma lì si ferma il percorso. Nel XX secolo ci sarà poco da sorridere. Il ghigno è ben più appropriato al secolo delle grandi catastrofi.