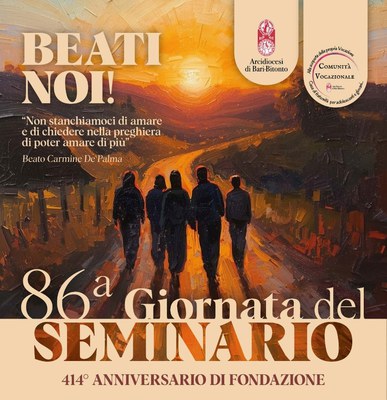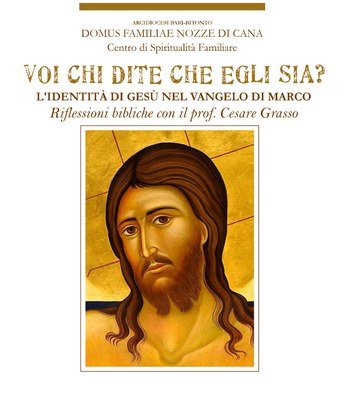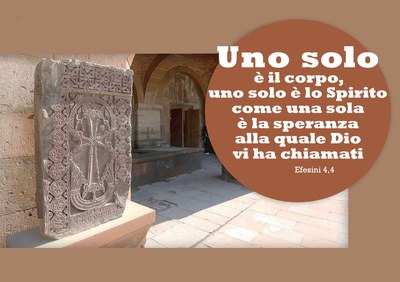Referendum, istruzioni per l'uso
 Si chiede di esprimersi sulla normache introduce la possibilità, per chi èimpegnato in attività di Governo, di non comparire nelle aule di giustizia.
Si chiede di esprimersi sulla normache introduce la possibilità, per chi èimpegnato in attività di Governo, di non comparire nelle aule di giustizia.
La quarta scheda ci interroga sul futuro di un istituto giuridico introdotto dal Governo, che concede al presidente del Consiglio e ai suoi ministri di sottrarsi a un’udienza penale – nella quale siano chiamati come imputati – se sopraggiungono impegni di carattere istituzionale. Il nostro ordinamento, all’articolo 420-ter del Codice di procedura penale, prevede già che ogni cittadino possa eludere un’udienza che lo riguarda in tre situazioni: caso fortuito, forza maggiore o legittimo impedimento.
Dunque, si può dare forfait qualora sussista un’assoluta impossibilità a presenziare. La legge sottoposta a referendum rivisita questa opzione già esistente, trasformando la funzione di Governo in una causa di legittimo impedimento. Una prima sforbiciata è arrivata lo scorso gennaio dalla Corte costituzionale: mentre per qualsiasi cittadino deve essere il giudice a valutare e dichiarare legittimo il motivo avallato per l’assenza, originariamente questa legge stabiliva che la presidenza del Consiglio (cioè la diretta interessata) potesse autocertificare l’esistenza di impegni istituzionali.
La Corte ha bocciato l’autocertificazione di Palazzo Chigi, dichiarando che deve essere sempre e solo il giudice a valutare, di volta in volta, l’intoppo ed eventualmente respingerlo, imponendo la prosecuzione del dibattimento.
Perché SI
Per stabilire democraticamente che tutti i cittadini sono davvero uguali davanti alla legge e che non esistono zone di privilegio, nell’ordinamento giuridico italiano, a favore degli uomini politici. «A ben guardare, il referendum incarna ormai, dopo l’intervento della Corte costituzionale, più un valore simbolico che un significato tecnico-giuridico», commenta Enrico Grosso, docente di Diritto costituzionale all’Università di Torino. «Il quesito era stato proposto dall’Idv di Antonio Di Pietro prima che la Corte intervenisse dichiarando la legge parzialmente illegittima». Dopo la sentenza dello scorso gennaio, la legge ha perso gran parte dei suoi effetti pratici su specifici processi attualmente in corso, pur continuando a designare l’attività politica di alcune cariche al Governo come un legittimo impedimento. Se dunque l’interpretazione della Corte costituzionale ha svuotato la legge di gran parte del senso e dello scopo che aveva originariamente, al di là dell’aspetto tecnico rimane il valore politico del referendum. «In questo senso, viene chiesto agli italiani di votare Sì o No all’idea che la politica possa pretendere per sé stessa privilegi giudiziari negati ai comuni cittadini», interpreta Grosso. «La vera domanda posta agli elettori è se sia giusto che una legge istituisca per i politici uno statuto differenziato nel rapporto con il potere giudiziario: voterà Sì chi ritiene importante quel principio-cardine del costituzionalismo moderno che pretende, come teorizzavano già alcuni grandi padri delle rivoluzioni settecentesche in America e in Francia, che qualsiasi potere pubblico, anche se democraticamente legittimato, debba essere soggetto a limiti e contrappesi che ne impediscano la sfrenatezza. Il referendum si è trasformato in una scelta tra due opposte visioni dei rapporti tra istituzioni».
Perché NO
Per permettere al premier e ai suoi ministri di svolgere serenamente le loro funzioni. Queste parole si trovano in una sentenza del 2004, con cui la Corte costituzionale aveva annullato il lodo Schifani, che prevedeva la sospensione generalizzata dei processi per le alte cariche dello Stato. Pur ritenendo che la “tregua” violasse l’interesse ad avere un processo penale rapido ed efficiente, «la Corte non ritenne del tutto infondata l’esigenza di assicurare un trattamento differenziato ai titolari degli organi più importanti per permettere loro un sereno esercizio della funzione di Governo», ricorda Agatino Cariola, ordinario di Diritto costituzionale all’Università di Catania.
Su queste basi era nato il lodo Alfano (Legge 124/2008), che prevedeva la sospensione dei processi per il presidente della Repubblica, i presidenti delle Camere e il presidente del Consiglio dei ministri. «Anche questa disciplina è stata dichiarata incostituzionale dalla Corte, questa volta con un ragionamento più completo, basato più che sul principio di uguaglianza in quanto tale, sul fatto che la disciplina era stata introdotta con legge ordinaria, anziché con procedimento di revisione costituzionale».
Ultima della lista, anche la legge oggetto del referendum è venuta al giudizio della Corte, che – nonostante la potatura – non ha escluso che il presidente del Consiglio e i ministri possano accampare un legittimo impedimento, a patto che sia il giudice a decidere. «La Corte ha chiesto al giudice di valutare in concreto l’impedimento, mantenendosi entro i confini della funzione giurisdizionale». Dopo l’intervento della Corte non si tratta più di assicurare serenità ai titolari delle cariche di Governo, quanto di garantire efficacia all’azione pubblica, cioè all’attività dell’esecutivo.