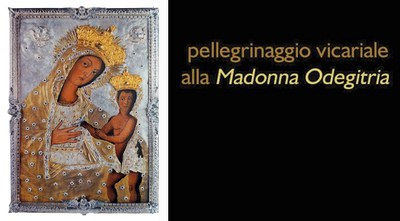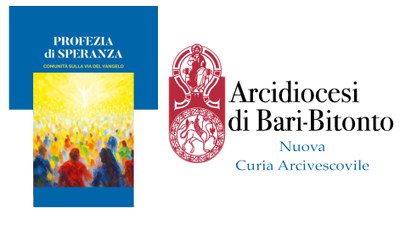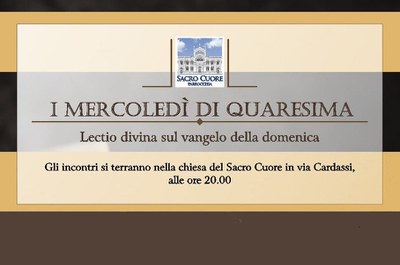Ricominciare
 Il cardinale Angelo Bagnasco, nell’aprire ieri la riflessione comune dei vescovi italiani riuniti in Assemblea generale, si è rivolto senza esitazioni «al cittadino nostro fratello (...) interlocutore amato e cercato» che è incalzato e quasi schiacciato da «una crisi epocale» che impone di trovare lo slancio per rispondere con «un cambiamento altrettanto epocale», che investa «modelli di pensiero e stili di vita».
Il cardinale Angelo Bagnasco, nell’aprire ieri la riflessione comune dei vescovi italiani riuniti in Assemblea generale, si è rivolto senza esitazioni «al cittadino nostro fratello (...) interlocutore amato e cercato» che è incalzato e quasi schiacciato da «una crisi epocale» che impone di trovare lo slancio per rispondere con «un cambiamento altrettanto epocale», che investa «modelli di pensiero e stili di vita».
Cambiare, ridando il giusto posto alla grande «cultura dei legami» e a quella «del dono» che sono il nostro umanissimo, povero e grandioso antidoto ai risentimenti e alle violenze disgregatrici, quelle frutto di malvagità e follia e persino quelle frutto di eventi naturali. Cambiare, riconoscendo concretamente il rispetto, lo spazio e il ruolo che meritano sia alla famiglia fondata sul matrimonio e aperta a nuove vite sia a quella dimensione comunitaria, che accoglie e sviluppa persone e Stati, e deve essere recuperata con urgenza da un’Europa oggi palesemente senza radici, senza spinta e senza visione. Cambiare restituendo rispetto, spazio e ruolo anche al volontariato come «tirocinio di vita personale e iniziazione alla vita sociale». E puntando sul lavoro. Anzi sul «lavoro, lavoro, lavoro». Che è il vero nome della crescita economica, e le assicura un volto umano. Ce n’è bisogno, scandisce il cardinale, tanto quanto i sacrifici che abbiamo dovuto fare e ancora faremo. Ce n’è bisogno come secondo tempo del grave sforzo ricostituente e rinsavente che è oggi guidato con spirito di servizio – quello stesso spirito che dovrebbe contagiare anche partiti che si mostrano rischiosamente incerti – dal governo di Mario Monti. Uno sforzo che ci è piombato addosso quasi di colpo, ma in modo niente affatto imprevedibile e inatteso dopo gli anni del benessere, o meglio del consumismo, fondato sul debito. Ce n’è bisogno per la dignità di tutti e come risposta a un disagio che continua a crescere, in particolare tra i giovani.
In questo modo, il presidente della Cei si rivolge a ognuno di noi, nelle nostre distinte eppure complementari responsabilità. Parla a politici e imprenditori, banchieri e operai, giornalisti e sindacalisti, funzionari e magistrati, lavoratori, educatori e sacerdoti... Parla a noi, protagonisti e vittime di un tempo da vivere con coraggio, lucidità e tenace voglia di ricominciare nella complicata quotidianità e nella vita spirituale e di fede. Un tempo che ci sfida a «ricalibrare» noi stessi, le nostre diverse attività e attese, le regole dell’amministrare e del fare politica, il rapporto tra i palazzi del potere (tutti, ma proprio tutti) e l’uomo e la donna, il cittadino e la cittadina, l’equilibrio serio tra i diritti e i doveri. Un tempo che ci mette severamente alla prova: c’è da lottare controcorrente per rimettere in piedi, nel verso giusto, la scala dei «valori fondamentali e fondativi» e per capovolgere l’attuale devastante e antiumano trend delle scelte, delle false priorità e delle «ciniche speculazioni» che – ogni giorno di più – minacciano la vita delle singole persone e dei popoli.
Ricominciare e ricalibrare, insomma, la stessa «idea del vivere personale e collettivo».
Farlo proprio in questo tempo difficile, un tempo da affrontare non come persone sole (decise a chiudersi sempre più nella trincea dell’individualismo) e non sentendosi isolati, ma riscoprendo il senso e la forza che, appunto, provengono e quasi erompono dall’essere «comunità». Farlo nella certezza – come insegna Papa Benedetto, richiamandoci alla fede in Gesù, che è «fiducia nella fedeltà di Dio» – che c’è una «speranza affidabile» alla quale riferirsi e che ci sono uomini e donne di speranza con i quali condividere la fatica per ridare basi solide e giuste alla "città dell’uomo", che oggi più che mai è qui, dove si vive, eppure abbraccia l’intero pianeta.
L’uguaglianza – ci ricorda Bagnasco – è condizione della fraternità». Ricominciare e ricalibrare, significa anche ridarci misura. Morale senso del limite, contro ogni tipo di corruzione: dell’azione amministrativa, del buon diritto, della buona scienza, dello stile personale. Una misura esigente, che dev’essere ovviamente propria della testimonianza e delle «iniziative provvidenziali» di quanti, da cattolici, già agiscono o si propongono di agire nella sfera pubblica nel segno – come ha invocato il Papa – dell’«altruismo disinteressato». Niente di meno di questo si attende, e ormai pretende, anche il «cittadino nostro fratello».