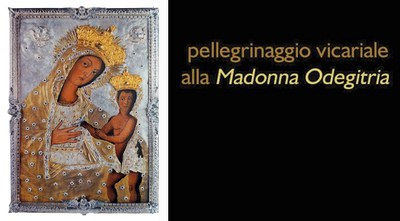Buio in sala Horror a merenda

Il mio primo incontro con la comicità è stato drammatico. Abitavo a Napoli, in via Crispi, e lì vicino, c’era un piccolo cinema di ultima visione, il cinema Amedeo. Quando ho cominciato a frequentarlo, nella prima metà degli anni Cinquanta, non andavo ancora a scuola. Ma quando fui iscritta alla prima elementare dell’Istituto Maria Ausiliatrice le mie frequenti sedute cinematografiche non diminuirono. I miei genitori erano entrambi appassionati di cinema. Mio padre in particolare amava il cinema americano, i western e i musical, e ogni tanto mi portava con sé a vedere questi film favolosi per colori, attori, scenari, musiche. Ma il più delle volte, con qualche tata o insieme a un altro gruppetto di ragazzini, venivo spedita al cinema Amedeo se c’era una programmazione adatta ai bambini.
Adatta ai bambini: così pensavano i miei genitori e gli altri adulti della famiglia e naturalmente i gestori della sala, che si riempiva effettivamente di schiamazzanti e ululanti risate infantili. Non le mie, no di certo. Io morivo di terrore o semplicemente di disagio. Tutti ridevano, io tremavo, oppure ero profondamente dispiaciuta da quanto vedevo sullo schermo. I film cui venivo regolarmente mandata per divertirmi e che regolarmente fallivano il loro obiettivo erano i film di Gianni e Pinotto. Non c’è da stupirsi che quel supplizio sia stato così denso e prolungato: dal 1940, quando esordiscono, fino al 1956, quando si rompe il loro sodalizio, Bud Abbott e Lou Costello girano trentasei film. Nel dopoguerra il ritmo è intensissimo, anche due film all’anno, e si specializzano in un genere che ha molto successo: la parodia dei film horror. Cioè la fonte dei miei dolori.
Quando ancora non sapevo né leggere né scrivere venivo spensieratamente spedita dai miei a vedere la parodia del Dottor Jekyll e Mister Hide, Dracula, Frankestein o La Mummia, tutti girati attorno al ’55. Può darsi che io fossi una ragazzina particolarmente impressionabile ma, ripensandoci, perché avrei dovuto prendere per parodie delle storie di cui non avevo visto il prototipo serio? Non sapevo allora che attori di veri horror, tipo Bela Lugosi e Lon Chaney, apparivano nel film scherzosamente: io non ne coglievo che l’aspetto terrificante come se stessi assistendo alla orrifica versione iniziale e in effetti – ricostruisco col senno di poi – se le situazioni erano comiche, tra equivoci sberleffi contrattempi e svelamenti, i travestimenti erano più o meno simili agli originali. Soprattutto una pellicola intitolata sinistramente Il cervello di Frankenstein mi gettò in uno stabile stato di terrore, e un personaggio in particolare: l’uomo-lupo. Ogni notte mi dedicavo ad accurate ricognizioni nella mia stanza per assicurami che non fosse nascosto sotto il letto o dentro l’armadio. Perché i miei genitori insistessero a mandarmi a vedere quei film rimane a tutt’oggi un mistero: credo che ci fosse un intento pedagogico che li caratterizzava anche in altre occasioni, l’idea cioè che dovessi superare le mie paure immotivate.
Quando nel ’56 Gianni e Pinotto, travolti dai guai personali e pubblici (c’era poco da ridere: divorzi, malattie, condanne per evasione fiscale) si separarono, per me non fu comunque un sollievo. Stavamo infatti per trasferirci a Roma, dove i miei tormenti sarebbero continuati al Cinema dei Piccoli di Villa Borghese. Qui di scena erano Stanlio e Ollio: non c’erano più parodie di film dell’orrore ma, nelle comiche che il cinemino proiettava in continuazione, una serie di situazioni che ai miei occhi infantili incarnavano la quintessenza dell’infelicità umana. Non c’era azione che il ciccione e il secco intraprendessero che non finisse in un disastro. Se dipingevano una parete finivano invariabilmente a mollo nella vernice, se volevano salvare una fanciulla venivano scambiati per rapinatori, se aiutavano una vecchietta la polizia li inseguiva come pericolosi malviventi. Cadevano incessantemente dalle scale, dalle sedie, dalle finestre. Erano sgangheratamente, stralunatamente, esplosivamente sfortunati, e io ne ero tremendamente afflitta.
Se con Gianni e Pinotto il comico suscitava in me paura, le disgrazie di quei due eterni malcapitati di cui tutti crudelmente ridevano mi suggerivano penose considerazioni sull’ingiustizia umana, tanto più opprimenti perché non sapevo come articolarle. Devo aggiungere che sia nel caso di Gianni e Pinotto sia in quello di Stanlio e Ollio alle disavventure dei protagonisti si aggiungeva, incombente e angosciante, un fattore tecnico. Le pellicole che venivano proiettate in quelle sale erano residui e spettri di pellicole: rigate, crepate, saettanti di mille lucine in un ectoplasmatico bianco e nero trasformavano gli attori in fantasmi. Dalla saletta di Villa Borghese uscivo alla luce del giorno sempre come chi si sveglia da un incubo.
Dunque, dev’essere per queste premesse così minacciose che non ho mai amato la comicità che punta alla risata esplosiva, in cui, come si dice, ci si piega in due. Se mi capita non mi tiro indietro, ma non la vado a cercare. Più avanti negli anni ho capito che il comico che prediligo, quello che mi dà sollievo e fiducia nella vita, si presenta in quella forma particolare, sommessa e implicita, che muove al sorriso: insomma, se la partita si gioca tra la risata e il sorriso, faccio il tifo per il sorriso. Ovviamente parlo della commedia, di un certo tipo di commedia però, senza ammiccamenti e doppi e tripli sensi, e per spiegarmi porterò due esempi, uno cinematografico e uno letterario.
L’esempio cinematografico è un film del 2000, Il gusto degli altri, diretto e sceneggiato dalla francese Agnès Jaoui: la storia di un imprenditore ricco, affascinante, sprezzante ma anche annoiato dai suoi troppi privilegi, che si scontra con un mondo più povero e più semplice del suo e ne rimane catturato. Niente sentimentalismi: è l’ironia della vita che guida il racconto, gli ostacoli su cui inciampa e cade l’imprenditore superbo e accigliato sono i suoi raffinati pregiudizi, senza esagerazioni e senza estremismi.
La stessa pacatezza ironica – per venire all’esempio letterario – è la cifra di una autrice che si muove in un piccolo mondo di relazioni e abitudini quotidiane, l’inglese Barbara Pym, che nel 1977, solo tre anni prima della morte, fu scoperta (o riscoperta) da Philip Larkin. Benché fosse una donna colta e attiva, era vissuta e aveva scritto sempre un po’ in sordina fino a quando il celebre poeta connazionale la definì 'la scrittrice più sottovalutata del secolo', mettendola per questa via al centro dell’attenzione. Anche i suoi personaggi si muovono in un mondo in sordina: una libreria, un ufficio universitario, un negozio di antiquariato e molte canoniche di quei pastori anglicani che la letteratura inglese ha per secoli coltivato come inesauribile fonte di ricchezza narrativa. Miss Pym usa l’ironia come un grimaldello conoscitivo, ma non prende in giro nessuno: ironica è la luce in cui, discretamente, sono immerse le sue creature. C’è qualcosa ai suoi occhi di teneramente incongruo, o implicitamente buffo, nelle avventure e disavventure umane, e riconoscerlo non è l’ultima delle virtù. Le sue storie non fanno mai ridere, ma si leggono con un costante sorriso interiore che illumina e alleggerisce la realtà. Come se nei suoi libri fosse in azione una forma equa e solidale della comicità.