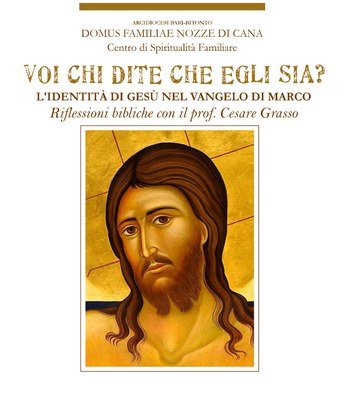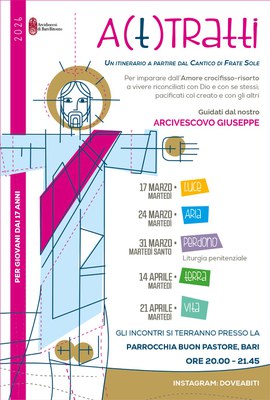VI Domenica del Tempo Ordinario anno B. La lebbra e la rabbia

La lebbra scomparve ed egli guarì
Sono già varie domeniche che s. Marco ci sta raccontando la guerra senza quartiere di Gesù contro il male, contro ogni specie di male; a favore dei malati, di ogni malato. Due domeniche fa', nel quadro della giornata di Cafarnao, abbiamo riletto la pagina della prima cacciata di uno spirito maligno da un povero indemoniato, e il messaggio era terso, trasparente: dove appare Gesù, si dissolve la potenza malefica che incancrenisce l’uomo.
Domenica scorsa abbiamo riascoltato la guarigione della suocera di Pietro, e poi - alla sera di quella prima giornata di missione a Cafarnao - ci è stata ricordata da s. Marco la guarigione di molti malati e la liberazione di molti posseduti da spiriti maligni: Gesù ci si conferma come colui che combatte e vince il male ovunque lo incontri. La conclusione che ne tira l’evangelista è lampante, e la troviamo fissata nel versetto immediatamente precedente al brano odierno: “E andò per tutta la Galilea, annunciando (il vangelo) nelle loro sinagoghe e scacciando i demoni” (Mc 1,39). Dunque nel DNA della missione di Gesù troviamo una struttura “a doppia elica” - analogamente alla scoperta di Watson e Crick nel 1953 - con due dimensioni che insieme stanno o insieme cadono: l’evangelizzazione e l’umanizzazione, intesa quest’ultima come la piena restituzione dell’uomo alla sua dignità e libertà.
1. Con il vangelo di oggi la lotta di Gesù contro il male registra un salto esponenziale: il malato ora è un povero lebbroso, potremmo dire un malato terminale, segnato dal morbo di Hansen, una malattia oggi curabile, ma, a quel tempo, terribile, impietosa, inesorabile. Il lebbroso infatti veniva considerato come un morto, un simbolo ambulante del male: la sua presenza rendeva “immondi”, inabili alla vita della comunità sacra, come avveniva per il contatto con un cadavere. Lo scrittore ebreo Giuseppe Flavio afferma che “i lebbrosi non erano in nulla diversi da un morto”. Anche un testo della comunità di Qumran, presso il Mar Morto, documenta bene questa mentalità: “Chiunque è colpito nella sua carne (=lebbroso) non entrerà nella congregazione di Dio”. Del resto, abbiamo sentito dalla 1ª lettura le terribili sanzioni stabilite dalla legge sui lebbrosi, costretti a portare vesti strappate e capo scoperto, a coprirsi la barba e a gridare: “immondo, immondo”, segni di lutto, rappresentanti di una situazione di morte, che imponeva all’impuro - in senso religioso e civile - di tenersi “fuori dell’accampamento”, lontano dal mondo dei viventi.
Ma vediamo ora, quasi al rallentatore, l’episodio della guarigione del lebbroso. Il racconto si articola in tre brevi segmenti: l’invocazione del malato, la risposta di Gesù, le conseguenze della guarigione prodigiosa.
L’approssimarsi dell’anonimo malato di lebbra viene introdotto dall’evangelista con un “allora venne a lui un lebbroso”. È un modo per Marco di agganciare questo episodio al versetto immediatamente precedente in cui veniamo a sapere che Gesù se ne andava annunciando il vangelo “in tutta la Galilea”. Così l’evangelista può spiegare ai lettori quel fatto strano e sconcertante: contro ogni tabù, il lebbroso può avvicinarsi al rabbi galileo perché perfino nel suo lazzaretto è giunta la buona notizia che Gesù andava in giro a “scacciare i demoni”; e quindi anche per lui, costretto a vivere fuori del villaggio, il Maestro poteva offrire una speranza di guarigione. È da sottolineare anche il fatto che per la prima volta s. Marco riporta le esplicite parole di richiesta da parte del malato per ottenere la guarigione. Il lebbroso supplica Gesù “in ginocchio”, e lo fa con quella invocazione ardente che vale un intero trattato sulla fede: “Se vuoi, puoi guarirmi”.
Alla supplica umile e fiduciosa del lebbroso, Gesù reagisce innanzitutto con un sentimento: la compassione. La parola ebraica soggiacente indica lo smuoversi delle viscere materne, e sta ad esprimere l’amore appassionato - appunto, viscerale - di Dio nei confronti dell’uomo. Il Signore si commuove davanti al nostro male, perché è Dio e non uomo (cfr. Os 11,9), proprio come freme di commozione una mamma che non può “non commuoversi per il frutto delle sue viscere” (Is 49,15). “La compassione, cioè, etimologicamente, soffrire con l’altro, ha un senso etico. È la cosa che ha più senso nell’ordine del mondo” (E. Lévinas). Nel fatto che ora questa compassione tenerissima di Dio abbia per organo il cuore umanissimo di Gesù e per oggetto un lebbroso - condannato dalla legge di Israele alla morte civile e religiosa - si misura tutta la differenza tra l’Antico e il Nuovo Testamento, e si registra il passaggio dalla legge alla grazia. È interessante però notare che in alcuni manoscritti di origine occidentale, al posto di “mosso a compassione”, si legga “adirato”, il che starebbe a sottolineare l’insofferenza di Gesù - annunciatore del Regno di Dio - contro i mali e contro la morte, che tengono l’uomo schiavo e segregato dalla comunità. La malattia - grazie a Gesù - non è più luogo di separazione, ma diventa spazio di incontro.
2. Il sentimento dell’amore, mentre traduce la rabbia del Figlio di Dio in fremito contro il male, declina la sua compassione in tenerezza a favore del malato. Di fatti Gesù stese la mano: il tendere la mano ricorda l’azione di Dio che, mosso a compassione per il suo popolo, schiavo in Egitto, ha compiuto i prodigi dell’esodo “con braccio forte e mano tesa”. Ma la mano di Gesù non si arresta a qualche centimetro dalle piaghe purulente del lebbroso, ma “lo tocca” con commovente tenerezza e con intenzione apertamente polemica nei confronti di scribi e farisei, sempre pronti a gridare allo scandalo. Il Maestro non si pone a rispettosa distanza di sicurezza in una blindata cabina di regia, non innalza barriere tra sé e gli infermi o gli indemoniati, e non agisce per delega o per conto terzi, ma si espone fisicamente al contagio del nostro male. Così proprio il nostro male diventa il punto di contatto: lui, Gesù, prende da noi la nostra umanità malata e noi prendiamo da lui la sua umanità sana e risanante. Cristo è davvero in tutto e per tutto il Servo sofferente che prende e porta su di sé le nostre infermità, come si legge nel rotolo di Isaia: “Noi lo giudicavamo percosso da Dio e umiliato” (53,4), una espressione che nella traduzione latina veniva resa con: “Noi lo giudicavamo come un lebbroso (quasi leprosum)”.
Sorprendente - è il terzo elemento - la conclusione del miracolo: il lebbroso è stato reintegrato nella società, ma Gesù, lui che non ha avuto paura di avvicinarsi agli intoccabili, si costringe a starsene fuori “in luoghi deserti”. Questo è il “prezzo” che egli deve pagare per reinserire l’ex-lebbroso “nel villaggio”. Mentre lui finisce per trovarsi nella stessa situazione del lebbroso, prima della guarigione, il lebbroso guarito comincia a “proclamare e a divulgare il fatto”. Vale la pena ricordare che “proclamare” è il verbo della evangelizzazione. Si verifica quindi uno scambio delle parti: mentre l’Evangelizzatore per eccellenza si è dovuto isolare - “al punto che non poteva entrare pubblicamente in una città” - il lebbroso risanato si è potuto reinserire nella “città” ed è diventato, oltre che un uomo guarito, un missionario, in un certo senso, un vero evangelizzatore.
3. Ancora una volta il vangelo ci parla di Gesù e ci parla di noi.
Di Gesù ci dice cosa fa Dio di fronte al nostro male: si cala personalmente nel nostro inferno e non viene per organizzare una marcia di protesta contro il sistema; non viene a tenere un corso di filosofia sul dolore umano. Certo, non viene neanche ad eliminare completamente la sofferenza e la morte, ma viene a incontrare gli emarginati e gli oppressi; viene a prendere il loro giogo su di sé e a farne il luogo per manifestare l’amore del Padre per i piccoli e i poveri, per gli ammalati e gli esclusi. Cristo combatte il male, accogliendo la miseria degli altri e accettando di prendere su di sé la sofferenza di tutti. Non elimina la morte, manifesta l’amore; non spiega il dolore, lo riscatta dall’assurdo.
Di noi questo vangelo ci dice che siamo veri discepoli di un Maestro così, a condizione che ci schieriamo in prima fila contro ogni tipo di emarginazione. Di nessuno - extracomunitario o malato, depresso o disperato, barbone o ignorante - possiamo dire: “Non merita neanche che io lo sfiori e non mi deve neppure toccare”. Quante volte invece noi cristiani ci comportiamo proprio così: magari ammiriamo le suore di madre Teresa e, quando alla televisione vediamo la gente che muore di fame o di freddo, ci commuoviamo pure, ma poi non ci muoviamo neanche di un passo. Come possiamo allora dirci discepoli di questo Gesù che si è fatto “lebbroso” per salvarci?
Commento di mons. Francesco Lambiasi
tratto da "Il pane della Domenica. Meditazioni sui vangeli festivi"
Ave, Roma 2008
Per il Video-Commento al Vangelo, clicca qui
Scarica il ritornello al Salmo Responsoriale, clicca qui
Scarica il modulo salmodico, clicca qui