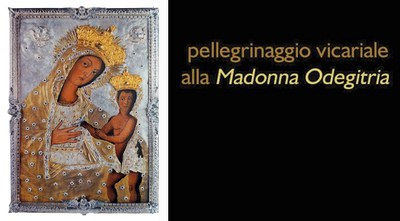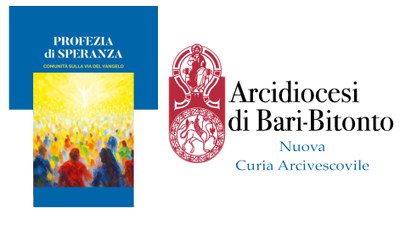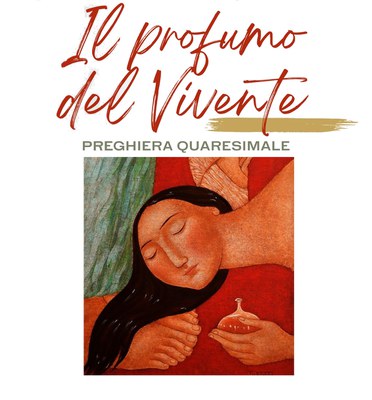Il denaro non deve governare

1. «L'economia attuale è antiumana»
 «Sarebbe auspicabile realizzare una riforma finanziaria che sia etica e che produca a sua volta una riforma economica salutare per tutti. Il denaro deve servire e non governare!». Sceglie l’incontro con gli ambasciatori di Kyrgyzstan, Antigua e Barbuda, Lussemburgo e Botswana presso la Santa Sede papa Francesco per il primo intervento del pontificato sulla crisi economica mondiale e le cause, a cominciare dalla speculazione finanziaria, che l’hanno innescata con conseguenze devastanti a livello sociale.
«Sarebbe auspicabile realizzare una riforma finanziaria che sia etica e che produca a sua volta una riforma economica salutare per tutti. Il denaro deve servire e non governare!». Sceglie l’incontro con gli ambasciatori di Kyrgyzstan, Antigua e Barbuda, Lussemburgo e Botswana presso la Santa Sede papa Francesco per il primo intervento del pontificato sulla crisi economica mondiale e le cause, a cominciare dalla speculazione finanziaria, che l’hanno innescata con conseguenze devastanti a livello sociale.
«La maggior parte degli uomini e delle donne del nostro tempo», ha detto Francesco, «continuano a vivere in una precarietà quotidiana con conseguenze funeste». E così, ha spiegato, «alcune patologie aumentano, con le loro conseguenze psicologiche, la paura e la disperazione prendono i cuori di numerose persone, anche nei paesi cosiddetti ricchi; la gioia di vivere va diminuendo; l'indecenza e la violenza sono in aumento; la povertà diventa più evidente. Si deve lottare per vivere, e spesso per vivere in modo non dignitoso».
Nel mirino del Papa ci sono gli idoli del nostro tempo: avidità e sfruttamento, la finanza senza regole, un capitalismo consumistico che cerca solo il profitto e distrugge ogni rete di solidarietà sociale, l’uomo ridotto a merce. «Una delle cause di questa situazione, a mio parere, sta nel rapporto che abbiamo con il denaro, nell’accettare il suo dominio su di noi e sulle nostre società», ha detto Bergoglio, «così la crisi finanziaria che stiamo attraversando ci fa dimenticare la sua prima origine, situata in una profonda crisi antropologica. Nella negazione del primato dell’uomo! Abbiamo creato nuovi idoli. L’adorazione dell’antico vitello d’oro (cfr Es 32,15-34) ha trovato una nuova e spietata immagine nel feticismo del denaro e nella dittatura dell’economia senza volto né scopo realmente umano. La crisi mondiale che tocca la finanza e l’economia sembra mettere in luce le loro deformità e soprattutto la grave carenza della loro prospettiva antropologica, che riduce l’uomo a una sola delle sue esigenze: il consumo. E peggio ancora, oggi l’essere umano è considerato egli stesso come un bene di consumo che si può usare e poi gettare».
Nel suo discorso il Papa ha tuonato anche contro la corruzione e l’evasione fiscale. «C'è», ha detto, una corruzione tentacolare e una evasione fiscale egoista che hanno assunto dimensioni mondiali, la volontà di potenza e di possesso è diventata senza limiti». Senza solidarietà, ha concluso, non si esce da questa spirale drammatica dove i ricchi diventano sempre più ricchi e i poveri sempre più poveri. «Il Papa ama tutti, ricchi e poveri ma ha il dovere, in nome di Cristo, di ricordare al ricco che deve aiutare il povero, rispettarlo, promuoverlo», ha detto, soffermandosi sugli squilibri a livello mondiale: «Mentre il reddito di una minoranza cresce in maniera esponenziale, quello della maggioranza si indebolisce. Questo squilibrio deriva da ideologie che promuovono l’autonomia assoluta dei mercati e la speculazione finanziaria, negando così il diritto di controllo agli Stati pur incaricati di provvedere al bene comune. Si instaura una nuova tirannia invisibile, a volte virtuale, che impone unilateralmente e senza rimedio possibile le sue leggi e le sue regole».
Alla Chiesa non servono i cristiani da salotto - Giovedì mattina nella messa celebrata nella Domus Santa Marta Francesco ha sferrato un duro attacco nei confronti dei cristiani «da salotto», «educati», ma senza «fervore apostolico». Per il Papa la testimonianza dei cristiani, tutti non solo i missionari, deve invece essere incisiva e forte: «Se diamo fastidio, benedetto sia il Signore. Avanti, come dice il Signore a Paolo: "Coraggio"».
L’esempio secondo il Papa è da ricercare in San Paolo: «Paolo», ha detto, «dà fastidio: è un uomo che con la sua predica, con il suo lavoro, con il suo atteggiamento dà fastidio, perché proprio annunzia Gesù Cristo e l’annunzio di Gesù Cristo alle nostre comodità, tante volte alle nostre strutture comode – anche cristiane, no? – dà fastidio. Il Signore sempre vuole che noi andiamo più avanti, più avanti, più avanti… Che noi non ci rifugiamo in una vita tranquilla o nelle strutture caduche, queste cose, no? Il Signore… E Paolo, predicando il Signore, dava fastidio. Ma lui andava avanti, perché lui aveva in sé quell’atteggiamento tanto cristiano che è lo zelo apostolico. Aveva proprio il fervore apostolico. Non era un uomo di compromesso. No! La verità: avanti! L’annunzio di Gesù Cristo: avanti!».
Antonio Sanfrancesco
2. Denaro, finanza e sviluppo secondo il cardinale Bergoglio
 «La concezione magica dello Stato, la dilapidazione del denaro del popolo, il liberalismo estremo mediante la tirannia del mercato, l’evasione fiscale, la mancanza di rispetto della legge tanto nella sua osservanza quanto nel modo di dettarla e applicarla, la perdita del senso del lavoro». E soprattutto «una corruzione generalizzata che mina la coesione della nazione e ci toglie prestigio davanti al mondo. Questa è la diagnosi». Nel libro intervista di Gianni Valente (Francesco, un papa dalla fine del mondo, Emi) il futuro papa Jorge Mario Bergoglio elenca i mali morali che hanno portato alla bancarotta dell’Argentina, la cui fase parossistica si verificò soprattutto tra il 1999 e finì il 2002 con il ritorno alla crescita del Pil.
«La concezione magica dello Stato, la dilapidazione del denaro del popolo, il liberalismo estremo mediante la tirannia del mercato, l’evasione fiscale, la mancanza di rispetto della legge tanto nella sua osservanza quanto nel modo di dettarla e applicarla, la perdita del senso del lavoro». E soprattutto «una corruzione generalizzata che mina la coesione della nazione e ci toglie prestigio davanti al mondo. Questa è la diagnosi». Nel libro intervista di Gianni Valente (Francesco, un papa dalla fine del mondo, Emi) il futuro papa Jorge Mario Bergoglio elenca i mali morali che hanno portato alla bancarotta dell’Argentina, la cui fase parossistica si verificò soprattutto tra il 1999 e finì il 2002 con il ritorno alla crescita del Pil.
Bergoglio adoperò l’immagine dei genitori delle Villas Miseria che di notte attendevano che i figli dormissero per piangere sulle proprie sciagure. Avvenne nei giorni della bancarotta. Perché il default dello Stato argentino rappresentò uno dei momenti peggiori della sua storia. Le sue onde sismiche temporali di quel terremoto finanziario risalgono a epicentri storici molto più antichi, dalle dittature militari ai debolissimi governi democratici, vere e proprie Repubbliche di Weimer sudamericane, a cominciare da quello del presidente Raùl Alfonsin. Le politiche dittatoriali o fragili e corrotte portarono alla crescita del debito pubblico, accumulato soprattutto dopo la guerra delle Falkland. Furono questi i prodromi di una crisi economica devastante. Quando il governo si rivelò incapace di remunerare il debito, l’inflazione si impennò e andò fuori controllo, raggiungendo il tasso mensile del 200 per cento, fino al 5 mila per cento del luglio 1989. In molte città del grande Paese scoppiarono numerose rivolte popolari.
Nel 1989 il liberista filo americano Carlos Menem, succeduto ad Alfonsin, dichiarò guerra all’inflazione e stabilizzò la moneta nazionale agganciando l’austral, la moneta che aveva sostituito il peso al dollaro, con un cambio fisso. Tutto ciò ebbe effetti positivi per gli argentini, che poterono di nuovo viaggiare all’estero, acquistare beni d’importazione e chiedere crediti in dollari a tassi agevolati.
Ma la montagna del debito pubblico continuava a incombere. Solo i prestiti concessi dal Fondo Monetario Internazionale impediva che esplodesse. Nel 1999, il neo eletto presidente Fernando de la Rúa (liberista come Menem e accusato di aver venduto per quattro soldi le imprese agli americani) prese in mano un Paese dove la disoccupazione era ormai a livelli critici e gli effetti negativi del tasso di cambio fisso erano ben evidenti. L’Argentina entrò in una recessione che divenne ben presto stagnazione. Al posto del peso, si utilizzavano valute complementari; la più forte di esse era il Patacón, emesso dalla provincia di Buenos Aires.
La fuga di capitali aumentò. Nel 2001 la gente iniziò a temere il peggio e a ritirare grosse somme di denaro dai propri conti correnti convertendo pesos in dollari e mandandoli all'estero. Il governo adottò una serie di misure (note come corralito) che congelarono effettivamente tutti i conti bancari per dodici mesi, permettendo unicamente prelievi di piccole somme di denaro.
Il corralito esasperò il popolo argentino che si riversò nelle strade di Buenos Aires. Si svilupparono proteste popolari, come il cacerolazo, che consistevano nel percuotere rumorosamente pentole e padelle. Queste proteste andarono avanti fino al 2002 e finirono per diventare “espropri proletari”. Gli scontri fra i locali e la polizia divennero una consuetudine, così come gli incendi appiccati nelle strade di Buenos Aires, messa a ferro e fuoco. De la Rúa abbandonò la Casa Rosada in elicottero il 21 dicembre 2001 portandosi dietro una sorta di “damnatio memoriae” per la sua inconsistenza e incapacità.
Durante l’ultima settimana del 2001, il governo ad interim guidato da Rodríguez Saá, di fronte all’impossibilità di ripagare il debito, completamente incapace di affrontare la crisi, dichiarò lo stato di default sulla maggior parte del debito pubblico. Al suo posto arrivò alla Casa Rosada Eduardo Duhalde, un senatore molto noto di Buenos Aires, che aveva la fama di risanatore negli incarichi che aveva ricoperto.
Duhalde lasciò fluttuare il cambio con il peso spingendo in su l’inflazione fino all’80 per cento. Molte imprese chiusero o fallirono, molti prodotti importati divennero praticamente inaccessibili ed i salari furono congelati. I conti correnti in dollari furono convertiti in pesos a meno della metà del loro valore. Fu quella l’epoca dei cartoneros, i raccoglitori di cartone che vagavano per le strade di Buenos Aires per raggranellare qualche peso. uno dei tanti metodi che si utilizzavano in Argentina per far fronte ad un tasso di disoccupazione che era salito fino al 25 per cento. Ma la cura da cavallo cominciò a funzionare.
Eduardo Duhalde, dopo essere riuscito a stabilizzare la situazione, chiamò il popolo alle urne, vinte da Néstor Kirchner, che continuò a tenere quello che era considerato l’artefice della ripresa, Roberto Lavagna, il ministro dell'economia nominato da Duhalde. Il Paese cominciava a respirare. Anche perché la prospettiva economica era del tutto differente da quella degli anni novanta; il peso debole aveva reso le esportazioni argentine economiche e competitive all'estero ed aveva scoraggiato le importazioni. Inoltre, l’alto prezzo della soia sui mercati internazionali causò un grande afflusso di valuta estera.
Il governo incoraggiò la produzione locale e prestiti accessibili per le imprese, organizzò un piano ambizioso per aumentare il gettito fiscale e destinò una grande quantità di finanziamenti ai servizi sociali controllando la spesa in altri campi. Il peso, intanto, si rivalutò lentamente e l’industria a poco a poco trovò nuovi spazi anche attraverso le cooperative dei lavoratori che erano stati licenziati.
L’Argentina riuscì a tornare alla crescita economica con grande forza; il Pil aumentò a ritmi superiori dell’8 per cento, fino a toccare il 15 per cento nel 2007. Ma rimase sul campo tanta miseria, e soprattutto una diseguaglianza di fondo nella distribuzione dei redditi: il 10 per cento più ricco della popolazione argentina dispone di un reddito 31 volte superiore a quello più povero. Il nuovo presidente Cristina Kirchner, che aveva preso il posto dello scomparso marito Nestor, candidandosi alla testa del partito peronista fondato dal marito, annunciò un piano di pagamento ai creditori, basato su forti sconti, molto criticato dal Fondo Monetario Internazionale. Poi annunciò che il suo Paese avrebbe saldato, come il Brasile, il debito con l’Fmi. Ma la terapia funzionò e l’Argentina si sentì in quegli anni fuori dall’incubo.
L’Argentina ripagò il debito con le riserve di valuta estera della banca centrale. Anche se il Fondo Monetario di madame Christine Lagarde continua ad accusarla di truccare i dati macroeconomici, come avvenne oltre dieci anni fa. Ma la pasionaria peronista amica di Fidel Castro e Chavez ha risposto dando degli usurai ai vertici del Fondo. In questi ultimi mesi però anche gli argentini cominciano a sentire puzza d’imbroglio. I rincari hanno ripreso a galoppare. La disoccupazione aumenta. E così da settembre sono tornati in piazza con pentole e cucchiai.
Francesco Anfossi
3. Il fondatore della moderna finanza? San Francesco
 E’ ancora presto per un’enciclica sociale del nuovo Papa. Ma i primi segnali già ci sono. Giorno dopo giorno, papa Francesco aggiunge una tessera del mosaico della dottrina della Chiesa legata alla nuova epoca della globalizzazione. Lo fa con molta coerenza rispetto alla sua esperienza di vescovo e cardinale. Quando l’arcivescovo di Buenos Aires Jorge Mario Bergoglio ha scelto il nome del santo di Assisi per il suo pontificato, pensava a “una Chiesa povera per i poveri”, ma, da fine intellettuale e da buon gesuita, la sua scelta si riferiva anche ad una visione teologica, filosofica e sociale.
E’ ancora presto per un’enciclica sociale del nuovo Papa. Ma i primi segnali già ci sono. Giorno dopo giorno, papa Francesco aggiunge una tessera del mosaico della dottrina della Chiesa legata alla nuova epoca della globalizzazione. Lo fa con molta coerenza rispetto alla sua esperienza di vescovo e cardinale. Quando l’arcivescovo di Buenos Aires Jorge Mario Bergoglio ha scelto il nome del santo di Assisi per il suo pontificato, pensava a “una Chiesa povera per i poveri”, ma, da fine intellettuale e da buon gesuita, la sua scelta si riferiva anche ad una visione teologica, filosofica e sociale.
Non tutti sanno che i francescani, nel medioevo, fondarono le basi della finanza moderna. Con i francescani è praticamente nata l’economia di mercato, frutto maturo della scuola di pensiero di Bonaventura di Bagnoregio e altri filosofi. Pensiamo ai Monti di Pietà, da loro fondati nell’ambito della lotta all’usura. Ma anche i principali strumenti contabili nascono in ambito francescano. La partita doppia è stata perfezionata da Luca Pacioni, collaboratore di Leonardo da Vinci. La povertà dei francescani era libertà e distacco dalle cose materiali, ma significava anche lotta alla miseria che è la mancanza di sostentamento e dignità. “Quando San Francesco, di fronte al vescovo attonito si spoglia e rimane nudo lo fa perché si sente finalmente libero. Ma ai suoi confratelli raccomanda di tenere sempre nella madia pane e formaggio per i poveri che bussano alla porta del convento”. Chi conosce il nuovo pontefice fin dai tempi in cui era arcivescovo di Buenos Aires è l’economista Stefano Zamagni, padre degli studi sul Terzo Settore e studioso di economia francescana, che ha svolto lunghi soggiorni presso l’Università Cattolica della capitale argentina. “Il Papa dovrà scegliere il modello di economia di mercato più consono alla Chiesa e alla redistribuzione equa delle risorse economiche” afferma l’economista bolognese. “Benedetto XVI aveva già scelto chiaramente nella Caritas in Veritate la terza via: l’economia civile di mercato”. Il dilemma, per Zamagni, è tutt’altro che semplice: “Si tratta di stabilire se si ritiene che la dottrina sociale della Chiesa debba limitarsi ai problemi della giustizia - e quindi alla sfera della distribuzione del reddito e della ricchezza - oppure se si pensa che ci si debba occupare anche della ricchezza e del reddito. Noi sappiamo che, a partire da Leone XIII fino a Giovanni Paolo II, la prevalenza è stata sul primo momento, il momento della distruibuzione: la giusta mercede all’operaio, ai più deboli, la lotta alle disegueglianze. Il papa tedesco aveva inaugurato un’altra stagione per il pensiero cristiano: la sfera della produzione. Perché è durante la produzione che si possono commettere le ingiustizie più grandi. Se l’acqua è inquinata, bisogna intervenire sulla sorgente. Per troppo tempo la dottrina sociale della Chiesa si è occupata di distribuzione (con la sacrosanta attenzione ai poveri, a chi meno ha) dimenticando le fasi della produzione della ricchezza. Ma se io mi occupo della condizioni di vita e non delle capacità di vita non rendo giustizia alla dignità dell’uomo e giungo a rendere sterile il pensiero economico”.
Francesco Anfossi
© Famiglia Cristiana, 16 maggio 2013