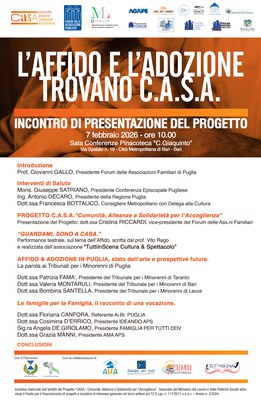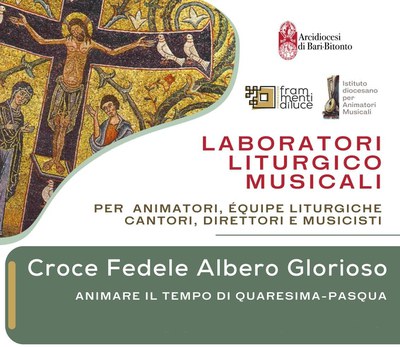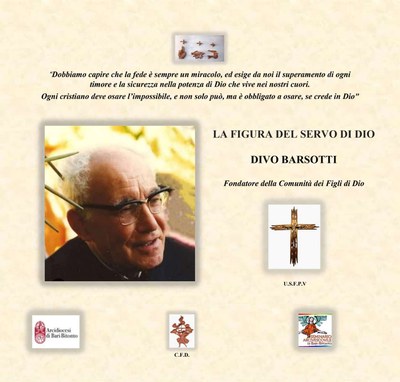La fede nella Rete delle relazioni: comunione e connessione
Guido Gili, Docente di sociologia dei processi culturali e comunicativi, Università del Molise23 aprile 2010
Vorrei partire da una breve premessa per tracciare la cornice di questo intervento. E’ una osservazione che ricavo dalle prime pagine di un recente bel saggio del sociologo della religione Peter Berger, intitolato Questioni di fede. Sebbene con profonde differenze, le condizioni della fede oggi assomigliano a quelle dei primi cristiani che vivevano nel mondo greco-romano, un contesto sociale e culturale caratterizzato da un vivace pluralismo, per cui la fede era possibile solo come scelta deliberata. Sotto questo aspetto la nostra situazione è simile a quella di Paolo, quando predicava nell’agorà di Atene, dove una moltitudine di dèi convivevano e competevano tra loro. Quindi, per certi aspetti, siamo diventati o siamo tornati, contemporanei dei primi cristiani.
Pur nella similitudine, c’è però qualcosa di specifico nella situazione attuale ed è che la modernità, di cui tutti siamo figli, “mina progressivamente l’ambiente sociale in cui la religione e qualsiasi altra cosa nella quale le persone credono sono date per scontate”. Le persone normalmente danno per scontate le loro credenze nella misura in cui ciascuno intorno a loro fa lo stesso. In altri termini, “le credenze appaiono auto-evidenti se intorno ad esse c’è un consenso sociale più o meno omogeneo”. La modernità mina questo consenso, per cui “l’individuo è spinto a confrontarsi in maniera crescente con credenze, valori, stili di vita assai differenti ed è perciò costretto a scegliere tra di essi”. Questo vale anche per la fede cristiana, che non è più assimilata – o molto meno che in passato – come parte dell’ambiente culturale e dell’ethos condiviso, ma torna ad essere di nuovo una questione personale, una questione di adesione personale.
Ora noi sappiamo che l’annuncio di Cristo si inserisce sempre in un contesto spazio-temporale, psicologico, sociale e culturale specifico, interpella e incontra gli uomini nelle loro condizioni storiche e concrete. “In quel tempo” si scandisce sempre all’inizio di ogni episodio evangelico, così come “in questo tempo” noi dobbiamo pensare alle condizioni della fede e della comunicazione della fede oggi.
Questo tempo è stato definito in vari modi, ma sicuramente un tratto assolutamente centrale, determinante nella sua definizione è l’importanza che vi hanno assunto le nuove tecnologie della comunicazione tanto che possiamo dire che ambiente sociale e ambiente mediale costituiscono le due facce, le due dimensioni di una stessa realtà. E le nostre relazioni hanno sempre questi due caratteri, per cui le relazioni della vita quotidiana si intrecciano e si compenetrano con le relazioni che creiamo e manteniamo attraverso i media.
L’ambiente mediale che caratterizza questo tempo è una realtà complessa e, come abbiamo visto in questi giorni può essere rappresentato in vari modi, anche contrastanti, e ogni rappresentazione illumina alcuni aspetti, alcuni caratteri di questo ambiente.
Vorrei dunque in questo intervento riflettere su queste diverse rappresentazioni e cercare di capire quali implicazioni e quali indicazioni è possibile trarre per la presenza della Chiesa in questo ambiente mediatico e per l’azione di tutti coloro che in questo ambiente assumono una responsabilità personale.
1. Una prima immagine con cui si rappresenta l’ambiente mediatico e la rete di relazioni comunicative che lo caratterizza, soprattutto con l’avvento e lo sviluppo dei cosiddetti media interattivi e partecipativi, è quella della “piazza” o dell’agorà (cioè l’immagine per eccellenza dello spazio pubblico). Nell’immagine della piazza sono presenti tre aspetti:
a) Innanzitutto la piazza esprime l’idea di uno spazio libero e “aperto” nel quale sono possibili i più diversi incontri, è il luogo di incontri molteplici e solo in parte predeterminati e predeterminabili. Vi si può incontrare chiunque, chi si conosce bene e a cui si è legati da forti relazioni, chi si conosce appena, e anche gli sconosciuti (anche se, seguendo questa metafora, va detto che anche nelle piazze vi sono relazioni preferenziali tra gruppi e gruppetti già costituiti).
b) In secondo luogo la piazza è uno spazio “pubblico” dove si parla e si discute, in cui l’opinione “privata”, personale, può essere espressa, scambiata, condivisa, paragonata con quella degli altri. E’ quindi il luogo in cui trovano spazio tutte le opinioni senza particolari gerarchie o priorità, senza che nessuna possa arrogare per sé un primato, che non emerga dalla discussione e dal confronto. Tutte sono poste potenzialmente sullo stesso piano. Si esprime qui anche la dimensione politica della “sfera pubblica mediata” come luogo di confronto e aggregazione democratica.
c) Infine, spesso nelle nostre rappresentazioni, la piazza è contrapposta al palazzo: è il luogo delle relazioni orizzontali, circolari, e quindi questa metafora esprime l’idea che l’ambiente comunicativo veda il tramonto dei vecchi sistemi di relazioni comunicative centralizzate, uni-direzionali e a-simmetriche del passato, cioè le relazioni proprie dei tradizionali mass media, che rispondevano unicamente ai valori e agli interessi di chi ne deteneva la proprietà o il controllo.
Questa prima immagine dell’ambiente mediale è stata evocata in modo diretto o indiretto anche in questi giorni in vari interventi e si è espressa nell’invito alla Chiesa, alla comunità cristiana e ai singoli cristiani a “giocarsi”, a coinvolgersi entro queste relazioni orizzontali, dialogiche, discorsive, insomma in questo ambiente di relazioni che sembra ricordare da vicino l’Areopago di Atene, dove Paolo prese la parola. Quindi, secondo questa prima immagine, il sistema dei media si configura come un Nuovo Areopago e quindi chiede un atteggiamento che si ponga in una continuità ideale con quello di Paolo.
E tuttavia bisogna capire la reale natura della piazza, perché le metafore per certi aspetti aiutano a capire, ma a volte propongono semplificazioni fuorvianti. E’ una piazza particolare in cui, possiamo dire, coloro che vi camminano hanno una visione focalizzata, vedono solo ciò che è oggetto della loro attenzione selettiva. In questo senso la direzione della navigazione è sempre costruita a posteriori dal percorso del navigante, piuttosto che a priori dall’intenzione del comunicatore. Questo processo ha un carattere sicuramente positivo: significa che nella rete delle relazioni digitali è il fruitore a decidere, attraverso le sue scelte di navigazione, il percorso da compiere ed è quindi sempre il co-autore della comunicazione (Cantoni 2001). Ma ha anche una implicazione negativa: la predeterminazione di ogni incontro che si farà sulla piazza, perché l’esposizione e l’attenzione selettiva di coloro che vi si affacciano si dirige prevalentemente su ciò verso cui nutrono già un interesse e solo molto difficilmente è possibile entrare nel cono di luce della loro attenzione. “Raramente gli uomini apprendono ciò che già credono di sapere” osservava l’economista inglese Barbara Ward.
Questo aspetto, che è esattamente l’effetto contrario rispetto a quello della piazza aperta, contiene però un’indicazione: identifica come fondamentale l’aspetto della credibilità dell’emittente, cioè l’aspetto dell’apertura di fiducia che il ricevente è disposto ad attribuirgli prima ancora di impegnarsi in una relazione con lui. Perché se non c’è questa credibilità anticipata, questa aspettativa positiva, che apre alla relazione, in realtà la possibilità di incontro come sorpresa, come possibilità non predeterminata, come “incontro” nel senso forte del termine non avviene. Una volta entrati in un rapporto è possibile indirizzare o accompagnare l’altro su dei percorsi, suggerirgli dei percorsi, altri incontri, ma se non c’è questo incontro iniziale, gli altri prendono tutt’altre strade.
2. Accanto a questa prima immagine ce ne sono altre due altrettanto significative ed “esplicative”, che ricavo dall’ultima opera Mediapolis di Roger Silverstone, un grande studioso di media recentemente scomparso.
La prima è quella dell’ambiente mediale come “lo spazio della cacofonia”, come uno spazio aperto, ma proprio perché aperto, sempre più caotico e frammentato, soggetto alla più grande confusione. In questo spazio c’è di tutto e di più. E’ lo spazio di una pluralità di voci disordinate e casuali, che si susseguono e si sovrappongono, voci invasive, disturbanti o seduttive, che urlano o sussurrano, che adescano, che ingannano. Ma anche voci contraffatte, come ad esempio nel caso di molti blog che si fingono indipendenti e amatoriali e in realtà sono al servizio di imprese, governi o gruppi politici (Gaggi, Bardazzi, L’ultima notizia). E’ insomma il luogo delle dissonanze, della confusione, del rumore. Questa immagine ripropone e amplia l’idea di alluvione o inflazione comunicativa che era stata introdotta qualche tempo fa e all’esperienza soggettiva di un bombardamento continuo e caotico di messaggi, suggestioni, slogan. E’ ancora Silverstone che ne descrive bene alcuni caratteri: la spettacolarizzazione dell’io, la commercializzazione ossessiva, la richiesta continua di aver fiducia e di credere in ciò che viene proposto, il crollo delle distanze e delle differenze, la confusione e la commistione di pubblico e privato, la perdita del rispetto della privacy, la volgarizzazione di ciò che è serio e la legittimazione di ciò che è banale, lo sfruttamento di chi è debole e vulnerabile, l’erosione dei confini tra reale e immaginario, tra realtà e la finzione, tra notizia e intrattenimento.
Secondo questa immagine, il sistema dei media attuale realizza pienamente e praticamente uno dei caratteri propri della modernità: il relativismo dei valori e degli stili di vita. Da questo punto di vista, infatti, il sistema dei media – in particolare la televisione e Internet – costituiscono l’esempio più eclatante di relativismo applicato. Il relativismo della TV o di Internet non è un fatto filosofico o teoretico, ma un è un fatto eminentemente pratico, pragmatico. Tutti i contenuti e tutti i programmi e generi hanno lo stesso valore potenziale e a tutti è riconosciuto lo stesso valore purché si “facciano vedere”, siano in grado di suscitare l’interesse di qualcuno, assicurino audience e introiti pubblicitari.
Tutto ciò corrisponde ad una visione del mondo nella quale si perdono relazioni e gerarchie di valore e di importanza, in cui, per usare una bella espressione del filosofo Ignatieff, “non c’è niente di sacro”.
Questa immagine dello spazio cacofonico, con le sue implicazioni culturali, mi sembra suggerire tre osservazioni:
a) In questo contesto diventa essenziale saper riconoscere, valutare le voci, discriminare le voci sulla base del criterio del rispetto della dignità delle persone. Non è mai indifferente il modo in cui si parla dell’uomo e della sua vita. Un primo aspetto è che si può parlare dell’uomo e delle relazioni umane – come l’amicizia, l’amore, l’affetto, ma anche il conflitto, l’odio o il risentimento – in un modo aperto alla ricchezza e alla complessità dei fattori che comprendono la sua umanità o in modo stereotipato e riduttivo. Ad esempio si possono usare formule semplificatorie e banali per descrivere e interpretare le azioni umane o si può cercare di coglierne la profondità e le cause. Ma discernere tutto questo non sempre è facile perché mai come in questo tempo, per usare una bella espressione di Theodor Adorno, la “menzogna veste la maschera della verità”. Occorre dunque vagliare, riconoscere e allearsi con tutto ciò che è difesa e promozione della dignità umana, ovunque sia e da qualunque esperienza sociale emerga. Questo è un aspetto fondamentale della lotta per il “rispetto” della dignità umana, che è un tratto fondamentale del nostro tempo (R. Sennett, Il rispetto).
b) La seconda implicazione riguarda direttamente la Chiesa. Nello spazio cacofonico, la Chiesa deve parlare non con una sola voce, ma con una pluralità di voci, che corrispondono alla pluralità delle esperienze e delle sensibilità ecclesiali, personali e di gruppo, ma queste voci devono esprimere una sostanziale unità. La verità è sinfonica, ricordava il grande teologo von Balthasar e la voce della Chiesa deve essere come uno spartito comune nel quale converge la ricchezza delle voci e degli strumenti. Purtroppo negli ultimi tempi, si è assistito a dichiarazioni, prese di posizioni, che hanno creato molti problemi all’immagine e alla credibilità della Chiesa, per protagonismo, sprovvedutezza, ingenuità, mancanza di conoscenza dei meccanismi dei media. Questo pericolo, che sempre è esistito, aumenta enormemente con Internet, che offre una insolita amplificazione anche a voci isolate, casuali o periferiche, per cui una dichiarazione o un intervento in un sito o in una piccola televisione della Nuova Zelanda o del Perù il giorno dopo ha già fatto il giro del mondo. Questo vale innanzitutto come richiamo per tutti, ognuno nel suo ruolo e per la sua responsabilità, a considerare che ogni atto comunicativo finisce per coinvolgere, come mandante, della comunicazione la Chiesa intera. In secondo luogo forse è necessaria una maggiore responsabilità collettiva e anche un professionismo maggiore nel consigliare, indirizzare, aiutare a prevenire errori comunicativi che poi si pagano duramente.
c) C’è poi una terza implicazione. La voce va allenata, va addestrata. Questo è il tema della competenza comunicativa. Ormai, nell’epoca di Internet e dei media diffusi, dei social network e degli user generated contents, non può riguardare solo la voce di chi ha le maggiori responsabilità, quindi degli specialisti, dei professionisti, ma anche di tutti coloro che si uniscono al coro.
- Occorre quindi una forte autorevolezza dei comunicatori professionali e questo implica sostenere chi ha una particolare vocazione ad impegnarsi in questo campo con una adeguata formazione;
- ma questa è anche una vocazione diffusa. Tutti sono chiamati ad essere comunicatori efficaci. Da un lato perché questo attiene alla dinamica propria della fede, ma anche perché è la cifra comunicativa di questo tempo, in cui ognuno può essere efficacemente emittente e ricevente nella rete della relazioni. Il problema della credibilità della comunicazione, oggi non riguarda più solo i professionisti o gli specialisti, riguarda tutti.
3. C’è poi anche una terza immagine, assai interessante e realistica, per quanto forse sgradevole. L’ambiente mediatico, dice ancora Silverstone, è un “campo di tensioni”, un campo di lotte e di conflitti. In una parola, ci piaccia o no, è un campo di battaglia. Un campo in cui si scontrano e si contrappongono grandi gruppi economici, politici ed editoriali, in cui vi è una lotta accanita per conquistare i consumatori e gli elettori, dove si ritagliano un loro spazio anche posizioni estremistiche e violente (che promuovono l’odio in rete). Molto più che in passato, i media sono diventati dunque un gigantesco campo di battaglia per conquistare consumatori, per la propaganda politica, per l’affermazione di ideologie. E ognuno cerca di allargare il proprio spazio, il proprio dominio. Questo campo è anche ricco di “voci alternative, di minoranze, e di azioni individuali”, che trovano nelle nuove tecnologie una importante opportunità di azione e di espressione: pensiamo ad esempio a tutta la ricchezza dei cosiddetti media non mainstream o alle esperienze del citizen journalism (queste esperienze sono importanti, anche se presentano molti limiti, vedi Gaggi e Bardazzi). Con tutto questo, però, non tutti possono scendere in campo, perché non tutti hanno le risorse economiche, tecnologiche e le competenze per accedervi. E comunque, la grandissima maggioranza di quelli che vi accedono restano presenze del tutto marginali, irrilevanti e insignificanti, come rivela impietosamente, ma realisticamente, il titolo del libro di Lovink, Zero Comments. Sei in rete, ma è come non ci fossi perché nessuno di accorge di te e non hai la forza per importi, per “farti vedere”.
Anche questa terza immagine ha delle implicazioni:
a) Prima implicazione: l’ambiente mediatico è e resta un campo di interessi forti, aggressivi e spesso non proprio benevoli verso la Chiesa e la fede cattolica. Per questo occorre presidiare il territorio mediatico, tenere la posizione, non farsi travolgere, individuando anche strategicamente i media più utili ed efficaci. Per questo è il campo in cui la Chiesa deve continuare a generare e rafforzare mezzi di comunicazione autoprodotta, cioè mezzi propri, ma anche deve cercare il più possibile di influenzare la comunicazione eteroprodotta, cioè la comunicazione di altri soggetti perché parlino della esperienza della fede in modo non riduttivo o deformato. Questo è infatti un campo nel quale la Chiesa può ricevere, e ce ne stiamo accorgendo in questi mesi, delle ferite terribili.
b) C’è una seconda implicazione: questo è un campo attraversato dall’ingiustizia in cui alcuni combattono con i carri armati e altri con le fionde e a mani nude. Tutti noi sappiamo che cos’è il knowlege divide, di cui il digital divide è un aspetto. E’ l’idea che c’è una conoscenza utile, che conta, che fa arricchire, che è motore dell’economia, di cui la competenza digitale è una parte significativa (Petrella 2002).
Questa conoscenza utile, questa conoscenza che è una risorsa importante per la vita delle persone, delle famiglie e dei popoli, è distribuita in modo ineguale. Nell’enciclica Caritas in veritate, Benedetto XVI parla di una giustizia distributiva, ma nel caso dei media, questa giustizia distributiva è anche una giustizia relazionale. Allora questo è un campo privilegiato di una azione per la giustizia, e anche di una critica sociale, di cui i cristiani devono farsi protagonisti. Nell’enciclica il Papa parla di uno stretto rapporto tra ecologia ambientale ed ecologia delle relazioni umane, delle relazioni sociali. Esiste un rapporto altrettanto stretto tra l’ecologia umana e sociale e l’ecologia dei media. Poiché ecologia umana ed ecologia dei media sono oggi due facce della stessa realtà. La giustizia o l’ingiustizia nelle relazioni umane si rispecchia, si riverbera in quella delle relazioni comunicative e viceversa, l’inquinamento delle une produce l’inquinamento delle altre e la libertà e la trasparenza delle une interagisce e influenza quella delle altre. E la dignità delle persone riconosciuta in una sfera si ripercuote nell’altra.
Un’ultima considerazione a conclusione di questo primo punto. Globalizzazione e nuovo ambiente mediatico sono strettamente legati. La piazza è la piazza globale, ma globale è anche lo spazio della cacofonia e il campo delle tensioni, il campo del conflitto per l’egemonia comunicativa.
Ciò che caratterizza la globalizzazione non è solo il fatto che si crea una interdipendenza a livello globale dei sistemi giuridici, politici, economici e comunicativi, cioè il fatto di vivere in un unico contesto, ma è anche la “consapevolezza” di vivere in un unico contesto. La riflessività, la coscienza di vivere in un mondo globalizzato è dunque un fattore essenziale delle globalizzazione (Robertson).
Questo aspetto ha una implicazione immediata: in questo mondo siamo provocati, interrogati, da tutto ciò che accade ovunque. McLuhan ha bene espresso questa idea quando, nei suoi ultimi scritti ha osservato che viviamo in un teatro globale, dove non ci sono spettatori, ma tutti siamo attori perché tutti coinvolti, volenti o nolenti, nelle vittorie e nelle sconfitte, nei progressi e nelle tragedie degli altri.
Se ciò vale in tutti i campi e per tutti gli aspetti del nostro agire, vale anche e a maggiore ragione per la nostra identità di credenti. La globalizzazione rende ancor più evidente il carattere universale della Chiesa, rende più chiaro, soggettivamente percepibile, che il respiro della Chiesa è universale, che essa è un corpo unico. E’ la sfida di una rinnovata coscienza dell’universalità, della cattolicità della Chiesa. Tutto ciò che accade nella Chiesa e alla Chiesa ci riguarda direttamente, mi riguarda direttamente. Ed io sono chiamato a risponderne, io personalmente come individuo, gruppo, movimento, associazione, parrocchia, diocesi, etc. Io non posso dire: la mia parrocchia, la mia diocesi o la mia associazione va bene, quando la Chiesa soffre nel mondo, è attaccata o perseguitata. O non posso non soffrire di ciò che macchia l’immagine della Chiesa e mette a repentaglio la sua credibilità, la fiducia che gli uomini ripongono in essa. Perché in queste situazioni certo contano le dichiarazioni ufficiali, i comunicati, le prese di posizione chiare di chi ha responsabilità nella Chiesa, ma conta la testimonianza di ognuno nella sua parrocchia, nel suo ambiente di lavoro, nelle relazioni di vita quotidiana, ma anche nelle relazioni in rete. Ognuno di noi è corpo della Chiesa e volto della Chiesa. E in questo ambiente globalizzato ciò diventa più chiaro, più evidente, anche drammaticamente evidente.
Il senso di tutto ciò è espresso poeticamente e potentemente da Thomas Stearn Eliot nei Cori dalla Rocca,: una Chiesa per tutti e un lavoro per ciascuno [e aggiungerei: non un lavoro qualsiasi, un lavoro purchessia, ma un lavoro da protagonisti, corrispondente alle capacità e alla vocazione specifica di ciascuno].