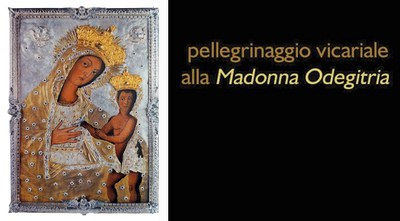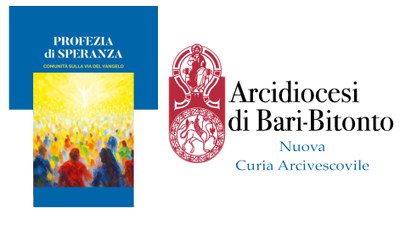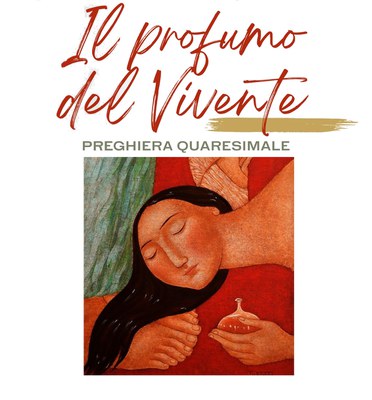La fragilità e l'amore
 «Adesso voglio parlare della mia fragilità, non mascherarla, convinto che sia una forza che aiuta a vivere. La fragilità rifà l'uomo, mentre la potenza lo distrugge». Così esordisce Vittorino Andreoli nel suo saggio dal titolo emblematico, «L’uomo di vetro».
«Adesso voglio parlare della mia fragilità, non mascherarla, convinto che sia una forza che aiuta a vivere. La fragilità rifà l'uomo, mentre la potenza lo distrugge». Così esordisce Vittorino Andreoli nel suo saggio dal titolo emblematico, «L’uomo di vetro».
Sul tema della «fragilità» l’Associazione medici cattolici italiani (Amci) e la Piccola Casa della Divina Provvidenza sabato scorso, al centro congressi del Santo Volto di Torino, hanno organizzato il convegno, «L’uomo fragile», che ha visto la partecipazione del noto psichiatra. Il tema è di grande attualità e ha assunto in questi ultimi anni alcune caratteristiche nuove che lo rendono oggetto di ulteriori riflessioni e approfondimenti. La fragilità è una condizione connaturata all’esistenza, legata alla finitudine umana, alla precarietà del tempo e delle condizioni. Ci interpella, pone questioni di senso, della precarietà, della provvisorietà, dell’hic et nunc. E’ al contempo una dimensione ontologica, che accompagna da sempre l’uomo nei suoi molteplici modelli antropologici.
Esiste una fragilità legata alla biologia e quindi all’evolvere naturale del tempo (infanzia, adolescenza, maturità, senescenza) alle malattie, alla sofferenza, alla morte. Sono le declinazioni più o meno conclamate, e cioè le patologie del corpo, della mente e dell’anima. Sono le dipendenze da alcol, da droghe, da farmaci, ma sono anche le disabilità. Vi è poi una fragilità meno visibile, esistenziale e sociale, legata all’essere ed al suo agire nel mondo. Martin Heidegger ben riassumeva questa dimensione quando definiva l’uomo come «essere per la morte», «gettato nel mondo». Paura, angoscia, tristezza ed insicurezze permeano ed accompagnano tutta la nostra vita.
La condizione umana, afferma Andreoli, gira attorno alla morte e alla paura della morte. «La percezione della fine è dentro ciascuno di noi, è uno stigma della specie, un marchio della sua caducità. Ecco la condizione umana, ecco il prossimo secondo di ciascuno di noi, il futuro possibile che ci attende. E in questa condizione come è possibile dimenticare la fragilità? Come è possibile vivere il presente senza tenere conto che è ancorato all'attimo successivo in cui può accadere di tutto, ogni forma di disgrazia e di perdita? Di fronte a queste domande, che nascono dalla paura e dal dolore, persino la potenza appare fragile».
La globalizzazione, il relativismo etico, la fiducia sconfinata nella scienza, il consumismo esasperato, la ricerca ostinata del piacere, della ricchezza e del successo, hanno contribuito a rendere l’uomo contemporaneo ancora più fragile e disorientato. «Una società in forte cambiamento e dai ritmi esasperanti quale è la nostra», continua Andreoli, «può rendere gli adattamenti del singolo più difficili. Basterebbe pensare allo sconvolgimento avvenuto negli ultimi anni con l’introduzione delle tecnologie digitali, da cui è scaturito un mutamento sostanziale dei rapporti e dei linguaggi. La virtualità era una dimensione inimmaginabile appena qualche decennio fa. Oggi dobbiamo adattarci a una società che si trasforma continuamente, non solo nelle tecnologie, ma anche nelle relazioni, sempre più complicate. Concentrati su di noi abbiamo ucciso gli dei e reso la bellezza l’unica nostra religione. Non abbiamo più sogni, non coltiviamo progetti, non sopportiamo il silenzio, facciamo rumore per vincere la solitudine, incapaci di amare, di insegnare ai nostri figli e di imparare dai nostri padri. E siamo pieni di paura». Viviamo monitorizzando e medicalizzando i sentimenti, arrivando a negarli, ritenendoli inaccettabili in un mondo programmato per le emozioni “positive”.
E’ significativo che in Italia il 14 per cento della popolazione soffra di depressione clinica: non una tristezza o una malinconia transitorie dovute a eventi occasionali come il lutto, bensì una condizione strutturata che ha le caratteristiche per rientrare in una categoria psichiatrica. A questo si deve aggiungere che l’ansia, nelle sue diverse manifestazioni, colpisce il 20 per cento della popolazione, mentre il 5 per cento presenta disturbi maniacali e il 2 per cento soffre di schizofrenia. La società del fare e dell’apparire, dell’avere e non dell’essere, penalizza e colpevolizza la fragilità, la bandisce come una debolezza da combattere e da rimuovere ed il mondo patinato e scintillante la nasconde e la maschera.
Ma un uomo non si misura dalla sua ricchezza, dai suoi titoli onorifici e dalle azioni eclatanti che compie, ma dal suo valore intrinseco. Se vogliamo conoscere il valore giusto di un uomo, diceva già Seneca, guardiamolo spogliato del patrimonio, degli onori, delle altre false apparenze della fortuna; guardiamolo nell’animo per vedere se egli è grande di suo o se ha una grandezza presa in prestito. La dignità non deriva da un contratto, ma ci appartiene in quanto persone. A tal riguardo, il contributo del cristianesimo è significativo. La prospettiva cristiana coglie l’uomo in tutte le sue dimensioni, con le sue virtù e le sue fragilità.
E’ illuminante a tal riguardo l’ultima pubblicazione di Paolo Scquizzato, «Elogio della vita imperfetta». Scrive il sacerdote cottolenghino, docente di Teologia: «Il principio di tutti i mali è un’errata, quanto perversa, idea di perfezione che ci portiamo dentro. Idea alla quale pensiamo dovrebbero corrispondere il nostro essere, quello degli altri e quello di Dio. Ciò che ci fa male, ciò che è distruttivo, è l’idea di dover essere “in un altro modo”; che, per essere accettati da noi stessi, dagli altri e da Dio, non dovremmo essere abitati dalle impurità. Vorremmo essere semplici “ostriche vuote”, senza corpi estranei. Dei puri, insomma. Ma questo non ci è dato. E anche qualora ci considerassimo tali, ciò non significherebbe che non siamo mai stati feriti, ma solo che non lo riconosciamo, non riusciamo ad accettarlo, che non abbiamo saputo perdonarci e perdonare, comprendere e trasformare, avvolgere le nostre ferite con quella madreperla, che fuori di metafora è l’amore, rimanendo semplicemente poveri e terribilmente vuoti».
Se la fragilità è una condizione a cui non possiamo sottrarci, dobbiamo però trovare un equilibrio, delle vie di fuga, delle strategie per ribaltare la prospettiva trasformando la debolezza in forza. Il primo passo è riappropriarsi della dimensione della «finitudine». Una visione in cui campeggia il limite, sostiene Andreoli, impedisce i deliri di onnipotenza e di vivere per il potere. Impedisce di essere cattivi verso chi sbaglia, poiché l'errore è connaturale alla fragilità, alla paura di sbagliare che, se talora aiuta ad evitare l'errore, sovente lo facilita: per la preoccupazione di evitare l'errore, lo si immagina e lo si compie. Non c'entra il nichilismo, ma la voglia di aiutare l'altro.
La fragilità come origine della voglia di legame, di comprensione, di solidarietà e di amore. La fragilità non spinge a vincere; talvolta sa di vittoria l'aver lasciato il primo posto a chi non ha mai vinto. La fragilità conosce gli ultimi e non soltanto i forti.
Una società fragile non è una società debole, semmai è una società saggia.
La fragilità porta alla saggezza, a vedere il limite della ricchezza e del potere, a sentire il dolore nella sua drammaticità e nel suo mistero. È bellissima l'idea dello scambio di fragilità visto come scambio di forza di vivere.
Ed a questo punto, nel pensiero di Andreoli, avviene un passaggio significativo. La «finitudine» si apre alla dimensione relazionale, supera i confini dell’io e si apre all’altro, al noi, cioè alla realizzazione di sé nella comunità, nella polis. Ribadisce lo psichiatra: «La mia fragilità significa che ho bisogno dell'altro: di lei che si faccia parte di me senza confini e distinzioni, di chi mi possa aiutare con la voglia di mostrarsi amico poiché sa che io sento la voglia di esserlo per lui».
Ad analoghe conclusioni, pur declinate attraverso la prospettiva della fede, giunge Paolo Scquizzato: «Occorre avere il coraggio, e la grazia, di restituire alle nostre ferite il diritto di cittadinanza. Il rapporto con noi stessi e la nostra vita quotidiana (sociale, familiare, relazionale) diverranno “paradisiaci” quando riusciremo ad accoglierci ed amarci non malgrado, ma attraverso tutte le nostre ferite e le nostre debolezze. Una comunità (sia essa civile, familiare, religiosa) sarà un “paradiso” non quando tutti saranno perfetti e non vi saranno più tensioni, bensì quando ciascuno potrà finalmente gettare via la maschera che gli copriva la sua vera identità, perché si sentirà accettato e amato così com’è; quando limiti, peccati, ferite e tradimenti non sono più occasioni di divisione e maledizioni, ma luoghi dove potersi amare e perdonare. L’ostacolo è la condizione perché la luce possa risplendere; l’attrito è la condizione perché il movimento possa verificarsi. Perdere non vuol dire essere sconfitti, e questo perché il bene vince sempre».
Sano o risanato all’interno di questo percorso non è quindi colui che confida solo in se stesso, che dispone di capacità fisiche, psichiche o mentali al di sopra della media, ma colui che ha la forza di accettare la propria umanità finita, la propria fragilità, in altre parole, di accettare la vita.
Enrico Larghero
© "Il nostro tempo", 3 novembre 2013