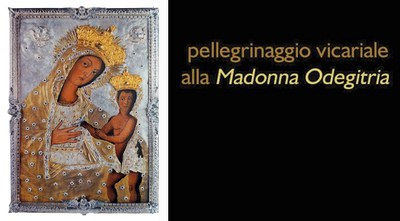L'incontro. L'oratorio ha un progetto: crescere insieme, nella comunità, sul territorio
All’ultimo atto del terzo Happening degli Oratori (H3O), ormai il titolo calembour "Facciamo fuori l’Oratorio" dovrebbe essere chiaro. E proprio all’ultimo atto, nella chiesa del Seminario regionale pugliese di Molfetta che ha ospitato i 500 tra giovani, preti e suore, rappresentanti dell’immenso variegato popolo degli oratori italiani, don Michele Falabretti, responsabile del Servizio nazionale per la pastorale giovanile, lo ricorda, lo ribadisce, lo incide nelle menti e nei cuori affinché non ci sia possibilità di equivoco.
"Far fuori" significa dare più importanza alle persone, che fanno oratorio, che ai muri dell’edificio oratorio. Non significa andare chissà dove, perché non si tratta di una questione meramente geografica; e comunque sarà il "fuori" a venirci incontro. Significa piuttosto rimanere in ascolto e modulare il progetto educativo sulla base delle voci – sussurri e grida di speranza o disperazione, interesse o indifferenza – che giungono da "fuori".
Falabretti si fa aiutare da un amico antico, un salesiano bergamasco morto ancor giovane, 15 anni fa, quando era da poco vescovo a Belluno-Feltre, uno che l’oratorio e la passione per i giovani li aveva nel sangue: «Per don Vincenzo Savio l’oratorio dovrebbe essere come una tenda. Leggero, che si possa spostare, perché se oratorio sono innanzitutto le persone, allora si può "fare oratorio" ovunque». Sottile come una tenda anche per un altro motivo: «La tenda ti permette, mentre ci stai dentro, di cogliere le voci di chi sta fuori».
"Far fuori", conclude Falabretti, significa dunque «ascoltare questo nostro tempo. Abbiamo delle certezze? Certamente. Ma non sono un gabbia, un "circolo" da cui nulla esce e in cui nulla entra. La Chiesa non ha mai avuto paura di incontrare le persone per ciò che sono, mai avuto paura di cambiare». Lo ripete più volte: «Gli altri non saranno mai esattamente come noi li vorremmo. "Far fuori" significa incontrarli per ciò che sono", comodi o scomodi, gratificanti o ruvidi. "Far fuori" è "il coraggio di cambiare ciò che va cambiato».
È la storia dell’oratorio. Don Bosco creò una novità, partendo dalla scuola, dando parole e numeri a ragazzi che ne erano privi e a cui nessun altro avrebbe pensato. L’oratorio, negli anni a venire, avrebbe dato musica, teatro e sport a chi altrimenti ne sarebbe stato privo: «Sapeva intercettare i bisogni umani», e da qui parlare all’anima. «Il mondo bussa alla nostra porta», non lo sentiamo?
Nulla però accade da sé, nulla è automatico. Nelle tre giornate di H3O una delle parole-chiave è stata "progetto". L’oratorio ha bisogno di «un progetto legato al territorio in cui viviamo, il territorio geografico e soprattutto umano, territorio sempre diverso in Italia. Solo così l’immutabile Vangelo potrà essere declinato in tanti modi diversi». Da qui la necessità di dare spessore al profilo dell’educatore, colui al quale per primo è affidato il progetto, mai cavaliere solitario perché il progetto appartiene alla comunità, di cui l’educatore è interprete.
Il mosaico manca ancora di una tessera, il ruolo "politico" dell’oratorio. Falabretti guarda negli occhi i giovani uno per uno: «Quando la città non ha più tempo né voglia di prendersi cura dei più piccoli, ci siete voi, con un servizio fatto di legami, custodia e servizio, che non ha prezzo». E questa è politica, in senso lato ma lo è perché interessa la polis. «Voi non animate solo i ragazzi. Voi animate una comunità intera». Anche nella più remota delle periferie, l’oratorio può essere il centro.