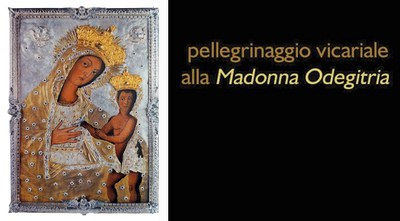Memoria, fedeltà, profezia: 40 anni di Caritas Italiana
 IL RISCHIO DELLA CARITÀ
IL RISCHIO DELLA CARITÀ
“Quando la carità è un rischio, proprio quello è il momento della carità”. Così si esprime il vecchio prete, protagonista dell’ultimo film di Ermanno Olmi, “Il villaggio di cartone”, che il maestro ha voluto girare nella mia città e che qualcuno ha definito un “inno alla carità”. Si tratta di un’opera che ha fatto e fa discutere, che ci interpella e sollecita soprattutto il nostro lavoro: ci fa pensare. E se è vero, con Heidegger, che il fatto più preoccupante del nostro tempo è che non siamo capaci di pensare[1], allora l’esercizio di un pensiero che fa memoria e medita ritengo non potrà che giovarci, in questo quarantesimo compleanno della Caritas italiana.
Evocare il rischio nel nostro attuale contesto ecclesiale e culturale significa non solo riflettere sul carattere rischioso di ogni azione, che comporti delle scelte precise e ponderate (solo chi non fa nulla, non rischia nulla), ma soprattutto interrogarci sul rischio come cifra dell’attuale condizione umana, così come viene descritta da Ulrich Beck nei suoi lavori[2].
Qual è il contesto culturale nel quale viviamo e operiamo? Gli esiti del villaggio globale hanno condotto a quella che è ormai definita in modo evidente post-globalizzazione; mentre, come aveva a stigmatizzare Régis Debray, le cose (i prodotti) si globalizzano e le persone si tribalizzano[3], in un particolarismo talvolta esasperato.
Nel frattempo siamo chiamati ad abitare un mondo sempre più complesso, che interpella e pervade anche l’esercizio della carità.
La coscienza della complessità può aiutarci a fare memoria e ad esercitare la profezia di fronte ai rischi cui oggi è esposta la charitas, essenza della vita cristiana e della sequela che personalmente e comunitariamente intendiamo perseguire. La consapevolezza di essere eredi di una lunga tradizione di carità, che affonda le sue radici nel Vangelo e attraverso i secoli si esprime nella vita della Chiesa, piuttosto che motivo di orgoglio, non può che sollecitare l’impegno alla conoscenza di questa tradizione, delle forme e figure di santità che ha prodotto, delle difficoltà e dei rischi che ha affrontato, delle testimonianze di uomini e donne di carità, non raramente diventate veri e propri martiri, che ha generato. Possiamo far riferimento alla storia remota della Chiesa, ma anche alle figure di santità, il più delle volte nascoste, che hanno costellato questi ultimi quarant’anni, anche nelle nostre chiese che sono in Italia. Ma proprio la “memoria” oggi risulta particolarmente compromessa, se non perduta, in un contesto mediatico tutto proteso a vivere l’eterno presente dell’attimo fuggente, tanto incapace di riferirsi al passato, quanto di sperare nel futuro. In questo senso piuttosto che esercitarci nella memoria della carità, forse siamo chiamati ad attuare la carità della memoria, venendo incontro ad uno dei bisogni più profondi dell’epoca che siamo chiamati a vivere con intelligente amore. Credo sia soprattutto questo il senso della richiesta avanzata per la mia relazione, in riferimento non tanto a quanto nella prassi si è realizzato, ma alla visione globale cha ha accompagnato finora l’esperienza della Caritas in Italia.
La memoria delle comunità in cui operiamo, del territorio in cui viviamo, ci rimanda all’altra parola presente nel titolo della relazione che mi è stata assegnata: fedeltà. Se uno dei modi più fuorvianti di intendere la globalizzazione consiste nell’omogeneizzazione etnica, culturale, religiosa, allora comprendiamo come sia in gioco, direi oggi non più di ieri, la stessa identità cristiana.
L’identità cristiana è, come sempre, di fronte alla tentazione della riduzione e della dissolvenza in quella che oggi potremmo chiamare la “religione civile”, dove il rapporto al Signore Gesù risulta marginale rispetto al nostro essere nel mondo. A nessuno sfuggono le conseguenze
di questa “fedeltà cristiana” nell’esercizio della carità, che richiama l’ispirazione profonda della Caritas fin dal suo nascere il 2 luglio 1971. Questo aspetto è centrale nella riflessione che stiamo svolgendo.
Finalmente la terza parola: profezia. Non solo nel senso di apertura o predizione di un futuro, ma nel senso etimologico di essere portatori di una Parola che non è nostra, e che proprio perché tale non possiamo imporre, ma solo proporre. Essa non va dimostrata, ma solo indicata. Certo, senso profetico significa anche senso critico, denuncia, vigilanza e prospettiva di quella “riserva escatologica” che ci fa essere nel mondo senza essere del mondo; ma non dobbiamo dimenticare che agli oracoli di giudizio, nei profeti dell’antica alleanza, si accompagnano sempre oracoli di salvezza, di simpatia, di speranza. Anche il Figlio dell’uomo non è venuto a giudicare il mondo, ma a salvarlo. Lui appunto, non noi, che, quando abbiamo fatto tutto quanto ci è richiesto, in termini di fedeltà e di dedizione, dobbiamo continuare a considerarci “servi inutili”. Ciò non ci esime da quello sguardo di fede e di speranza che ci fa misurare con le sfide della globalizzazione e ci fa contemplare l’icona offerta dall’Apocalisse della «città santa, la nuova Gerusalemme» che scende dal cielo (Ap 21,2).
Come pure la dimensione profetica del nostro essere ed agire da credenti rende necessario l’esercizio di una duplice diffidenza:
a) verso quanti sistematicamente denigrano il nostro tempo, cogliendone soltanto gli aspetti problematici e critici;
b) verso quanti si lasciano sommergere dal nostro tempo, inseguendo piuttosto le mode che il Vangelo.
Non ci sono epoche solo di luci o solo di ombre: la nostra epoca – come quelle che l’hanno preceduta – ha luci ed ombre, e in questo chiaroscuro ci lasciamo orientare dalla luce della fede.
RISCHI E ANTIDOTI NELL’ESERCIZIO DELLA CARITÀ
Non è un caso che il sottotitolo del film di Olmi sia «∂iabasis», la parola che si fa atto. Il prete, che si prende cura dell’immigrato ferito, incomincia a rendersi conto che la sua chiesa, ormai disadorna, non è più vuota ed è diventata il luogo dove la Parola di Dio può essere messa in pratica. In altri termini, la «Parola» (è dall’ascolto della Parola che nasce la fede cristiana) deve essere efficace, deve dare frutto per non rimanere lettera morta. Ma è altrettanto vero che nella Parola della croce ogni atto (d’Amore) prende forma, misura e motivo.
Il racconto filmico, che ha carattere di apologo, mi offre l’occasione per accennare a qualche deriva cui può andare incontro l’esercizio della carità e agli eventuali antidoti.
Sbilanciamento sulla carità come prassi
Qual era l’intuizione originaria di Paolo VI che volle l’erezione della Caritas italiana a cinque anni dalla chiusura del Concilio? Era quella di fare la carità? Ma la Chiesa già la faceva. E tanta. Non saprei se meno o più di oggi.
Mi sembra che la preoccupazione del pontefice fosse quella di “aggiornare” l’azione caritativa alle novità conciliari e sociali. Nelle Caritas diocesane, che muovevano i primi passi, il 28 settembre 1972, Paolo VI coglieva un frutto del Concilio, come espressione della «crescita del Popolo di Dio»: «La vostra azione - affermava - non può esaurire i suoi compiti nella pura distribuzione di aiuto ai fratelli bisognosi. Al di sopra di questo aspetto fondamentale materiale, deve emergere la sua prevalente funzione pedagogica, il suo aspetto spirituale che non si misura con cifre e bilanci, ma con la capacità che essa ha di sensibilizzare le Chiese locali e i singoli fedeli al senso e al dovere della carità».
È questo avvenuto?
La preoccupazione per i rischi cui si espone oggi l’esercizio della carità non proviene soltanto dai nostri ambienti e contesti ecclesiali, ma si coglie nella cultura cui apparteniamo e che respiriamo con l’aria. Già Gustav Flaubert, nel 1938 - per fare un riferimento letterario -, scriveva che «la filantropia si esercita facendo la carità ai poveri», - e aggiungeva malevolmente - «per avere il proprio nome sui giornali»[4]. Qui risulta il fraintendimento tanto madornale quanto diffuso, secondo cui l’espressione “fare la carità”, che ascoltiamo anche dalla voce del povero incontrato causalmente per strada, è sinonimo di “fare beneficenza”. Il senso dell’elemosina, che condividiamo con i fratelli islamici, va oltre l’assistenzialismo spicciolo e immediato, sebbene non debba escluderlo. Ci siamo a lungo interrogati su questo, ma forse abbiamo bisogno di richiamare il carattere multiforme della carità.
a) Alle sorgenti della virtù della carità
Il beato Antonio Rosmini collegava la carità all’essere e invitava a viverla secondo le tre forme costitutive: temporale (o materiale), intellettuale e spirituale (morale). Nella prima forma di carità doniamo ciò che abbiamo, nella seconda ciò che sappiamo, nella terza noi stessi. Se l’essere ha a che fare con la carità e viceversa, questa nel suo esercizio concreto e quotidiano non può non ispirarsi a questa triplice forma, esprimendo la propria origine trinitaria, il proprio radicamento nel Dio uno e trino. È superfluo ricordare che Rosmini aggiungeva che «la principale e suprema specie di carità è la terza, che tende ad un bene più grande e più vero»[5].
È qui l’inedito cristiano dell’amore. Non è un amore meramente umano (a partire dall’uomo: dalle sue emozioni o affetti, dalla sua filadelfia o filantropia), ma divino, e perciò partecipato e ricevuto come karis, cioè grazia. «Dio è amore» (1Gv 4, 8.6) è il principio dell’amore a un duplice livello: ontologico ed etico, ossia dell’essere e dell’agire.
Ora la Trinità non ci sta semplicemente davanti, come un’icona della fede e della preghiera, ma ci coinvolge sul piano dell’essere e dell’agire. Una sola e medesima carità mi unisce a Dio come Padre e ai figli di Dio come fratelli. Non sono due carità, ma una sola carità. E tutta la carità, anche quella verso il prossimo, è teologale.
Carità è anzitutto essere nella carità. Modalità questa non sufficientemente o assai poco evangelizzata. Per cui scontiamo nella catechesi e nella coscienza cristiana uno sbilanciamento sulla carità etica, sulla carità come comandamento e come prassi. La fede nella carità – “noi abbiamo creduto alla carità” (1Gv 4,16) – non significa primariamente un fare, ma un riconoscersi e disporsi costitutivo fondamentale: un “lasciarsi fare” dallo Spirito di Dio che ci stabilisce nella carità di Dio. È significativo che S. Tommaso d’Aquino non definisca primariamente la carità come virtù etica, ma come stato di vita: «una speciale amicizia dell’uomo con Dio». «La carità – aggiunge – non è virtù dell’uomo».
Ha questa visione teologale della carità orientato costantemente in modo esplicito la Caritas?
b) Il rischio della deriva assistenzialistica e lo “stile cristiano”
Ma cercando di aguzzare lo sguardo, pensando più in profondità al rischio di una deriva assistenzialistica della carità, da cui cercava di metterci in guardia Paolo VI, possiamo scorgervi il prodursi di un ulteriore fraintendimento, con cui quotidianamente deve misurarsi chi intende agire sospinto dalla carità in questo mondo: da un lato l’impulso della spontaneità, che può generare uno spontaneismo momentaneo e a lungo termine sterile, dall’altro la tentazione connessa con la necessità di organizzare il servizio, che può diventare burocratizzazione dell’amore; da un lato il volontario con la sua generosità, dall’altro il funzionario con i suoi progetti.
Fra il livello della spontaneità volontaristica e quello dell’organizzazione progettante, si dà una terza via, che esclude la scorciatoia del compromesso e si ispira all’evidenza dello “stile cristiano”.
Il cristianesimo è anche una questione di stile. Capacità e necessità di identificazione,
ma anche capacità dinamica di conversione. E lo stile del cristiano e della comunità si misura sullo stile di Gesù: sui suoi gesti e sulle sue parole. Oltre ogni compromesso, si tratta di recuperare quello “stile paradossale”, fondato sul paradosso che è Cristo stesso, cui fa esplicito riferimento il Discorso a Diogneto, nel momento in cui esprime il modo di essere del cristiano nel mondo: “[I cristiani] danno l'esempio di una vita sociale mirabile, o meglio – come dicono tutti – paradossale” (Discorso a Diogneto V, 4).
Il riferimento allo stile ci permette - tra l’altro - di coltivare gli antidoti che si oppongono al rischio della deriva di una trasformazione, per esempio, del “volontariato” in “parastato”. Quando, visitando con una quarantina di sacerdoti baresi la Missione speranza e carità di Palermo, Biagio Conte, questo “medievale folle di Dio”, ci ha detto di non aver voluto ricevere alcun contributo dalle istituzioni statali per le sue tre Città della gioia siciliane, ho compreso ulteriormente il senso del rischio di ridurre la Caritas un po’ a movimento un po’ a business, soprattutto se ci lasciamo persuadere dalle sirene statali nei momenti di emergenza. Quanta fatica ho esperimentato, anche personalmente, durante lo sbarco degli albanesi a Otranto, per dissuadere dal gestire, con sovvenzioni statali, l’accoglienza! L’intuizione conciliare di una Chiesa libera, anche nella carità, non può essere aggirata. Risuonano le parole della Gaudium et Spes: «Certo, le cose terrene e quelle che nella condizione umana, superano questo mondo, sono strettamente unite, e la Chiesa stessa si serve delle cose temporali nella misura che la propria missione richiede. Tuttavia, essa non pone la sua speranza nei privilegi offertigli dall’autorità civile; anzi, rinunzierà all’esercizio di certi diritti legittimamente acquisiti, ove constatasse che il loro uso potrebbe far dubitare della sincerità della sua testimonianza o circostanze nuove esigessero altre disposizioni» (n. 76).
NEL CAMMINO PASTORALE DELLA CHIESA ITALIANA DEL POST-CONCILIO
Come pastoralmente si è collocata la Caritas in Italia nei primi decenni postconciliari?
Gli orientamenti pastorali degli anni ’70 Evangelizzazione e sacramenti hanno forse rappresentato la svolta più radicale, dopo il Concilio, nella Chiesa italiana.
Di fronte a un’accentuata «sacramentalizzazione», si è compreso che non è possibile vivere la liturgia, vivere i sacramenti senza dar ragione della propria fede, della propria speranza.
Già il Rinnovamento della catechesi (Documento Base) aveva preparato il terreno. L’affermazione della priorità dell’evangelizzazione ha, però, di fatto privilegiato la catechesi come preparazione ai sacramenti, e ne ha accentuato l’aspetto razionale. La catechesi è preparazione, non solo ai sacramenti, ma anche alla vita. Il rapporto fede-vita è uno dei nodi richiamati nel post-concilio. Mi sembra però che la pastorale non ha dato molto rilievo alla connessione fede-rito. La «chiesa della Parola» ha camminato parallelamente alla «Chiesa del Sacramento». Questa settorialità (riflessa anche nella strutturazione degli uffici pastorali, diocesani e nazionali) ha accentuato da una parte l’aspetto intellettualistico-dottrinale nella catechesi e dall’altra il ritualismo nella liturgia, non proponendo in modo convincente il legame con una «Chiesa della testimonianza».
In altri termini, il rapporto fede-vita è insufficiente senza il riferimento alla comunicazione della vita divina attraverso il sacramento. Il Documento pastorale dell’Episcopato Italiano è chiaro: «Dalla parola al Sacramento, alla vita nuova: questa la dinamica dell’esistenza cristiana», e richiama la prassi illuminata dai Padri della Chiesa[6].
La circolarità piena comporta il trinomio: fede-celebrazione-vita. Negli anni ’70 la difficoltà di leggere la «testimonianza nella vita» si manifesta già con il primo convegno ecclesiale Evangelizzazione e promozione umana (1976), ma si acuisce nel decennio seguente per il difficile confronto, soprattutto nel mondo laicale, tra chi si rifà alla cosiddetta «scelta religiosa» (AC) e chi sottolinea la necessità dell’immersione totale, anche politica, nelle lotte e nei conflitti storici (CL).
In quel clima, la Nota pastorale La Chiesa italiana dopo Loreto (1985) è preoccupata di declinare la carità piuttosto nella linea della comunione intraecclesiale, notevolmente scossa.
È indubbio che, nel frattempo, la Caritas italiana manifesta una progressiva vivacità. La Carta pastorale del 1995 (Lo riconobbero nello spezzare il pane, n. 27) lo evidenzia. L’obiezione di coscienza, la costituzione in buona parte delle chiese locali della Caritas diocesana, lo sviluppo e la strutturazione del volontariato, il sorgere di centri di ascolto e accoglienza, degli Osservatori permanenti dei bisogni e delle povertà, l’apertura alle urgenze internazionali, la Consulta ecclesiale degli organismi socio-assistenziali sono tappe di un denso cammino.
All’inizio degli anni ’80 il documento La Chiesa italiana e le prospettive del paese indica la strada del «ripartire dagli ultimi», ma, al di là di timidi cenni, il legame con la Parola e il Sacramento quasi scompare, o si limita a un generico richiamo al «primato della vita spirituale» (n. 13). Peraltro non mi sembra che in quel decennio, preoccupato prevalentemente dei rapporti intraecclesiali, si sia facilitata la traduzione nella pastorale delle parrocchie di quel prezioso documento della CEI: Eucaristia, comunione e comunità (1983).
Emerge che la funzione pedagogica, «centrale come intuizione nella filosofia dell’azione pastorale della Caritas», «è di difficile attuazione e non sembra costituisca una qualità affermata ed evidente dell’azione della Caritas» (Carta pastorale n. 31).
La via mistagogica
Il riferimento allo stile cristiano, precedentemente richiamato, mette in campo la necessità della formazione.
Forse dovremmo riprendere, approfondire e verificare quanto già dopo il Convegno ecclesiale di Palermo la Chiesa italiana aveva fortemente richiamato nella Nota pastorale del 1996 Con il dono della carità dentro la storia, nel capitolo sulla necessità della formazione: “Come tendere seriamente alla santità? Come maturare una spiritualità incarnata nella concretezza della vita quotidiana e della storia? Come diventare soggetti credibili della nuova evangelizzazione? Non c'è altra via se non quella di una seria formazione alla vita cristiana (…). Come Dio, nel suo rivelarsi, incontra l'uomo nel tempo, così l'educazione alla fede lo introduce passo dopo passo alla pienezza del mistero e si fa itinerario. Il primo itinerario da valorizzare è quello comune a tutto il popolo di Dio, l'anno liturgico, scandito dalla domenica, giorno del Signore e giorno della Chiesa, della Parola, dell'Eucaristia, della carità. A partire da questo fondamentale itinerario vanno poi sviluppati itinerari di vita cristiana diversificati, che tengano conto dell'età, del ruolo ecclesiale, dell'esperienza spirituale, della condizione familiare, culturale e professionale. Nel comune cammino dell'anno liturgico devono innestarsi attenzioni specifiche, perché la proposta non suoni generica, ma colga ciascuno nella propria concreta situazione. Perché l'esperienza di fede venga personalizzata, si valorizzino i luoghi in cui la persona esce dall'anonimato: la famiglia anzitutto, quindi la parrocchia, «casa aperta a tutti», le piccole comunità, i gruppi, le aggregazioni ecclesiali. Queste realtà possono diventare laboratori di preghiera, di rapporti umani e fraterni, di apostolato, di servizio ai poveri e alla comunità, di progettazione pastorale, culturale e sociale. Gli itinerari, diversi tra loro, devono comunque comprendere e fondere in una circolarità dinamica le tre dimensioni fondamentali della pastorale e della vita cristiana: annuncio, celebrazione e testimonianza” (nn. 13-15). Se siamo qui a ricordare queste parole, forse è perché le abbiamo dimenticate o forse non le abbiamo mai profondamente fatte nostre, ma è anche perché l’istanza educativa, cui la Chiesa italiana sta volgendo la sua attenzione in questo ultimo decennio, va presa sul serio e messa in atto attraverso itinerari formativi, piuttosto che esperienze occasionali.
Converrebbe, a tal proposito, rifarsi allo stesso titolo della Relatio finalis del Sinodo straordinario dei Vescovi del 1985, a vent’anni dalla conclusione del Concilio Vaticano II: Ecclesia sub verbo Dei mysteria Christi celebrans pro salute mundi[7]. Questa sintesi autorevole ripropone il
volto di una Chiesa che nella luce della Parola di Dio celebra i misteri di Cristo e si propone nel mondo come testimonianza dell’amore di Cristo.
Ecco cosa stava a cuore a Paolo VI: una corretta visione della Chiesa come soggetto di pastorale e l’inserimento della carità cristiana nella missione evangelizzatrice della Chiesa.
La rottura, nella nostra pastorale, tra il cammino della fede e il cammino della celebrazione liturgica si riflette anche sulla corretta esperienza della carità.
Come superare questa situazione d’«impasse» pastorale?
Il Rito dell’iniziazione cristiana degli adulti, che costituisce la forma tipica di ogni itinerario di fede, nelle Premesse indica la mistagogia come punto di incontro tra catechesi-liturgia-carità (vita).
Che cosa s’intende per mistagogia?
È l’ingresso nel mistero, l’inserimento sempre più profondo nel mistero di Cristo, che copre tutto l’arco della vita.
Sappiamo che le radici della mistagogia risalgono alla Tradizione dei padri della Chiesa, in particolare al periodo che va dal IV al VI secolo. L’impressionante parallelismo tra la situazione culturale e religiosa del tempo patristico e l’attuale condizione dell’uomo post-moderno e post-globalizzato[8], suggerisce di far riemergere l’inscindibile rapporto tra la fede celebrata e la fede vissuta. Se l’istanza etica è molto presente nella cultura contemporanea (neoebraismo), non dobbiamo dimenticare che una Chiesa che si presenti come «semplice custode dell’etica» (A. Dupront), si rivela incapace di rispondere alla «domanda di senso» che sale dal cuore dell’uomo contemporaneo.
Le esigenze morali devono essere percepite come epifania del mistero creduto e celebrato, perché le opere del cristiano sono sempre opera fidei.
La via mistagogica comporta l’educazione alla carità ecclesiale, che spinge la comunità cristiana a farsi solidale con gli uomini e le donne del proprio tempo e a servirli nella causa della loro piena promozione. «Ubi amor, ibi oculus»; è la «discretio caritatis». Una formazione catechetica e liturgica a nulla varrebbe senza l’educazione alla carità. E viceversa: non potrebbe esistere carità senza fede celebrata nel mistero cristiano. L’impegno educativo di questa prima parte del decennio pastorale 2010-2020 per un rinnovamento degli itinerari di iniziazione cristiana spero ne tenga conto.
Al rapporto fede-vita, conviene ripeterlo, va aggiunto l’inscindibile rapporto celebrazione-vita[9].
È la logica della sacramentalità.
ESERCIZIO DELLA CARITÀ E LOGICA SACRAMENTALE
Mentre da un lato, alla luce dell’impegno profuso nella “nuova evangelizzazione”, risulteranno certamente attuali – a proposito di memoria e fedeltà – i richiami magisteriali proposti, un passo avanti di natura profetica potrà forse condurci a pensare la carità nell’orizzonte della sacramentalità, con un’attenzione non meramente marginale alla dimensione “mistagogica” della fede e della prassi, che non va semplicemente evocata nell’ambito catechetico e liturgico, ma che va prospettata come scelta trasversale di tutto l’agire ecclesiale. Si tratta di abbandonare una visione unilateralmente ritualistica del Sacramento e dei segni sacramentali nel tentativo di innestare l’originaria sacramentalità di Cristo, della Chiesa, dei segni nel mondo che abitiamo. L’esercizio della carità profezia del Regno, vissuto nella memoria e nella fedeltà a Cristo, impone scelte radicali e al tempo stesso globali che coinvolgano le persone e le comunità in tutto il loro essere ed agire. Come il prete non è tale solo nel momento in cui celebra i sacramenti o prega la
liturgia delle Ore, ma sempre (il carattere imprime una svolta ontologica alla persona), come il cristiano non è tale solo quando partecipa alle funzioni religiose, così la carità non può parcellizzarsi in strutture o organizzazioni separate dal contesto ecclesiale, che ne costituisce il grembo.
Alcuni hanno gridato allo scandalo, quando hanno assistito, nella proiezione del film di Olmi, alla detronizzazione del crocifisso e all’occupazione dello spazio sacro da parte degli immigrati clandestini, senza riflettere sul fatto che la chiesa veniva abitata da croci di carne e da stigmate umane, che il crocifisso iconicamente esprime. Come pure sarebbe fuorviante stracciarsi le vesti di fronte alla scena del fonte battesimale che viene utilizzato per raccogliere l’acqua piovana (che, peraltro, scende dal cielo, in cui si riflette una vetrata colorata che reca il simbolo trinitario), poi riscaldata al fuoco dei ceri, per aiutare la puerpera africana nel parto. Come il fonte ci genera alla fede, così è la fede stessa ad imporci la custodia della vita e l’impegno per la sua strenua difesa.
Ecco allora i tre passaggi che siamo chiamati a compiere insieme, due dei quali appartengono al passato (memoria) e al presente (fedeltà) e il terzo al futuro (profezia) della riflessione ecclesiale sulla carità. Dall’attenzione degli anni ’90 all’innesto dell’agire caritativo come agape nella prospettiva dell’evangelizzazione, alle encicliche di papa Benedetto che ci hanno aiutato a pensare l’essere stesso di Dio come carità e il rapporto fra carità e verità (senza dimenticare la lettera sulla speranza, tutt’altro che estemporanea rispetto al tema degli altri due documenti), mettiamo in luce la sacramentalità della carità come possibilità di rilanciare lo stile cristiano nell’orizzonte della formazione, attraverso un’adeguata mistagogia dell’agire credente.
La sacramentalità della carità nel Verbo incarnato
In un tempo di “risveglio della gnosi”[10], è necessario vigilare sulla tentazione dualistica (corpo-spirito), che comporta il disprezzo per tutto quanto è mondano e carnale e quindi la negazione della storicità della rivelazione cristiana e dei suoi contenuti fondamentali quali l’incarnazione del Verbo e la risurrezione della carne di Cristo e nostra. Basterebbe la lapidaria espressione del Prologo del IV Vangelo a mostrare come la fede in Cristo escluda ogni forma di dualismo, perché il “Verbo si è fatto carne” (Gv 1,14). “Il Figlio di Dio divenne veramente uomo per salvare l’uomo”: così rispondeva il grande Ireneo di Lione (Adversus hereses) alla tentazione gnostica. Pur nel rispetto della specificità delle epoche storiche, quale profonda analogia – come ho già sottolineato – fra il nostro tempo e il proto cristianesimo e l’età patristica! E come è particolarmente attuale la figura di Cristo “grande mistagogo”, che, come tale ci pone al riparo dalle opposte tentazioni del falso spiritualismo del secolarismo mondanizzante! È quanto farà dire a S. Massimo di Torino: «in quell’uomo, Cristo, vi è una parte della carne e del sangue di ciascuno di noi… In Cristo la nostra carne ci ama» (in Christo caro nostra nos diligit)[11].
La sacramentalità del Verbo incarnato è stata di recente espressa, con una formula davvero innovativa nella dottrina del magistero ecclesiale, nella “sacramentalità della Parola”, fatta propria dall’Esortazione apostolica Verbum Domini di Benedetto XVI: “La Parola di Dio si rende percepibile alla fede attraverso il «segno» di parole e di gesti umani. La fede, dunque, riconosce il Verbo di Dio accogliendo i gesti e le parole con i quali Egli stesso si presenta a noi” (n. 56). È del tutto evidente che la sacramentalità (efficacia) della Parola trova la sua espressione nella capacità di realizzare la presenza di Dio nella storia, dell’Eterno nel tempo, dell’Invisibile nel visibile e tale sacramentalità si fonda sul mistero dell’incarnazione del Verbo.
L’esercizio della carità realizza e mostra questa presenza-assenza di Dio e la esprime nelle forme più diverse di attuazione e realizzazione. Nella Parola - lo ripeto - la carità prende forma, misura e motivo: la forma, la misura e il motivo dell’amore di Cristo, vangelo dell’amore di Dio da cui il discepolo impara “la Parola della Croce”, rivelazione dell’“amore più grande” (Gv 15,13), dell’“amore sino alla fine” (Gv 13,1).
La carità di Cristo (e nostra) attraverso le parole e i gesti
Il sacramento fondamentale che è Cristo esprime la propria identità in rapporto al Padre e a noi attraverso le sue parole e i suoi gesti. Basterà qui richiamare a titolo semplificativo la sua predilezione per gli ultimi e il miracolo della moltiplicazione dei pani. Mi limito a segnalare come, perché il miracolo accada, Gesù invita i discepoli alla condivisione del poco che hanno. Certamente se avesse prodotto il cibo dal nulla, il portento sarebbe risultato più eclatante, ma la dinamica sacramentale dell’atto d’amore ne avrebbe sofferto. È altresì importante rilevare – proprio nella prospettiva mistagogica che intendo adottare – come il gesto, nel IV vangelo, costituisca l’occasione per il discorso sul pane di vita, con i riferimenti eucaristici che la tradizione gli ha conferito e che ben conosciamo.
E dal punto di vista della parole di Gesù, come non rievocare la parabola del buon samaritano, che con profondità esegetica e teologica il compianto Vittorio Fusco ha definito una “parabola laica”, nell’orizzonte della sua interpretazione delle parabole come vere e proprie “frontiere del Vangelo” che, “senza cessare di essere dono che viene da Dio e non dagli uomini, si rivela però veramente rivolto agli uomini, capace di farsi carico dei loro interrogativi, di raggiungerli efficacemente […] nel vivo della loro esistenza”[12].
La sacramentalità della carità si esprime anche nella capacità dei nostri gesti di accoglienza, di soccorso, di amore di diventare parabole del Regno e della sua presenza nella storia.
Possiamo spingerci fino a tanto?
Nell’enciclica Deus Charitas est Benedetto XVI lo indica in modo ardito: “Dio […] questo principio creativo di tutte le cose – il Logos, la ragione primordiale – è al contempo un amante con tutta la passione di un vero amore. In questo modo l’eros è nobilitato al massimo, ma contemporaneamente così purificato da fondersi con l’agape” (n. 10). Questa visione erotico-agapica di Dio affonda le sue radici in un’antica tradizione (Agostino e Pseudo Dionigi) e ci dice che la passione cha anima la nostra azione creativa va riportata a questo fondamento teologico, che deve trasparire dal nostro fare e dire quotidiano, come dall’elaborazione dei nostri progetti e dall’articolazione delle nostre strutture caritative.
È una risposta ai nostri legittimi interrogativi sull’autenticità dell’esercizio della carità. Tutti abbiamo bisogno di purificare costantemente la nostra “passione caritativa” dai nostri “bisogni” psicologici e affettivi (eros), per spingerci verso quella carità «sulla misura del cuore di Cristo» (agape).
Sulla sacramentalità del Verbo incarnato, morto e risorto poggia e si fonda la Chiesa, chiamata a vivere, celebrare e annunciare l’unione fra Dio e il mondo e l’unità del genere umano. Una indicazione preziosa ci viene a questo riguardo dalla Dei Verbum: “la Chiesa nella sua dottrina, nella sua vita e nel suo culto, perpetua e trasmette a tutte le generazioni tutto ciò che essa è, tutto ciò che essa crede” (n. 8). Non si tratta dunque del fare, ma dell’essere. Si tratta della “contemporaneità” dell’evento salvifico, che l’Esortazione apostolica coglie in primo luogo come presenza (= parousia) nella Chiesa: “Il rapporto tra Cristo, Parola del Padre, e la Chiesa non può essere compreso nei termini di un evento semplicemente passato, ma si tratta di una relazione vitale in cui ciascun fedele è chiamato ad entrare personalmente. Parliamo infatti della presenza della Parola di Dio a noi oggi: «Ecco, io sono con voi tutti i giorni, sino alla fine del mondo» (Mt 28,20)” (Verbum Domini, n. 51).
L’Eucaristia fonte e culmine nell’esercizio ecclesiale della carità
Presenza che trova il suo culmine nell’Eucaristia: “Il Vangelo di Luca ci dice che «si aprirono loro gli occhi e lo riconobbero» (24,31) solo quando Gesù prese il pane, recitò la benedizione, lo spezzò e lo diede loro, mentre prima «i loro occhi erano impediti a riconoscerlo» (24,16). La presenza di Gesù, dapprima con le parole, poi con il gesto di spezzare il pane, ha reso possibile ai discepoli il riconoscerLo, ed essi possono risentire in modo nuovo quanto avevano già vissuto precedentemente con Lui: «Non ardeva forse in noi il nostro cuore mentre egli conversava con noi lungo la via, quando ci spiegava le Scritture?» (24,32). Da questi racconti emerge come la Scrittura stessa orienti a cogliere il suo nesso indissolubile con l’Eucaristia. […] Parola ed Eucaristia si appartengono così intimamente da non poter essere comprese l’una senza l’altra: la Parola di Dio si fa carne sacramentale nell’evento eucaristico. L’Eucaristia ci apre all’intelligenza della sacra Scrittura, così come la sacra Scrittura a sua volta illumina e spiega il Mistero eucaristico. In effetti, senza il riconoscimento della presenza reale del Signore nell’Eucaristia, l’intelligenza della Scrittura rimane incompiuta” (Verbum Domini, nn. 54-55). Tutto questo trova nella presenza reale eucaristica (nelle specie) il suo culmine e il suo luogo concreto di massima espressione e realizzazione non solo nel momento propriamente liturgico-cultuale, ma in tutta la vita della Chiesa e del cristiano, che in questo senso, si configura come vita eucaristica.
Non costituisce questa una rilettura, in prospettiva mistagogica, del progetto pastorale Evangelizzazione e sacramenti, con riferimento alla vita, ala storia, all’esercizio della carità?
Il legame tra Eucaristia e solidarietà con i poveri (ed esigenza di giustizia sociale) è stato un tema intensamente sentito e dibattuto nella Chiesa nel corso degli anni sessanta e settanta. Oggi non lo è più. Come comunità cristiana, avremmo invece bisogno, di fronte all’attuale crisi economica e alle cause che l’hanno generata, di verificare, attraverso soprattutto l’ascolto della predicazione apostolica e la dottrina dei Padri, in che modo abbiamo, negli ultimi decenni, vissuto e compreso la dimensione etica della liturgia e l’istanza di condivisione dei poveri insita nell’Eucaristia.
Ultimamente, in ragione della crisi economica, sono risuonate nella Chiesa e anche nella società parole dimenticate come sobrietà, condivisione, solidarietà, gratuità, parole autenticamente evangeliche e ricche di umanità.
Ma per la comunità dei credenti in Cristo non vi può essere altra koinonia, altra autentica carità se non quella che nasce dalla «tavola del Signore» (1Cor 10,21).
Gli interrogativi che l’apostolo Paolo rivolge nella Prima Lettera alla comunità cristiana di Corinto diventano fonte per comprendere che l’essere e l’agire della Chiesa e di ogni cristiano dipendono, nel bene come nel male, dalla loro corretta prassi eucaristica.
In una catechesi sulla Seconda Lettera ai Corinti, a proposito della colletta che Paolo comprende come liturgia (2Cor 8 e 9), Benedetto XVI afferma: “amore per i poveri e liturgia divina vanno insieme, l’amore per i poveri è liturgia. I due orizzonti sono presenti in ogni liturgia celebrata e vissuta nella Chiesa, che per sua natura si oppone alla separazione tra il culto e la vita, tra la fede e le opere, tra la preghiera e la carità per i fratelli” (Udienza generale, 1° ottobre 2008)[13].
Tutti conosciamo bene la comprensione che Giovanni Crisostomo aveva dell’amore dei poveri come liturgia: “Ogni volta che vedete un povero ricordatevi che sotto i vostri occhi avete un altare” (Commento alla seconda lettera ai Corinti, Omelia 20,3).
La prospettiva eucaristica non deve tuttavia farci dimenticare la necessità di porre l’azione caritativa in rapporto all’intero settenario sacramentale, di cui il Battesimo è porta (ianua sacramentorum). Così, schematicamente, possiamo esprimere questi riferimenti dell’attività caritativa al Battesimo, in quanto essa esprime l’appartenenza cristiana e la configurazione del credente al Verbo incarnato che lo ha redento con la sua passione e risurrezione. Il riferimento alla Confermazione dice la necessità di esercitare la carità secondo la forma di una fede adulta e formata, non ingenua o spontaneistica e in ascolto dello Spirito, che anima e suscita le diverse forme di servizio che nella Chiesa si realizzano. Ma nell’Eucaristia partecipa una comunità che ha sperimentato la misericordia di Dio e dei fratelli, per cui la suprema carità da promuovere e incoraggiare è quella del perdono e della Riconciliazione, nei diversi ambiti della vita ecclesiale e sociale. Nei sacramenti dell’Ordine e del Matrimonio la carità va vista nelle dimensioni della necessità della sua strutturazione, intorno al ministero della Parola e del sacramento e della custodia vigile della famiglia e della vita. Infine il riferimento all’Unzione ci porta a riflettere sulle fragilità e sui limiti della condizione umana che col nostro impegno cerchiamo di incrociare e di alleviare.
Ma, più in profondità, la tradizione ci insegna che i sacramenti sono “segni efficaci della grazia”, ossia luoghi e momenti nei quali siamo chiamati a sperimentare la gratuità della salvezza che il Signore ci offre. Ciascun sacramento in modo proprio è segno efficace della carità di Cristo in noi.
Nei sacramenti celebriamo dei segni efficaci di un amore che non è prestazione ma grazia, dono dello Spirito di Dio che è in noi luce e virtù di carità: luce per conoscere “la carità di Cristo che sorpassa ogni conoscenza” (Ef 3, 19); virtù che abilita a tradurla nella singolarità e concretezza della vocazione e del ministero di ciascuno. Sappiamo che si tratta di una “grazia a caro prezzo” (D. Bonhoeffer) e in quanto tale di un dono impegnativo ed esigente e sappiamo anche a quanti fraintendimenti può essere esposto l’esercizio della gratuità nell’orizzonte del mercato globale. Certo, il dono mette in atto un’asimmetria fra chi offre e chi riceve, ma tale sproporzione è plausibile solo nei confronti di Colui a cui dobbiamo tutto, laddove il nostro rapporto agapico coi fratelli (destinatari) della nostra azione caritativa non potrà che suscitarne il riscatto e determinarne la possibilità di autentici rapporti di reciprocità, di uguaglianza e di giustizia.
Sulla “logica del dono” basterà rimandare ad alcuni passaggi decisivi della Charitas in Veritate: “La carità nella verità pone l'uomo davanti alla stupefacente esperienza del dono. La gratuità è presente nella sua vita in molteplici forme, spesso non riconosciute a causa di una visione solo produttivistica e utilitaristica dell'esistenza. L'essere umano è fatto per il dono, che ne esprime ed attua la dimensione di trascendenza” (n. 34). In particolare, come suggerisce il titolo evocativo e al tempo stesso problematico di un bel libro del filosofo Jacques Derrida[14], si tratta non solo di donare delle cose, dei beni, degli oggetti, bensì di “donare il tempo”, così come accade nell’esperienza del volontariato che le nostre caritas conoscono molto bene. Siamo di fronte ad un bene prezioso e raro, dal momento che ci sembra mancare sempre più, tanto che non ne abbiamo mai abbastanza per noi stessi e per gli altri. In questa prospettiva la sacramentalità della carità va pensata in relazione alla temporalità anacronistica della celebrazione e della festa (domenica), dove il chronos che divora i suoi figli (ricordate l’inquietante quadro di Goya) è sospeso, perché venga abitato dal kairòs della grazia della divina presenza. È un modo di declinare la testimonianza dei martiri di Abitene: senza la domenica non possiamo vivere, cioè senza l’Eucaristia, senza la Chiesa, senza il giorno del Signore.
GLOBALIZZARE LA SOLIDARIETÀ
Il vescovo Helder Camara, «fratello dei poveri» come lo ha definito il beato Giovanni Paolo II durante il suo viaggio a Recife, nel 1971 si domandava: “Quando l’Eucaristia è ricevuta al momento della morte è chiamata viatico: è il compagno per il grande viaggio cha ha inizio. Ma come chiamare l’Eucaristia ricevuta per vivere e far vivere la giustizia? Non facciamoci illusioni: il mondo conosce molto bene lo scandalo. Sono cristiani, almeno di origine, quel venti per cento di umanità che tiene nelle sue mani l’ottanta per cento delle risorse della terra. Che ne abbiamo fatto dell’Eucaristia? Come conciliarla con l’ingiustizia, figlia dell’egoismo?”.
Oggi più che mai il gesto eucaristico della fractio panis (klàsma, «spezzato» è il nome più antico attestato dalla Didaché 9,4) è il più grande gesto profetico con il quale la Chiesa testimonia l’amore di condivisione con i poveri nella solidarietà e nella giustizia.
Se è vero che l’esercizio della carità senza la fonte della Parola e dell’Eucaristia scivola nell’attivismo, dobbiamo riconoscere che la natura profetica ed etica della liturgia è costantemente esposta al pericolo di essere sopraffatta dalla dimensione rituale. Il fine della liturgia non è la sacramentalizzazione del credente, ma la sua santificazione.
Vorrei ritornare al film di Olmi e alla sua significazione «profetica» nell’affrontare il tema dell’immigrazione. All’Autore interessa particolarmente l’atteggiamento del cristiano (non a caso
presenta il personaggio del prete che prende posizione in modo sempre più netto e deciso a favore degli ultimi): può una persona definirsi cristiana se non riesce a vedere nei poveri, il volto di Cristo? Verso la fine del film il prete, che in precedenza si era aggrappato al tavolo dell’altare tentando di celebrare messa, confiderà: «Anche per me comincia il viaggio di ritorno verso la casa del padre». Se «viatico» è uno dei nomi tradizionali dell’Eucaristia - coma ha ricordato Helder Camara -, vorrei concludere richiamando la riserva escatologica, cui ho accennato all’inizio, che ha ispirato lo sguardo di fede di Giovanni Paolo II sull’Europa ed ha trovato espressione nell’esortazione apostolica Ecclesia in Europa, dove il Papa non manca di misurarsi col processo della globalizzazione. È infatti l’icona dell’Apocalisse che domina tutta la riflessione, che non assume affatto toni apocalittici, ma intende orientare ed infondere speranza ai cittadini di questo vecchio e insieme nuovo continente. Mi limito qui a richiamare il discernimento e l’orientamento che, proseguendo la riflessione già avviata nel discorso alla Pontificia Accademia delle Scienze Sociali del 27 aprile 2001, così si esprime: «Dire “Europa” deve voler dire “apertura”. Nonostante esperienze e segni contrari che pure non sono mancati, è la sua stessa storia ad esigerlo: l’Europa non è in realtà un territorio chiuso o isolato; si è costruita andando incontro, al di là dei mari, ad altri popoli, ad altre culture, ad altre civiltà». Perciò deve essere un Continente aperto e accogliente, continuando a realizzare nell’attuale globalizzazione forme di cooperazione non solo economica, ma anche sociale e culturale. C’è un’esigenza alla quale il Continente deve rispondere positivamente, perché il suo volto sia davvero nuovo: «L’Europa non può ripiegarsi su se stessa. Es-sa non può né deve disinteressarsi del resto del mondo, al contrario deve avere piena coscienza del fatto che altri Paesi, altri Continenti, si aspettano da essa iniziative audaci per offrire ai popoli più poveri i mezzi per il loro sviluppo e la loro organizzazione sociale, e per edificare un mondo più giusto e più fraterno». Il tema dell’immigrazione vi è totalmente inserito.
Per realizzare in modo adeguato tale missione, sarà necessario «un ripensamento della cooperazione internazionale, nei termini di una nuova cultura di solidarietà. L’Europa, inoltre, deve farsi parte attiva nel promuovere e realizzare una globalizzazione “nella” solidarietà. A quest’ultima, come sua condizione, va accompagnata una sorta di globalizzazione “della” solidarietà e dei connessi valori di equità, giustizia e libertà, nella ferma convinzione che il mercato chiede di essere «opportunamente controllato dalle forze sociali e dallo Stato, in modo da garantire la soddisfazione delle esigenze fondamentali di tutta la società». Mi sembra interessante notare come queste riflessioni siano incastonate nel capitolo dedicato al vangelo della speranza per un'Europa nuova, che si ispira all'espressione biblica: «Vidi anche la città santa, la nuova Gerusalemme, scendere dal cielo» (Ap 21,2).
© www.caritasitaliana.it, 21 novembre 2011
[1] “Il più considerevole nella nostra epoca preoccupante è che noi ancora non pensiamo” (M. HEIDEGGER, Che cosa significa pensare? Chi è lo Zarathustra di Nietzsche, Sugarco, Milano 1971, 39).
[2] Cfr. U. BECK, Che cos’è la globalizzazione. Rischi e prospettive della società planetaria, Carocci, Roma 1999; Id., I rischi della libertà. L’individuo nell’epoca della globalizzazione, Il Mulino, Bologna 2000; Id., La società del rischio. Verso una seconda modernità, Carocci, Roma 2000: Id., Libertà o capitalismo. Varcare la soglia della modernità, Carocci, Roma 2001.
[3] Cit. in M. AIME, Eccessi di culture, Einaudi Torino 2004, 123.
[4] G. FLAUBERT, Memorie di un folle, il Sole 24 ore, Roma 2011, 64.
[5] A. ROSMINI, Costituzioni dell’Istituto della Carità, Città Nuova – CISR, Roma – Stresa 1996, 468s.
[6] CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Evangelizzazione e sacramenti, 50-51; 63-65.
[7] Per questo cfr. F. CACUCCI, Ecclesia sub verbo Dei, in ASSOCIAZIONE TEOLOGICA ITALIANA, “A misura di Vangelo”. Fede, dottrina, Chiesa (a cura di M. VERGOTTINI), San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi) 2003, 205-228.
[8] Cfr. P. POUPARD, Il cristianesimo all’alba del terzo millennio, Piemme, Casale Monferrato 2000, 67.
[9] Cfr. F. CACUCCI, Catechesi liturgia vita, EDB, Bologna 2000.
[10] Cfr. G. FILORAMO, Il risveglio della gnosi ovvero diventare dio, Laterza, Bari 1990.
[11] Sermo 30, PL 57, 593; 594. Su Cristo, il grande mistagogo, cfr. F. CACUCCI, La mistagogia: una scelta pastorale, EDB, Bologna 2006, 29-32.
[12] V. FUSCO, Oltre la parabola. Introduzione alle parabole di Gesù, Borla, Roma 1983, 191.
[13] In Osservatore Romano, 2 ottobre 2008, Anno CXLVIII n. 230 (44.970), pg. 1.
[14] Cf J. DERRIDA, Donare il tempo. La moneta falsa, Raffaello Cortina, Milano 1996.