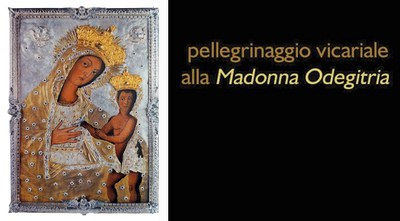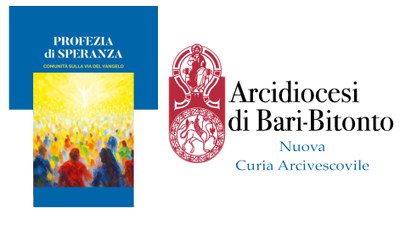Opere di misericordia e non parole per riformare la Chiesa

In tre atti che restano miliari, tutti da meditare ancora per lo spessore, l’introspezione e la profondità che hanno espresso, papa Francesco ha sviscerato nel giorno centrale del Giubileo dei preti – giovedì scorso – tutto il senso della misericordia. Nel succo di questo senso, tutto da meditare non solo per i preti, c’è anche questa considerazione: «L’amore va posto più nelle opere che nelle parole». Quali opere? «Quelle che il Padre 'ha preparato perché in esse camminassimo' ( Ef 2,10), quelle che lo Spirito ispira a ciascuno per il bene comune (cfr 1 Cor 12,7)». Perciò si deve desiderare e chiedere – ha detto Francesco – anche uno sguardo che impari a discernere i segni dei tempi nella prospettiva di quali opere di misericordia sono necessarie oggi per la gente, «per poter sentire e gustare il Dio della storia che cammina in mezzo a noi» e perché «nelle nostre opere il nostro popolo sa che comprendiamo il suo dolore». Quindi, senza ipocrisia, «ora si tratta di 'agire', e non solo di compiere gesti ma di fare opere, di istituzionalizzare, di creare una cultura della misericordia, che non è lo stesso di una cultura della beneficenza». E ha spiegato: «Non è questione che Dio mi usi misericordia in qualche mancanza, come se nel resto io fossi autosufficiente, o che ogni tanto io compia qualche atto particolare di misericordia verso un bisognoso. La grazia che chiediamo è quella di lasciarci usare misericordia da Dio in tutti gli aspetti della nostra vita e di essere misericordiosi con gli altri in tutto il nostro agire. Essere misericordioso non è solo un modo di essere, ma il modo di essere».
Se dunque la misericordia «è il modo di essere», non un’idea, né un vago sentimento della nostra fede che galleggia a mezz’aria senza trovare quella concretezza necessaria in cui esprimersi e realizzarsi, la carità non si dice, ma si fa. E facendola la si riceve. Da qui la tradizione spirituale e catechistica che vede nelle opere di misericordia corporale e spirituale la via per esprimere e praticare l’amore che sa comprendere la miseria dell’uomo e contribuisce al suo riscatto. Opere che nel loro insieme sono infinite, perché l’oggetto della misericordia è la vita umana nella sua totalità, nei suoi bisogni in quanto carne e in quanto spirito. E non v’è dubbio che se queste fossero praticate nel loro insieme cambierebbero la società. Sono del resto lo specchio della famosa «Regola d’oro» del fare agli altri quello che vorresti fatto a te. Sono la forza propulsiva per una prassi che ha conseguenze incisive in una strutturazione umanamente degna e giusta dell’ordine sociale-politico che permetta di vivere come esseri umani e non come bestie. Basta pensare all’opera di misericordia corporale di accogliere lo straniero, nel contesto attuale della questione delle migrazioni, o alla richiesta di visitare malati, che può essere messa in relazione con l’attuale economicizzazione e conseguente anonimizzazione del sistema sanitario.
E non v’è neppure dubbio che in esse si gioca anche la stessa credibilità della Chiesa. San Tommaso d’Aquino le chiama summa religionis christianae. Perché sono il segno di un’unione indissolubile, che è quintessenza, somma e compendio dell’esistenza cristiana: l’amore di Dio e l’amore del prossimo. Quindi seguirle è de facto la riforma stessa della Chiesa. Perché prima di tutto esprimono la riforma operata dalla misericordia in noi stessi. «Siate misericordiosi come è misericordioso il Padre vostro» è perciò l’imperativo evangelico che per Francesco si è fatto pontificato, già prima della sua elezione. E già prima dell’indizione dell’anno giubilare della misericordia se n’è fatto segno e strumento. Partendo dagli ultimi, guardando cioè in particolare ai bisogni concreti dei poveri e dei sofferenti, che sono i prediletti del Vangelo, nei quali si fa incontro Cristo stesso. Tra le tante attenzioni nei confronti dei poveri, compresa quella di aprire loro le porte della Cappella Sistina, come Vescovo di Roma ha fatto realizzare le docce per i clochard, i pellegrini mendicanti e i senza tetto sotto il Colonnato del Bernini in San Pietro e ha completato il progetto di aumentare quest’opera – attraverso le parrocchie romane che vi hanno aderito – anche con la disponibilità di un servizio ad hoc per la loro cura. Così è anche per l’aiuto offerto – tramite l’Elemosinerìa apostolica – a numerose famiglie disagiate, insolventi e a rischio sfratto a pagare le bollette. Così è per i 50mila euro che ha fatto donare al Centro Astalli per il pagamento delle spese di rilascio dei documenti necessari ai richiedenti asilo. Ma è solo qualche esempio di molta altra carità operosa e discreta.
A questa cultura della misericordia, che non si limita all’aiuto materiale ma tutto comprende, si affiancano gesti che lo vedono agire in prima persona, secondo il 'fuori orario' di un calendario riformato dal paradigma dell’amore, inteso proprio come l’unum necessarium. Così, proprio sul tracciato delle opere di misericordia, alla vigilia dell’apertura della Porta Santa in San Pietro, Francesco aveva annunciato che ogni venerdì del mese avrebbe anche compiuto un gesto diverso. Il 18 dicembre 2015 è infatti andato dritto all’Ostello della Caritas 'Don Luigi Di Liegro' presso la Stazione Termini di Roma dove ha aperto la Porta Santa della Carità. E a coloro che si proclamano cristiani in quell’occasione ha voluto ribadire in termini molto semplici che «Gesù, quando ci predica la vita, ci dice come sarà il giudizio nostro. Non dirà: tu vieni con me perché hai fatto tante belle offerte alla Chiesa, tu sei un benefattore della Chiesa, vieni in cielo. No. L’entrata in cielo non si paga con i soldi. Non dirà: tu sei molto importante, hai avuto tante onorificenze, vieni. No. Cosa ci dirà Gesù per aprirci la porta del cielo? 'Ero affamato e mi hai dato da mangiare; ero senzatetto e mi hai dato una casa; ero ammalato e sei venuto a trovarmi; ero in carcere e sei venuto a trovarmi'».
E ha aggiunto, tanto per essere ancora più chiari: «Nell’aprire questa Porta Santa, io vorrei che lo Spirito Santo aprisse il cuore di tutti e facesse loro vedere qual è la strada della salvezza! Non è la strada delle ricchezze, non è la strada del potere. È la strada dell’umiltà. E i più poveri, gli ammalati, i carcerati – Gesù dice di più – ci precederanno in cielo. Loro hanno la chiave. Colui che compie opere di carità è colui che si lascia abbracciare dalla misericordia del Signore». Da qui non una cultura della beneficenza ma lo stile di vita di una cultura della misericordia che rende testimoni credibili.
Da venerdì 15 gennaio 2016 «i venerdì delle opere di misericordia» sono quindi entrati nella pratica a pieno ritmo, con la visita a sorpresa a una casa di riposo per anziani nella periferia di Roma e in un Centro di degenza per malati neurologici in stato vegetativo davanti ai quali il Papa si è inginocchiato. A un mese di distanza, venerdì 16 febbraio, è stata la volta di un’altra visita a sorpresa alla Comunità San Carlo, nei pressi di Castelgandolfo, sede del Centro italiano di solidarietà fondato da don Mario Picchi, sorto per prevenire e contrastare l’esclusione sociale e le tossicodipendenze. La comunità, con i 55 ospiti che stanno compiendo un percorso per uscire dalla dipendenza dalle droghe, si è vista arrivare del tutto a sorpresa il Papa che voleva trascorrere con loro il pomeriggio. Il 24 marzo è toccato al Centro di accoglienza per immigrati e rifugiati di Castelnuovo di Porto, a poca distanza da Roma. Nella cornice delle visite della misericordia si include anche il viaggio del 16 aprile nell’isola greca di Lesbo per incontrare i rifugiati del Moria refugee camp insieme ai patriarchi della Chiesa ortodossa.
Il 13 maggio Francesco è invece uscito dal Vaticano per incontrare una comunità che ospita persone con grave disabilità mentale, appartenente alla grande famiglia dell’Arche fondata da Jean Vanier nel 1964 e dedicata alle persone più deboli ed emarginate della società. Papa Francesco è arrivato alle cinque del pomeriggio e si è seduto a tavola per fare merenda con i 18 disabili e i volontari. Ha ascoltato le loro semplici parole condividendone familiarmente le necessità. Tutto questo sono le opere della riforma dell’amore. Sono opere che si offrono come esempio vissuto «perché in esse camminassimo», mentre le future visite rinnoveranno ancora, attraverso gli ultimi, la sorpresa dell’abbraccio di Dio a Francesco. La prossima ha già una data: 18 giugno, al Collegio Universitario Villa Nazaret.
Stefania Falasca
© Avvenire, 9 giugno 2016