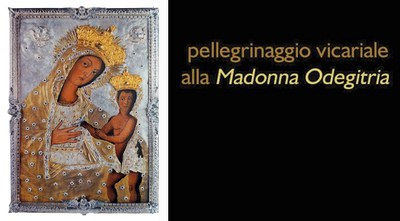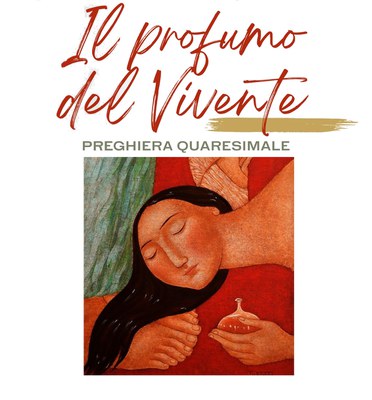Ridere? Roba da gente viva

Come si acquista il senso dell’humour? E come incide l’ambiente in cui si è formato sui suoi caratteri? Me lo sono chiesto spesso, partendo dai diversi modi di reagire, nelle persone che ho conosciuto e frequentato, a una battuta, a una barzelletta, a un incidente un tantino bizzarro. Constatando la diversità e, a volte, più spesso di quanto non si creda, la refrattarietà all’humour di molte persone.
C’entra per qualcosa il dna, probabilmente: non tutti si nasce con le stesse disposizioni, le stesse qualità, gli stessi caratteri, e si deve spesso constatare che c’è chi nasce senza il senso dell’humour, così come c’è chi nasce con una sensibilità e una reattività molto acuta verso certe cose e molto opaca verso altre. L’assenza di humour mi pare una mancanza grave, che impedisce di ridere, per esempio, dei modi spesso assurdi in cui il potere si manifesta, o dei difetti vistosi o nascosti dei nostri connazionali, del nostro prossimo.
Tanto più oggi che l’humour è gestito anzitutto da disgustosi comici televisivi, dai film-panettone di Aurelio De Laurentiis, da una satira politica rozza e volgare quanto i nostri politici: per un unico Altan, quanti figli di Forattini! Gli italiani degli anni dal dopoguerra agli anni ottanta si sono formati su un humour alla Topolino e Paperino, affidati, com’è noto, all’inventiva di sceneggiatori nostrani e non americani, e sulle meravigliose tavole tutto-pieno di Jacovitti, e sui comici del cinema, su Totò, Sordi e Peppino De Filippo, prima che sorgesse, per i meglio alfabetizzati, l’astro di Charlie Brown e della benemerita "Linus". Appartengo a quella generazione, e per di più ai suoi ambienti meno privilegiati, e il mio senso dell’humour è nato così, ma con il privilegio di un rapporto molto diretto con quanto ancora viveva di tradizioni più antiche, più "popolari" nel senso di un radicamento nella cultura di un passato in cui il popolo davvero creava la propria cultura, più o meno ricettiva verso quella ufficiale e comunque adattandola ai propri bisogni.
Ho visto da bambino gli spettacolini invernali (i "sega-la-vecchia" su copioni immutabili) a cui si dedicavano i contadini più arditi in certe sere di veglia, in Umbria; ho amato i poveri circhi con i loro poveri clown, e i ciarlatani di fiera, immortalati da Fellini in La strada e in tutta la sua opera; ho visto in più città avanspettacoli con comici di secondo e terzo e infimo grado, e a Napoli le sceneggiate, con le loro parti comiche indispensabili a interrompere il flusso di grandi storie passionali, e a Palermo l’ultima opera dei pupi e le rozze storie comiche di ’Nofrio. E ho sempre provato una sorta di istintiva venerazione per chi sapeva far ridere, sopra ogni altro, per Totò. Il teatro e la musica (per restare a Napoli, ma il discorso valeva per tutta l’Italia) erano le forme d’espressione più proprie agli analfabeti, quando chi sapeva leggere e scrivere in Italia era una minoranza. E gli analfabeti avevano una cultura e una storia non scritte, o che non erano in grado di leggere.
D’altronde, il rapporto tra cultura alta e cultura bassa, come insisteva una gran donna come la Woolf, era stato sempre intenso e di gran nutrimento per entrambe, da Dante a Shakespeare, da Rabelais a Molière, da Dickens a Tolstoj. Poi, diceva sempre la Woolf, ha vinto la medietà, la cultura media prodotta dall’enorme sviluppo del ceto medio, e oggi da quei "cafoni con laurea", funzionari e prof che si sono messi freneticamente a servizio degli interessi delle multinazionali della "cultura", di un potere che ha appreso, negli anni ’30 dei Goebbels, degli Stalin, di Cinecittà e di Hollywood, come si governi più facilmente se si conquista il consenso delle masse, un consenso che non riguarda dei prodotti particolari ma un intero modello di vita, l’american way of life. imposto dai forti all’umanità tutta.
Era cultura alta o bassa, Charlot? Il mio primo film di Chaplin fu Il dittatore. La guerra era finita da poco, avevo otto anni e lo vidi in un cinema di paese affollato all’inverosimile, stretto tra mia madre e una zia che, nelle scene del Duce e del Führer dal barbiere, rise così tanto da cadere dalla sedia. Mia madre e mia zia di che ridevano, se non degli spettri concreti, degli spettri armati che avevano prima invaso e poi rovinato la loro giovinezza? Ridevano perché erano, eravamo, ancora vivi. Di che rideva mio padre con i suoi amici raccontando all’osteria la scena del "pesce democristiano" in Fifa e arena? E di che ridevano i disoccupati napoletani di ieri vedendo, ancora Totò, ma prima ancora Petito e Scarpetta e tanti, tantissimi altri, nelle infinite gag alla Miseria e nobiltà che riguardavano la fame e le mille pulcinellesche fatiche per riuscire a fine giornata a calmare la pancia? (Che differenza, da chi ride con De Sica e Boldi sotto Natale perché ha mangiato e bevuto troppo!).
Era questo a farmi ridere, e solo col tempo il mio senso dell’humour si è affinato, oltre Ollio e Stanlio e Jerry Lewis, con la finezza e la leggerezza degli inglesi, da Chesterton ad Alec Guinness e degli italiani della svagata moderazione critica alla Benni, o con la cupezza del bretoniano humour nero, con l’assurdo di Ionesco e di chi attendeva o attende un Godot che si guarda bene dal palesarsi… L’humour ha preso, negli ultimi anni, una deriva strana: non si ride molto, e se si ride si ride sguaiati, da arricchiti che più volgari non si può. Non ci appartengono più le finezze, ma non ci appartengono più neanche le pesantezze, le grevità sostanziose. Per esempio, esistono siti "comici" nella rete? Mah, direi di no, e se ci sono si tratta, quasi alla lettera, di robaccia… Non una comicità da bambini, però, bensì da robot. O da morti, come nelle vignette e nelle stampe di José Guadalupe Posada che mi appaiono più attuali che mai, da morti che ridono tra loro e non hanno memoria di quando erano vivi. O che ridono della vita, di noi stupidi viventi.
Molti anni fa, quando decisi di piantare una Milano piena di violenza e trasferirmi a Napoli per occuparmi ancora una volta di bambini (il modo più sano di pensare alla rivoluzione!) la mia curiosità per quella cultura era enorme, attizzata dai film, dai libri, dalla radio. Nelle prime settimane di ambientamento dedicai molto tempo a "censire" per mio diletto e conoscenza tutti i luoghi di spettacolo allora attivi, che erano tanti. Un bagno di stupefazione e a tratti di felicità, al cui culmine posi due comici che mi parvero gli ultimi geniali rappresentanti di una tradizione sublime, Beniamino Maggio e Dolores Palumbo. (Una domenica mattina d’estate, quasi all’alba, mi imbattei per strada in Tina Pica che stava entrando con un’altra signora in una chiesa, e la seguii per osservarla da lontano…).
Quella di Beniamino era un comicità antichissima e modernissima, fatta di allusioni e piccoli tocchi, era delicatissima, aerea, essenziale, astratta; Dolores Palumbo la ricordo nel suo numero più celebre, quello della risata, quando si piazzava al centro del palcoscenico e guardava il pubblico e cominciava a ridere finché gli spettatori, per puro contagio, non la imitavano, perdendo ogni freno: qualcosa di fisiologico e, come dire?, di lombrosiano… una immediata rivelazione dell’assurdo…
Ma già l’incantesimo traballava, la sceneggiata moriva, la televisione dominava. E al Salone Margherita, in Galleria, un sotterraneo fatiscente e immemore della gloria passata, diventato un rifugio di pensionati e di drogati, vidi un vecchio comico, alle cui battute nessuno rideva e a cui nessuno prestava ascolto, gridare verso la sala: «Non ridete? Cosa devo fare per farvi ridere? Questo?». Come in un raptus, voltò le spalle al pubblico e si calò i pantaloni mostrando il sedere. Qualche anno dopo ci fu il terremoto, e la mutazione (il "genocidio" secondo Pasolini) colpì definitivamente anche l’ultima roccaforte popolare, distruggendo un popolo, la sua identità, le sue tradizioni secolari. I robot non sanno cos’è ridere, e oggi, in verità, c’è poco da ridere.
© Avvenire, 2 agosto 2012