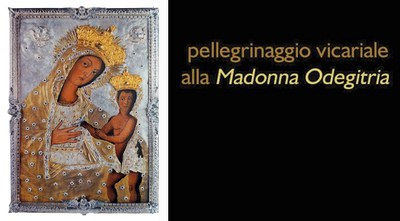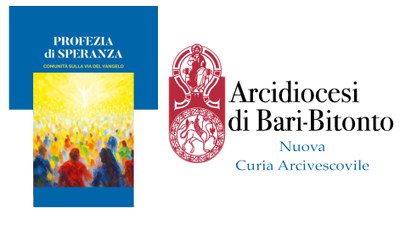Seminari, da 450 anni «vivaio» della Chiesa
 Il 4 dicembre 2013 ricorreranno i 450 anni dalla chiusura del Concilio di Trento (1545-1563) ma prima ancora (15 luglio) è stato importante fare memoria del giorno in cui i Padri conciliari approvarono all’unanimità il decreto Cum adolescentium aetas, che raccomandava l’erezione del Seminario in ogni diocesi. Un provvedimento di rilevanza epocale, che dotava la Chiesa di uno strumento per la cura delle vocazioni al sacerdozio ordinato, ancora oggi fondamentale e imprescindibile. Il Concilio di Trento ha rappresentato uno degli snodi più significativi della storia della Chiesa perché, raccogliendo e canalizzando gli impulsi positivi provenienti da vari ambienti del mondo cattolico, dette concretezza e sistematicità a un anelito alla riforma della Chiesa largamente condiviso attivando la formazione di un modello ecclesiale, destinato a durare nei secoli, che doveva cominciare con un cambiamento radicale che investisse innanzitutto i pastori, cioè i vescovi e i sacerdoti. Le emergenze su questo fronte erano numerose, relative alla residenza, all’assegnazione dei benefici ecclesiastici, alla cultura, al celibato e, più in generale, alla moralità e alla spiritualità dei chierici e, per quanto riguarda i vescovi, all’obbligo della cura pastorale e spirituale (anche catechetico e omiletico) del gregge a essi affidato.
Il 4 dicembre 2013 ricorreranno i 450 anni dalla chiusura del Concilio di Trento (1545-1563) ma prima ancora (15 luglio) è stato importante fare memoria del giorno in cui i Padri conciliari approvarono all’unanimità il decreto Cum adolescentium aetas, che raccomandava l’erezione del Seminario in ogni diocesi. Un provvedimento di rilevanza epocale, che dotava la Chiesa di uno strumento per la cura delle vocazioni al sacerdozio ordinato, ancora oggi fondamentale e imprescindibile. Il Concilio di Trento ha rappresentato uno degli snodi più significativi della storia della Chiesa perché, raccogliendo e canalizzando gli impulsi positivi provenienti da vari ambienti del mondo cattolico, dette concretezza e sistematicità a un anelito alla riforma della Chiesa largamente condiviso attivando la formazione di un modello ecclesiale, destinato a durare nei secoli, che doveva cominciare con un cambiamento radicale che investisse innanzitutto i pastori, cioè i vescovi e i sacerdoti. Le emergenze su questo fronte erano numerose, relative alla residenza, all’assegnazione dei benefici ecclesiastici, alla cultura, al celibato e, più in generale, alla moralità e alla spiritualità dei chierici e, per quanto riguarda i vescovi, all’obbligo della cura pastorale e spirituale (anche catechetico e omiletico) del gregge a essi affidato.
A Trento ci si sforzò di affrontarle mediante decreti dottrinali che precisavano – segnatamente sia in risposta alle affermazioni di Lutero e degli altri “riformatori”, sia nel rilancio delle tante istanze di riforma presenti nell’episcopato europeo – la sostanza teologica di alcuni elementi cardine della fede cattolica, e di riforma, per fornire soluzioni il più possibile concrete alle varie urgenze della vita ecclesiale, attraverso esortazioni e prescrizioni canoniche. Come ha osservato il grande storico del Concilio di Trento circa la rivoluzione protestante, Hubert Jedin, «la crisi dello scisma è stata in ultima analisi la crisi della formazione sacerdotale». Di questo dato i Padri conciliari dovevano avere contezza. La consapevolezza che la riforma, a questo livello, sarebbe dovuta essere insieme spirituale e strutturale si fece tuttavia strada lentamente nella loro mente e nel loro cuore. Si può dire che il tema abbia tagliato trasversalmente il Concilio. La questione era subito emersa nella IV sessione, allorché i Padri tridentini avevano discusso dell’obbligo per i parroci di predicare almeno nelle domeniche e nei giorni di festa, stante la pressoché totale disattenzione per la predicazione (spesso delegata agli ordini religiosi) e per la catechesi (con casi di analfabetismo religioso).
La Chiesa aveva avvertito anche prima di Trento lo scrupolo di provvedere alla formazione presbiterale, elaborando, di volta in volta, soluzioni idonee a far fronte ai bisogni dei tempi. Non a caso, diversi Pontefici avevano indetto concili in materia. Si erano sviluppate forme strutturate di formazione dei chierici a seconda dei tempi e dei luoghi. Erano così nate le varie scuole connesse ai monasteri, alle parrocchie e alle cattedrali. I Padri tridentini poterono avvalersi del confronto con alcuni modelli istituzionali già esistenti, dei quali ricalcare la fisionomia per il nuovo istituto che stava per nascere, come chi accoglieva i giovani poveri, di età compresa tra i 15 e i 35 anni, che intendevano accedere alla vita ecclesiastica, provvedendo alla loro istruzione nel diritto canonico e nella teologia e alla loro formazione spirituale e disciplinare. Poi i due collegi fondati a Roma da sant’Ignazio di Loyola, rispettivamente nel 1551 e 1552: il Collegio Romano, che si presentava come «scuola di grammatica, di humanità e di doctrina christiana» e impartiva gratuitamente ai suoi alunni la formazione culturale e spirituale, conservando sostanzialmente l’impianto tipologico dei collegi universitari; il Collegio Germanico, che nasceva invece con la specifica finalità di formare il clero tedesco (maggiormente colpito dalla ventata protestante) secondo la più rigida ortodossia cattolica e contemplava nei suoi regolamenti l’introduzione della figura decisiva del padre spirituale, che avrebbe coadiuvato il rettore e i confessori nell’opera formativa. Ma le più interessanti indicazioni dal punto di vista teorico giunsero però dal sinodo nazionale pro reformatione Angliae, convocato nel 1555 a Londra dal cardinale Reginald Pole. Tra i decreti di questa assise non solo compariva il termine “Seminario” nell’accezione che Trento avrebbe conservato, ma veniva imposto a ogni diocesi di costituirlo. Il decreto tridentino sui seminari, Cum adolescentium aetas, fu discusso e approvato all’unanimità dai vescovi nella XXIII sessione (15 luglio 1563: canone 18 del decreto di riforma). La decisione di imporre alle diocesi l’apertura del seminario – chiamato a configurarsi come una sorta di perenne vivaio vocazionale – era sostenuta, come manifesta la premessa del testo, da motivazioni di carattere teologico e pedagogico insieme. Bisognava avviare allo stato clericale i giovani candidati, «prima che le cattive abitudini si impadroniscano completamente dell’uomo» e la capacità di perseverare nella disciplina ecclesiastica ne risultasse compromessa. Il Concilio stabilì così che nei seminari dovessero essere ammessi «i ragazzi di almeno dodici anni, nati da legittimo matrimonio, sufficientemente capaci di leggere e di scrivere e la cui indole e volontà faccia sperare della loro perpetua fedeltà ai ministeri ecclesiastici.
Il Concilio vuole che si scelgano soprattutto i figli dei poveri, senza però escludere i figli dei ricchi, purché si mantengano da sé e dimostrino impegno nel servizio di Dio e della Chiesa». Dopo i criteri di ammissione, molto interessanti dal punto di vista pedagogico, il decreto tratteggia i dati essenziali di un programma formativo che abbraccia i vari ambiti del ministero ecclesiastico (disciplinare, culturale, liturgico, spirituale, morale e pastorale), lasciando comunque ai vescovi ampio spazio d’integrazione e d’intervento locale: «Il vescovo curerà che assistano ogni giorno al sacrificio della Messa, che si confessino almeno ogni mese e ricevano il corpo del nostro Signore Gesù Cristo quando il confessore lo giudicherà opportuno, e che nei giorni festivi prestino il loro servizio in cattedrale e nelle altre chiese del luogo. Tutte queste cose, insieme ad altre opportune e necessarie a questo scopo, i singoli vescovi le stabiliranno assistiti dal consiglio di due canonici tra i più anziani e i più seri, che essi sceglieranno, secondo l’ispirazione dello Spirito santo, e provvederanno con visite frequenti a farle sempre osservare». Queste disposizioni organizzative e disciplinari occupano all’incirca la metà del testo. Nel prosieguo si tratta quasi interamente del reperimento dei fondi necessari al mantenimento del Seminario, attraverso la tassazione dei vari benefici ecclesiastici. Può stupire una simile preponderanza della questione economica nel decreto e ci si potrebbe chiedere come mai i Padri conciliari abbiano insistito tanto sull’aspetto materiale e non piuttosto sulla spiritualità e sulla formazione, cioè le vere emergenze. In molte diocesi l’istituzione Seminario decollerà soltanto dopo decenni di tentativi più o meno fallimentari e, da qualche parte, addirittura a ben più di un secolo di distanza dalla chiusura del Concilio. Una delle più frequenti cause – se non la principale – di tale ritardo fu proprio la penuria di mezzi economici, e perciò l’impossibilità per le diocesi di sovvenire alle necessità del Seminario. Istituendo i Seminari, il Concilio di Trento ha consegnato alla Chiesa un’importante eredità, su cui non a caso insisteranno tutte le successive Relationes ad limina, e che sarà ribadita prima e dopo i due Concili contemporanei. Il Vaticano II, infatti, ne ha ribadito la necessità, quale luogo in cui «tutta l’educazione degli alunni deve tendere allo scopo di formare veri pastori d’anime, sull’esempio di nostro Signore Gesù Cristo maestro, sacerdote e pastore». A 450 anni di distanza, il Seminario appare ancora uno strumento indispensabile per la cura e la promozione delle vocazioni al sacerdozio.
Molte cose, è ovvio, sono cambiate da allora, sia nella società che nella famiglia e nella Chiesa. Ciò vale particolarmente per il nostro tempo di rapidi mutamenti culturali, sociali e antropologici. Se è vero, quindi, che il Seminario in quanto tale resta una struttura e una risorsa essenziale per la vita della Chiesa, è altrettanto vero che la riflessione sui vecchi e nuovi problemi della formazione sacerdotale – in particolare: la disciplina interna e le forme d’interazione tra Seminario e vita diocesana e cittadina – è e continuerà a essere necessaria e urgente, nella consapevolezza che la vera riforma della Chiesa deve partire sempre dal suo interno: dai presbiteri e dai consacrati, quindi anche da coloro che nei Seminari si preparano ad esserlo «all’altezza dei tempi». Fare memoria allora, non è una nostalgica laus temporis, ma è una attualizzazione del passato per salvarlo dall’oblio. Esattamente mezzo secolo fa, Hubert Jedin scriveva: «Il Seminario tridentino è stato una creazione nuova, non ben precisata sotto ogni riguardo, circa la quale non si potevano avere ancora esperienze. Bisogna dunque tanto più apprezzare la lungimiranza e il coraggio dei Padri conciliari, i quali indicarono la nuova via della formazione ecclesiastica. Il Seminario doveva – e deve anche nei nostri giorni – adattarsi alle esigenze concrete dei tempi, perché solo così può mantenere e tramandare lo spirito nel quale è stato creato dai Padri del Concilio di Trento».
Vincenzo Bertolone - Arcivescovo di Catanzaro-Squillace
© Avvenire, 17 luglio 2013