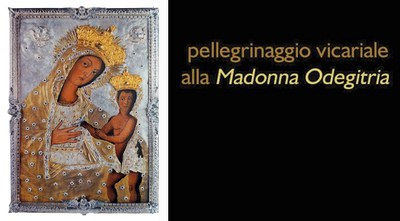Un giullare per Fortebraccio
Re di Norvegia per diritto di nascita e signore di Danimarca per elezione del compianto principe Amleto, Fortebraccio era fornito di ogni virtù necessaria a un uomo di governo. Era valoroso e leale, autorevole e giusto, clemente e infaticabile, oltre che predisposto a ben riuscire nei ritratti. A difettargli era semmai una dote minore, e cioè la propensione al riso. Non aveva, si direbbe oggi, un gran senso dell’umorismo. Al suo sguardo severo restava nascosto il ridicolo di una situazione di fronte alla quale il resto della corte si sarebbe sbellicato, ma siccome questa carenza era ben nota a chiunque frequentasse il castello di Elsinore, da quelle parti a sbellicarsi non provava più nessuno.
Ai motti di spirito, in particolare, si era rinunciato da quella volta che, alla vigilia di una battaglia, un cavaliere aveva scandito un brindisi “al braccio del nostro sovrano, al fortissimo più ancora che al forte”. Incapace di sciogliere la puerile sciarada imbastita sul suo stesso nome e sospettoso di essere vittima di ingiuria o addirittura di congiura, il re aveva lanciato un certo sguardo al capo degli arcieri e così il giorno dopo, quando già aveva vestito l’armatura, il cavaliere in questione aveva ricevuto la visita discreta del Ciambellano. Costui gli aveva spiegato che lo scontro si preannunciava duro e confuso, non si sa mai dove può conficcarsi la freccia scagliata sia pure dal tiratore più esperto, e quindi il cavaliere aveva davanti a sé la scelta: lanciarsi in campo aperto, rischiando di essere raggiunto alla schiena da un dardo, oppure prendere lì per lì la via del monastero, o ricordarsi di un voto che lo costringeva a salpare per le terre leggendarie di Vineland. Trovasse lui una scusa, altrimenti c’era il caso che il suo corpo tornasse dall’assalto disteso su uno scudo e accompagnato dagli onori che i vichinghi riservano ai loro eroi.
Una notte di agosto, mentre Fortebraccio stava affrontando la veglia boreale in compagnia di belle dame e nobiluomini specchiati, al portone del castello si presentò un pellegrino coperto da un saio, alla maniera dei frati. Chiese udienza al sovrano, gli fu concessa, raggiunse silenzioso il salone delle feste. Qui si spogliò della tonaca, rivelando uno di quei costumi dai mille colori, aderente a guisa di calzamaglia e ornato da un gonnellino che, da solo, sarebbe bastato a qualificarlo come giullare. A completare l’opera, si cacciò in testa un copricapo della stessa stoffa, tutto corna e campanelli.
«Chi sei? – domandò il solito Ciambellano –. Perché ti presenti davanti al mio signore a quest’ora di notte?»
«Il mio nome è Yorick – rispose il buffone – e sono venuto a dimostrare che Fortebraccio non è debole di mente».
Ora, il capo degli arcieri si trovava a un centinaio di miglia, al seguito di una guarnigione incaricata di sedare una rivolta ai confini del regno. Nondimeno, il sovrano si guardò intorno, ma il Ciambellano capì la mossa, scosse il capo come a scacciare un insetto e già stava per dire la sua, quando Fortebraccio sollevò un poco la punta delle dita, lasciando intendere che se la sarebbe cavata da solo.
«Yorick non è un nome norvegese», osservò.
«E infatti io sono di sangue danese, mio buon signore, anche se accadde che mia madre mi partorisse nella bella Italia».
«Sei un cospiratore?» domandò Fortebraccio, forse ignorando che ben difficilmente avrebbe ottenuto risposta affermativa. Quando mai, infatti, un traditore dichiara a gran voce i progetti di tradimento?
«Ma chiaro che sì», disse invece il giullare, nello sconcerto generale e per la soddisfazione del re, che ruotava lo sguardo sui compagni, come per dire: visto? lo sapevo io, che non c’era da fidarsi.
«Noi tutti che pratichiamo l’arte della celia e dell’arguzia siamo cospiratori al cospetto del Cielo. Spie di Dio siamo noi buffoni, mandati incontro ai regnanti per ripararli dalla catastrofe suprema».
«Di che parli?», tornò a interrogarlo Fortebraccio, sempre più confuso.
«Il buon Amleto, ricordate? Il dolce principe che in punto di morte vi affidò il trono su cui ora sedete. Bene, mio padre fu il suo vero tutore, che il Cielo mi sia testimone e Sua maestà non se ne abbia a male. E infatti finché ebbe a fianco un giullare che gli mostrasse quale commedia possa essere il mondo, il giovane Amleto fu il modello di ogni perfezione, la misura di ogni saggezza. Ma poi Yorick morì e all’erede di Elsinore toccò in sorte di diventare il buffone di se stesso».
«Ma Yorick non è il tuo nome? Perché affermi di essere morto, se sei qui di fronte a me?», obiettò Fortebraccio, speranzoso di aver colto in contraddizione l’ospite.
«Con il vostro permesso, anche voi portate il nome di vostro padre, mio signore. E pure Amleto portava quello dell’augusto genitore».
«Così si usa nelle famiglie di nobile lignaggio», intervenne stizzito il Ciambellano, che avrebbe tollerato un colpo di Stato più volentieri di un’infrazione all’etichetta.
«E infatti noialtri giullari siamo, a modo nostro, una stirpe eletta, i padroni nascosti di un mondo che nessun altro vede, ma del quale ogni regnante sulla terra dovrebbe avere contezza. Quel che mormora il popolo, i motteggi che il mugnaio scambia con il becchino, il gergo con cui gli attori alludono ai loro protettori. Sono le armi che più di tutte insidiano un trono. Buffe armi, lo ammetto. Per questo solo un buffone può contrastarle».
«Mi convincerei se tu riuscissi a farmi ridere», commentò Fortebraccio.
«Se è per questo, possiamo cominciare subito», rispose Yorick con una piroetta che fece tintinnare all’unisono i campanelli del copricapo.
«Vi narrerò la mia storia – proseguì –, di come mio padre, ancora giovane, e mia madre, nel fiore degli anni, abbiano intrapreso un viaggio da queste brume di Thule giù fino al sole d’Itala, dove ebbi la ventura di essere concepito e partorito, cresciuto ed educato».
«Perché proprio in Italia?», volle informarsi Fortebraccio.
«Perché in nessun altro Paese i buffoni sono tenuti in tanta considerazione, mio signore», rispose pronto Yorick.
Allora accadde. Dal petto di Fortebraccio iniziò a salire un tremito, che poi ridiscese verso la pancia, rimbalzò dallo stomaco fino alla gola, gorgoglio fra i denti e intanto pareva che spumeggiasse nelle orecchie, e il re fu costretto a spalancare la bocca, e da quella bocca regalmente spalancata uscì una salva di risate così sonore e poderose, così maestose e prepotenti che nessuno nella sala, neppure il Ciambellano, seppe trattenersi dall’imitare l’ilarità del sovrano.
«Sia! – sentenziò Fortebraccio – Da questo momento Yorick figlio di Yorick è mio buffone e consigliere, mia guida nell’assurdo che si cela fra le pieghe del mondo».
Così fu, per molti anni felici. Yorick però non ebbe mai il coraggio di confessare ad alcuno che quella sull’Italia e sui buffoni non era una battuta. Lui solo sapeva di essere diventato il giullare di Fortebraccio perché, una volta tanto, aveva parlato sul serio.