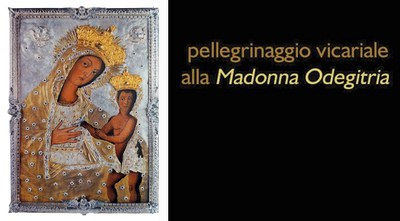La ‘via’ dell’ufficio diocesano per le comunicazioni sociali
1. Lo ‘strada maestra’ è il Vaticano II
Nei momenti di incertezza – e il nostro sicuramente lo è - più che conoscere i singoli mezzi da mettere in campo, occorre scorgere verso dove spingere lo sguardo. Insomma individuare la rotta. La coincidenza del 50° del Vaticano II con l’avvio dell’Anno della fede si offre come una base per discernere il nostro tempo e insieme per ricavare in esso la forma della comunicazione, che costituisce l’oggetto della nostra attenzione quotidiana.
Anche se il Concilio non ha mai messo esplicitamente a tema la fede, in realtà, è questa e non altra la sua profonda ispirazione. Lo si intuisce facilmente da quei ‘punti cardinali’ che sono le quattro Costituzioni[1]. Se però si volesse ritrovare lo spirito originario che ha prodotto questo evento che resta “una sicura bussola per orientarci”[2], non si può fare a meno di ritornare alla Gaudet Mater Ecclesia, da cui si ricava subito il centro del lavoro conciliare che è Cristo stesso “splendente nel centro della storia e della vita”. Giovanni XXIII che aveva lungamente lavorato a questa allocuzione lungo tutta l’estate del 1962, così prosegue: ”Illuminata dalla luce di questo Concilio la Chiesa.. si ingrandirà di spirituali ricchezze e, attingendovi forze di nuove energie, guarderà, intrepida, al futuro”. Il tono che emerge lascia trapelare il rifiuto di quella cultura della paura e del sospetto che aveva fatto capolino e che sempre tenta di riemergere nella storia della Chiesa, per dare invece spazio ad un atteggiamento di apertura e di fiducia, lontana dai ‘profeti di sventura’. “Nel presente momento storico – si confidava candidamente Papa Roncalli nel giorno inaugurale del Concilio – la Provvidenza ci sta conducendo ad un nuovo ordine di rapporti umani che, per opera degli uomini e per lo più al di là della loro stessa aspettativa, si volgono verso il compimento di disegni superiori e inattesi”. Quindi nella seconda parte dell’Allocuzione si giunge allo scopo del Concilio che consiste nel trasmettere "pura e integra la dottrina, senza attenuazioni o travisamenti”. “Il nostro dovere – affermava il Papa – non è soltanto di custodire questo tesoro prezioso, come se ci preoccupassimo soltanto dell’antichità, ma di dedicarci con alacre volontà e senza timore a quell’opera che la nostra età esige, proseguendo così il cammino che la Chiesa compie da quasi venti secoli”. Nessuna rottura con il passato, ma neanche una mera ripetizione di quel che è stato perché si intuisce che trasmettere è ‘consegnare’ dunque garantire il passaggio alla generazione successiva. Per questo occorre “un balzo innanzi” verso la penetrazione “dell’autentica dottrina” e la sua esposizione “attraverso le forme dell’indagine e della formulazione letteraria del pensiero contemporaneo”. A tale proposito affermava: ”Altra cosa è infatti il deposito stesso della fede, vale a dire le verità contenute nella nostra dottrina, e altra cosa è la forma con cui quelle vengono enunciate, conservando ad esse tuttavia lo stesso senso e la stessa portata”. E concludeva: “Si dovrà ricorrere a un modo di presentare le cose, che più corrisponda al magistero, il cui carattere è preminentemente pastorale”[3].
In questa dialettica tra deposito e forma, tra continuità del primo e discontinuità della seconda, sta la posta in gioco del Vaticano II, che aiuta anche ad orientare il lavoro di chi opera nell’ambito della comunicazione.
2. Evangelizzare è stare vicino a Dio
Nel suo primo intervento al Sinodo, sotto forma di meditazione, Benedetto XVI ha rimarcato che “la Chiesa non comincia con il ‘fare’ nostro, ma con il ‘fare’ e il ‘parlare’ di Dio”. Ed ha aggiunto: ”Se Dio non agisce, le nostre cose sono solo le nostre e sono insufficienti; solo Dio può testimoniare che è Lui che parla e ha parlato (…). Perciò è importante sempre sapere che la prima parola, l’iniziativa vera, l’attività vera viene da Dio e solo inserendoci in questa iniziativa divina, solo implorando questa iniziativa divina, possiamo anche noi divenire – con Lui e in Lui – evangelizzatori”[4].
Evangelizzare dunque è opera di Dio e ‘nostra’ solo come effetto di una vicinanza e di un'apertura, perché non possono mai scambiarsi le cose di Dio con le nostre piccole cose. Questa percezione sgrava da un eccesso di responsabilità e protagonismo e insieme carica di una consapevolezza nuova. Non è, in primo luogo, la nostra visione della vita che va assicurata, ma la necessaria sintonia con la fonte da cui tutto segue. Ribadire questa priorità non è una semplice perorazione di ordine spirituale. In realtà, nella comunicazione l’ispirazione è fondamentale, se non ci si vuole appiattire a un semplice livello di comunicazione strategico-funzionale. Da questo punto di vista, la riscoperta della dinamica comunicativa di Dio che si dà all’uomo, rivelando se stesso, è un paradigma che va ritrovato se vogliamo tornare alle fonti del nostro impegno comunicativo. Le due lettere pastorali del Card. Martini, Effatà (1990) e Il lembo del mantello (1991) non hanno perso di attualità. In particolare vorrei richiamare due spunti che possono tornarci utili.
• Comunicandosi Dio ci renda capaci di comunicare (cfr. Effatà, 31-34)
La comunicazione di Dio non è mai a senso unico: essa tende a suscitare un circuito di risposta che è proprio di ogni comunicare autentico: parola-ascolto-risposta. Dal modo con cui Dio si rivela è possibile derivare alcune caratteristiche della comunicazione interumana.
+ Anzitutto ogni comunicazione nasce dal silenzio. Per pronunciare una parola appropriata occorre prima aver ascoltato, e l'ascolto accade nel silenzio: il silenzio di sé per far spazio all'altro. Per dire qualcosa di significativo occorre poi che sia maturato dall’interno perché non si riduca a chiacchiera, sfogo, esibizionismo.
+ La comunicazione richiede tempo: non si può fare tutto in fretta e senza grazia. Occorre sapere trovare i momenti giusti e alternare parola e silenzio, enunciazione e ascolto. Non bisogna spaventarsi dei momenti di ombra: non sempre si riesce ad essere trasparenti, c’è una fatica e una opacità da accettare realisticamente per trovare, con fantasia e pazienza, i modi e le forme per ridurre, nel tempo, lo scarto tra ciò che siamo e ciò che riusciamo a comunicare, tra ciò che riusciamo a capire dell'altro e ciò che l'altro è. L'idea di una trasparenza simultanea, di un'immediatezza espressiva totale appartiene a una mitologia contemporanea che in realtà alimenta solo la superficialità e l'esibizionismo.
+ La comunicazione coinvolge sempre la persona che comunica. Non si è mai esterni rispetto a ciò che si dice e in ogni caso ‘dirsi’ è anche un po’ ‘darsi’. La comunicazione è anche dono, anzi scambio di doni, come l'etimologia stessa ci suggerisce (cum-munus).
Se queste sono le caratteristiche, non mancano alcuni rischi del comunicare.
In particolare la dissociazione, la non reciprocità, l’impazienza.
La dissociazione è l’incapacità di mettere insieme silenzio, parola, incontro, frantumando, e dunque snaturando, ciò che in quello che Ricoeur definisce il "miracolo della comunicazione" accade in modo unitario. Se si parla soltanto si scade nel verbalismo, nel concettualismo, in un solipsismo che rischia di essere arrogante e prevaricatore; se si sta muti si rischia l'isolamento, l'estraniazione, la fuga dalla responsabilità, il rifiuto della relazione.
Così la non reciprocità che è la mancata accoglienza della proposta di comunicazione e dunque di relazione, il rifiuto dello scambio in nome della paura di perdere qualcosa, di legarsi, di intraprendere un processo che può richiedere impegno ed essere vissuto come diminuzione della libertà personale; o magari il prodotto di un malinteso senso di autorità, che genera timore di esporsi e incapacità di portare il proprio contributo, pur nel rispetto dei ruoli e delle competenze.
Infine l’impazienza, la fretta di avere subito dall'altro ciò che ci aspettiamo e desideriamo, che significa non concedere il tempo di ascoltare e ascoltarsi per elaborare delle risposte che non siano pure reazioni, ma che costruiscano relazione attraverso il dono di sé. L'accoglienza è la prima mossa della comunicazione, e la pazienza - che ci libera dalla gabbia dei nostri desideri più immediati che sono spesso i meno autentici e ci apre alla scoperta dell'altro - ne è il fertilizzante.
• Le forme di comunicazione non verbale della fede (cfr. Effatà, 70-76)
L’osservazione attenta del nuovo contesto post-mediale porta a considerare, al di là del processo di comunicazione mediante segni razionali, la ricchezza di forme di comunicazione nella fede da sempre presenti nell’esperienza ecclesiale e che negli ultimi secoli - condizionati da una ragione ragionante e calcolante e, forse, da una deriva intellettualizzante in funzione vuoi antipositivista vuoi antiprotestante – sono state un po’ trascurate. Vale dunque la pena di ritrovare quelle forme comunicative della fede, verbali e non verbali, che sono sempre state presenti nella tradizione cristiana. Senza soffermarsi per mancanza di un tempo adeguato sulla pregnanza comunicativa del corpo e dei gesti, del canto e della musica nella liturgia, basterà riferirsi alla comunicazione simbolica della fede. Il linguaggio simbolico (che torna in evidenza perfino nel web, il cui lessico è caratterizzato da termini quali 'salvare', 'giustificare', 'convertire', ma anche 'condivisione', 'partecipazione'), è veicolo privilegiato dell’esperienza religiosa perché è sommamente rispettoso della ‘differenza’ e della ‘distanza’. Non ci mette infatti in presa diretta con gli oggetti, tantomeno con Dio, e per questo il simbolo consente di stabilire un rapporto rispettoso, e costituisce una proposta discreta che va accolta e interpretata, e che è poi capace di aprire a significati sempre nuovi. Il linguaggio simbolico, insomma, non è un codice che si possa esprimere con formule matematiche, ma un mezzo d’espressione quanto mai vario e modulato, che conta su diversi livelli di comunicazione che arricchisce lo spettro possibile della parola. Non è superfluo ricordare che le civiltà occidentali che hanno inventato i nuovi linguaggi digitali sono anche quelle radicate nella Bibbia. E che non c’è alcuna opposizione tra i caratteri visivi, uditivi, emotivi e sensitivi dei nuovi linguaggi e la Scrittura: anzi, i primi aiutano a far emergere in modo nuovo e capace di parlare al presente il messaggio di Dio nella Bibbia, mettendone opportunamente in luce la ricchezza e la varietà espressiva.
3. Da ‘Testimoni digitali’ ad ‘Abitanti digitali’, fino ad oggi
Il grande appuntamento di ‘Testimoni digitali’ e il segmento successivo di ‘Abitanti digitali’, hanno definitivamente introdotto nella nostra mente, ma non ancora nella prassi diffusa, alcune convinzioni di fondo. In realtà, già con il Direttorio (2004), era stato definitivamente acquisito il passaggio dei media da strumenti ad ambiente. Ora l’accelerazione subita dalla rete consente di compiere un ulteriore passo in avanti in almeno tre direzioni.
La prima è il passaggio dalla trasmissione alla generazione. Osservando le pratiche più diffuse tra i giovani, puntualmente confermate dalla ricerca coordinata dalla prof.ssa Giaccardi[5], si scopre che la comunicazione avviene solo all'interno della relazione, e che dunque non basta più il modello riduttivo del broadcasting (unidirezionale, uno-a-molti). L’essere umano è un essere inter-comunicativo e la comunicazione o è generativa o non è; o costruisce attraverso l’evento dell’incontro, la possibilità di generare insieme qualcosa di nuovo, o non è. Non a caso il teologo Theobald[6] dichiara provocatoriamente che la fede è intrasmissibile e che può essere generata solo nell’incontro, come risposta libera all’invito che ci viene rivolto (è per questo che Gesù dice: ”Figlia, la tua fede ti ha salvata"). Da questo punto di vista la rete si conferma un nuovo ‘territorio’, in cui poter creare occasioni che suscitino una domanda, e rivolgere inviti che sollecitano un movimento di risposta. Ridurre le distanze, costruire vicinanza e anche intimità attraverso la condivisione e l’accompagnamento delle esperienze e delle difficoltà del vivere può rivelarsi la condizione per scoprire nuove strade di fratellanza e nuove occasioni di evangelizzazione.
La seconda direzione è quella che va dall’autorità a una testimonianza dialogica. La rete, infatti, può essere uno straordinario ambiente di scambio e di condivisione e perfino di educazione reciproca. Non si può entrare in comunicazione senza essere disposti, in un certo senso, a lasciarsi convertire dall’interlocutore: che non significa cambiare idea come una banderuola, ma andare fino in fondo alle ragioni delle proprie convinzioni, lasciandosi provocare dall’altro. Proprio il confronto e talora il contrasto dell’incontro consente di purificare la propria fede dagli irrigidimenti delle abitudini, delle convenienze, delle autoindulgenze. La rete insomma costringe a venir fuori, invita alla testimonianza e insieme mette alla prova. La testimonianza è un 'contenuto generato dall'utente', come lo descrive p. Spadaro[7], che non ha bisogni di orpelli per restituire credibilità alla parola pronunciata, ma che comunica attraverso l'autenticità che sa esprimere, con la vita prima ancora che con le parole.
La terza direzione è quella infine che si muove dall’informazione su di sé alla narrazione polifonica. Siamo passati dalla civiltà delle immagini alla civiltà delle storie. Ci si racconta in tanti contesti e su tanti palcoscenici, ma in realtà il racconto si è impoverito, così come il nostro linguaggio e con esso, come già ricordava Walter Benjamin la nostra capacità di fare esperienza. Il nuovo contesto della rete rappresenta una opportunità perché rigenerare il racconto a partire dal bisogno di narrazione che in essa emerge prepotente (1 miliardo è censita la popolazione di Facebook) vuol dire contribuire a ritessere il legame. Tale ricostruzione infatti passa dal ‘giro lungo’ degli altri che ci interpretano e ci aiutano a costruire il racconto di noi stessi. La rete offre la possibilità che l’auto-narrazione non sia semplicemente espressiva, individualista e autoreferenziale, ma possa diventare polifonica, riconoscendo gli intrecci che ci costituiscono come esseri umani e che fondano la nostra identità.
4. “Porte di verità e di fede, nuovi spazi di evangelizzazione”
Il web 2.0 è stato definito, fin dalla nascita dei social network, come il luogo della nuova socialità, la nuova piazza in cui incontrare sempre qualcuno per parlare del più e del meno, o per osservare semplicemente ciò che fanno gli altri. Uno spazio intrinsecamente relazionale. E non importa se si tratta di una piazza digitale: come scriveva Italo Calvino nelle Città invisibili, "Ogni volta che si entra nella piazza ci si trova in mezzo a un dialogo" (1972). Dove due persone si incontrano e si riconoscono, anche solo su un particolare o un accento della loro umanità quello è un luogo[8]. E tuttavia non bisogna cadere nell’equivoco opposto di considerare le relazioni ‘in’ rete del tutto uguali a quelle ‘fuori’ della rete. Sono esperienze che si integrano, non si oppongono, ma restano obiettivamente differenti.
Parlare, in ogni caso, del web come di uno spazio di esperienza significa incorporarlo nelle pratiche quotidiane e attribuirgli dunque la dose di attenzione che merita, per il fatto di essere uno dei territori in cui ci muoviamo e interagiamo con altri, e non una dimensione aliena, fantascientifica, separata dalla nostra quotidianità.
Il titolo del messaggio per la prossima Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali è esemplare in questo senso: “Reti Sociali: porte di verità e di fede; nuovi spazi di evangelizzazione” utilizza una metafora che sposta su un piano molto concreto la definizione, e quindi la potenziale funzione, della rete in generale e dei social network in particolare. Parlare di porte e di spazi significa far riferimento ai luoghi e alle forme dell'abitare, che è il modo tipicamente umano di vivere, e che consiste nel dare forma all'ambiente, iscrivendovi i propri significati.
In quanto spazi e porte, i social network sono elementi costitutivi del nostro nuovo contesto esistenziale, e importante condizione della circolazione dei significati al suo interno. Un contesto esistenziale che è sempre più misto e che non può più essere letto con le lenti del dualismo: reale/virtuale, autentico/inautentico, concreto/fittizio.
La realtà e l'autenticità, così come la finzione e l'inganno, stanno in ogni angolo di questo nuovo contesto e non sono appannaggio di una sua dimensione. E la realtà materiale, fatta di atomi anziché di bit, non deve a sua volta essere feticizzata, perché chiudere le porte al digitale significa oggi precludersi la possibilità di vivere pienamente l'ambiente in cui ci è dato di esistere.
Uno spazio misto, fatto di diversi livelli, ha dunque bisogno di porte che facilitino il passaggio tra le zone discontinue dell'ambiente. La porta, la soglia, il limes è da sempre un simbolo antropologico fondamentale, al centro di complesse ritualità in tutte le diverse culture. È lo è perché collega/divide spazi differenti, che richiedono, per essere vissuti pienamente, la consapevolezza delle loro intrinseche qualità, così come delle loro differenze. La porta è un 'attivatore di riflessività', perché ci ricorda che i luoghi che attraversiamo, pur appartenendo al nostro unico spazio esistenziale, sono di natura differente, e questa differenza chiede di essere riconosciuta, ascoltata, trasformata in criterio di orientamento per l'azione. Così la porta della chiesa, nel separare-connettere lo spazio profano da quello sacro, ci rende consapevoli della specificità e insieme della relazione tra i due (pro-fano, davanti al tempio), e della diversa esperienza che all'interno di ciascuno, e passando dall'uno all'altro, ci si dischiude.
Il simbolo è una porta, che apre a un mondo inesauribile di significati; gli idoli invece sono segni chiusi, senza porte né finestre, che rimandano solo a se stessi. Certo, la rete può essere vissuta come un idolo, come un pozzo dei desideri in cui è possibile trovare tutto ciò che cerchiamo, senza bisogno di altro. Alla fine, un grande specchio in cui non vedere altro che la nostra immagine riflessa. Ma l'invito del Papa è a cogliere invece la loro natura di "porte" che affacciano su uno spazio che non solo non è "virtuale", ma può essere propizio alla ricerca della verità e gettare nuova luce sul cammino della fede.
La porta è un passaggio verso altro, un affaccio verso un mondo che ci è meno familiare, ma che possiamo conoscere e rendere abitabile, cioè degno della nostra umanità. Definire i social network (che non sono solo Facebook e Twitter) delle porte di verità e di fede significa predisporci a cogliere le straordinarie opportunità di rinnovare il nostro sguardo, allargare i nostri orizzonti, ascoltare i nostri bisogni profondi: di infinito, di andare oltre, di trascendenza (che ė il movimento di "oltrepassare salendo").
Se lo spazio è ciò che unisce mentre separa, la porta del web può essere un'occasione, oggi, per percorrere con rinnovato slancio lo spazio che ci separa dalla nostra umanità più autentica: quella che Gesù, nel quale è abolita ogni distanza tra cielo e terra, ci ha mostrato. E anche per raccogliere pienamente l'eredità del Concilio: non si tratta infatti solo di travasare il deposito della fede nei nuovi linguaggi, ma di trasformare i nuovi spazi in luoghi di relazione e di testimonianza. Come ha scritto Pierangelo Sequeri collegando le due "aperture" del Concilio e, 50 anni dopo, dell'Anno della fede, "dobbiamo noi stessi aprirci alla fede; e riaprire di nuovo, per tutti, la porta della fede". Il nostro lavoro non può dunque ridursi a un operare per la forma: essa, infatti, non può essere separata dal deposito della fede e la vivacità del nostro servizio è legata a doppio filo a questa sintesi sempre da precisare, per poter comunicare pienamente «la gioia della verità (gaudium de veritate)» (Agostino, Confessioni, X, 23, 33).
A chiusura una domanda è forse utile: in che modo è possibile tenere insieme queste due attenzioni, integrando cioè la gioia di un linguaggio nuovo grazie alla profondità di una verità sempre antica?
Nel dare risposta a tale domanda - grazie al dibattito che ora si apre - si cela una posta in gioco decisiva, quella di ritrovare nell’incontro tra forma e contenuto la strada per attuare pienamente il Vaticano II.
Mons. Domenico Pompili
[1] Cfr. BENEDETTO XVI, Udienza generale del 10.10.2012
[2] Cfr. ibidem
[3] G. SALE, “Gaudet Mater Ecclesia”: l’allocuzione di apertura del Vaticano II”, in CivCatt 2012 III 351-362.
[4] BENEDETTO XVI, Meditazione alla prima sessione del Sinodo
[5] C. GIACCARDI, Abitanti della rete. Giovani, relazioni e affetti nell’epoca digitale, Milano, 2010.
[6] C. THEOBALD, Il cristianesimo come stile, 2 voll., Bologna, 2009.
[7] Cfr. A. SPADARO, Web 2.0, Milano, 2010.
[8] cfr. G. GILI, Identità e riconoscimento: perché la rete è un luogo, in Atlantide, anno VI, n.2, 2010, 85-92; A. SPADARO, Cyberteologia. Pensare il cristianesimo al tempo della rete, Milano, 2012, 15-17.