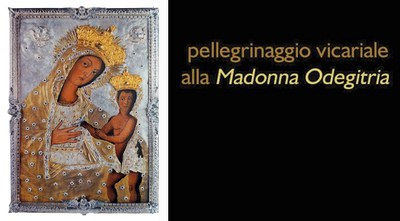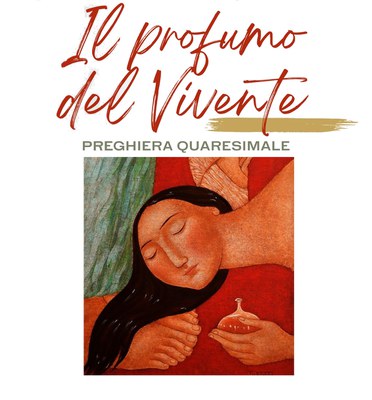La Chiesa apre le porte agli sfollati

Tra qualche giorno in giardino torneranno i bambini. I giochi sono ancora lì da giugno, dal loro ultimo giorno di scuola materna. All’ombra dei pini, tra le panchine del giardino dell’istituto delle suore del Divino Amore, c’è chi parla, chi legge, chi si racconta. In dieci dalle ore successive al terremoto del 24 agosto sono ospitati qui, in quelle camere di solito dedicate all’accoglienza dei pellegrini impegnati nel Cammino di San Francesco. Vengono da frazioni che pochi finora conoscevano, come Illica o Colle Posta, ma ci sono anche alcuni sfollati di Accumoli. Tra loro Eugenia, di origini siberiane, nel comune terremotato in vacanza con il marito Giorgio che oggi uscirà dall’ospedale.
Prova a farsi forza, perché vive il dolore più grande: ha perso la figlia Elisa di 17 mesi nel crollo della loro casa delle vacanze. «Secondo te sono pazza?», si è sentita dire proprio ieri la responsabile suor Luigina Visini da questa giovane donna, che invece di piangere cerca di rendersi utile. Forse non ha ancora realizzato bene la cicatrice che dovrà lenire o semplicemente, «visto che nella mia vita ho dato tanto coraggio a molti, ora debbo utilizzare per me quel coraggio», ha confidato a suor Luigina una sera a fine cena.
Come la superiora anche le cinque consorelle non chiedono mai nulla a questi ospiti di quella notte; il loro compito è solo ridare serenità in un momento difficile. Prima delle porte, infatti hanno aperto i cuori alla sofferenza di chi non ha più nulla. Molto spesso, «per non ferire chi è già ferito», semplicemente con il silenzio di una carezza. Come quella di Don Armando, arrivato da Benevento il giorno prima del sisma proprio da pellegrino. Con lui gli sfollati si confidano, ma non si sente di aver fatto chissà quale straordinarietà: «Dopo aver incontrato il Padre, ora faccio il padre per queste persone. Ecco il mio Giubileo della misericordia». Nella cucina dell’istituto, ogni tanto arrivano pacchi dalla Caritas o pasti dalla mensa dei poveri di Santa Chiara. Qui nessuno chiede nulla, perché «la Provvidenza vede e provvede».
Suor Luigina non si preoccupa del cibo, ma «di tenere sempre le porte aperte, di accogliere a braccia spalancate chi bussa», perché «siamo persone nate per amare ». L’impegno così adesso non è solo orientato a «donare, ma a donare in continuità, ad esserci insomma». Soprattutto quando si ha davanti persone come Giovanni (90 anni), Lidovina (85) in sedia a rotelle e i due figli con problemi mentali -accuditi da assistenti - da cui non vogliono separarsi. Aspettano di poter tornare nella loro casa, solo lesionata, a Colle Posta, dove hanno orto e animali a cui badare, «ma sappiamo che ci vorrà pazienza», minimizzano. Prega il Signore ogni momento per loro, perché «incontrino persone che non gli facciano sentire il peso della disperazione ».
Perché la dignità di tutti questi 'pellegrini del sisma', ammette, «mi commuove: qualcuno ha già detto che un giorno ci restituirà tutto quello che gli abbiamo offerto in questi giorni». Come il 60enne Lucio, della frazione Illica, che aveva solo 10 euro in tasca e doveva raggiungere la madre anziana ricoverata. «Gli ho dato pochi euro donati da alcuni sconosciuti reatini - racconta la Superiora - e sul suo volto, accanto al grande imbarazzo, ho visto scendere una lacrima».
Come loro, nella cittadina reatina, hanno aperto le porte moltissime strutture religiose: le suore di Santa Caterina dando ospitalità ai sacerdoti delle frazioni terremotate per consentir loro di fare la spola con Rieti ogni giorno, quelle Oblate del Gesù Bambino accogliendo alcune famiglie dell’Amatriciano, i Frati minori del santuario di Greccio visitato alcuni mesi fa da Papa Francesco - mettendo a disposizione dei terremotati l’oasi degli esercizi spirituali e una casa parrocchiale. Come pure la Chiesa avventista del settimo giorno di Rieti, che ha spalancato il suo centro polivalente per accogliere tredici musulmani provenienti da Albania, Kosovo e Macedonia, dal 1991 residenti ad Amatrice. Qui, nel grande salone, 5 bambini preparano un piccolo dolce per la festa di Zac, macedone che proprio oggi compirà 37 anni. Tutti lavorano per la sua festa, lui continua a dire che vuole tornare ad Amatrice per aiutare. «Non riesco più a stare qui sapendo, che ci sono tante cose da fare su, tra la mia gente» ripete a Sabrina Casciani, la volontaria Adra. L’idea di andar via da Amatrice non lo ha sfiorato neppure, perché «è la terra che mi ha accolto vent’anni fa, ora è la mia casa».
Alessia Guerrieri
© Avvenire, 2 settembre 2016
Il senso profondo del ben costruire
Il buon lavoro contro la distruzione
Perché si lavora? Presa sul serio, la domanda è tutt’altro che banale. Si lavora sicuramente perché si deve. Per garantirci un reddito, di conseguenza una vita il più possibile buona a noi e ai nostri cari. Ma si lavora anche per costruire qualcosa. È per questo che le terribili immagini delle macerie che deturpano il cuore dei borghi appenninici del Centro Italia colpiti dal terremoto sono così dolorose. Certo siamo in pena per le vite spezzate, per i feriti, per quanti ancora sono dispersi e non si sa – non sappiamo – se verranno trovati in mezzo alle macerie. Ma sono le macerie stesse a farci stare in pena, perché noi siamo fatti per costruire e quando vediamo la distruzione, il cuore si ribella.
C’è poi qualcuno che nel proprio lavoro tradisce questa vocazione a costruire. È il caso di chi, per profitto, per superficialità, per negligenza, ha contribuito a edificare una cosa fatta per distruggersi. Una terribile contraddizione di termini, che lega in qualche modo in questi giorni le macerie di Amatrice con quelle di Aleppo, distrutte non da un sisma ma da bombe costruite da uomini. Una terribile contraddizione richiamata dal vescovo di Rieti, Domenico Pompili, durante i funerali delle vittime di Amatrice ed Accumuli: «Il terremoto non uccide. Uccidono le opere dell’uomo». Uccide il frutto avvelenato di un lavoro che ha perso il suo significato, che è la costruzione.
Costruzione per una vita buona, nostra, dei nostri familiari, dei nostri clienti, di chi serviamo con il nostro ingegno, le nostre abilità, la nostra applicazione. Senza questo significato del lavoro restano solo la fatica e il profitto. Il secondo deve essere sempre più grande, la prima sempre minore, fino a scomparire. Così ritorna sempre più incalzante la questione della 'necessità del lavorare': se non avessimo la necessità di guadagnare, avrebbe ancora senso lavorare? La domanda non è affatto accademica, anzi è presente nell’agenda di molte forze politiche che – in vario modo – trattano di un reddito 'di cittadinanza' (teso non tanto a riavviare al lavoro e all’inserimento sociale che ne consegue, ma a liberare dalla necessità di avere un lavoro retribuito) o nell’agenda di quegli intellettuali che prefigurano nuovamente una 'fine del lavoro', magari in seguito ad una nuova rivoluzione industriale che 'affranchi' definitivamente l’uomo dalla fatica.
Ma c’è un modo di lavorare che, in questi giorni terribili, tutti abbiamo davanti agli occhi. Quello dei soccorritori, dei vigili del fuoco che scavano tra le macerie e piangono perché non sono arrivati in tempo. Il lavoro dei volontari che offrono gratuitamente la loro fatica per ri-costruire speranza in comunità che rischiano la distruzione, insieme a quella delle loro case.
Quanto vediamo ci restituisce il volto più vero, più umano del lavoro, che certo è fatica ed è anche profitto («la giusta mercede»), ma soprattutto è significato. Cooperare all’opera creatrice di Dio, che è costruttore, sempre. Allora mi pare che oggi si debba ricordare l’esigenza, la necessità di sviluppare un’educazione al lavoro. Perché il desiderio di costruire è inciso nel cuore dell’uomo, ma poi si incrosta di mille scorie che nel tempo rischiano di non permettere più di coglierne l’essenza più profonda e restano quindi solo fatica e profitto.
Tutti noi adulti abbiamo bisogno di questa educazione, l’educazione di chi lavora ad Amatrice e negli altri paesi distrutti e non si ricorda quasi della fatica, né si sofferma sul profitto, ma ha ben chiaro il senso del suo lavorare. Tra pochi giorni i nostri ragazzi torneranno a scuola. I più tra le mura della propria classe, alcuni probabilmente sotto una tenda perché la loro scuola non ha più mura. L’augurio è che possano trovare adulti, insegnanti, educatori, che con il loro lavoro rendano testimonianza di quanto conti il desiderio di costruire e di come questo desiderio apra mente e cuore al conoscere e all’apprendere. Così si ricostruisce un paese, non solo liberandolo dalle macerie di pietra, ma anche dalle macerie di un significato smarrito, che attende tenacemente di essere ritrovato.
Stefano Gheno
© Avvenire, 2 settembre 2016