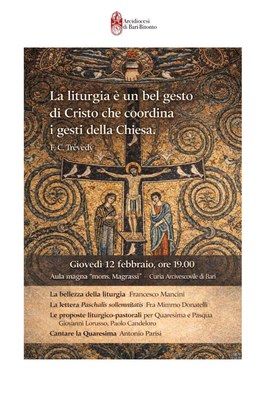Giacobbe e Rachele: ministero di cura e dono della vita
 Ringrazio anzitutto l’arcivescovo Francesco per la stima e il coraggioso invito: non è così abituale che una donna guidi il ritiro ai presbiteri … anche se sono passati 50 anni dal Concilio! Questa apertura fa onore alla vostra comunità diocesana, di cui ho avuto modo di apprezzare la ricchezza e vitalità pastorale già in occasione del Congresso Eucaristico (2005). Grazie a voi fratelli presbiteri dell’amore che avete per il Signore Gesù e per la sua Chiesa.
Ringrazio anzitutto l’arcivescovo Francesco per la stima e il coraggioso invito: non è così abituale che una donna guidi il ritiro ai presbiteri … anche se sono passati 50 anni dal Concilio! Questa apertura fa onore alla vostra comunità diocesana, di cui ho avuto modo di apprezzare la ricchezza e vitalità pastorale già in occasione del Congresso Eucaristico (2005). Grazie a voi fratelli presbiteri dell’amore che avete per il Signore Gesù e per la sua Chiesa.
Ci lasciamo guidare dalla Parola di Dio, fondamento e nutrimento della nostra fede, anima della nuova evangelizzazione. Come annunciare oggi la bella notizia di un Dio che ha tanto amato il mondo da dare il suo Unigenito? Come dare ragione della nostra speranza? Come essere trasparenza del Pastore bello?
Il come, lo “stile” non è affatto indifferente. Anzi, è proprio sul “come” che siamo chiamati maggiormente a riflettere e interrogarci, sulle modalità, sullo stile della nostra pastorale, del nostro dire la fede, del nostro comunicare il Vangelo.
Il “come” è in primo piano nella stessa esortazione che Pietro rivolge ai presbiteri (1Pt 5,1-4). Nulla è detto infatti sul significato e contenuto del “pascere” mentre invece l’enfasi è posta decisamente sul “come”, scandito da una triplice antitesi: “non per costrizione ma volontariamente, non per interesse ma con animo generoso, non come padroni … ma facendovi modelli del gregge” (1Pt 5,2-3).
Merita inoltre attenzione l’aspetto della reciprocità, bene evidenziato nell’esortazione di Pietro da un duplice en hymîn (“in voi”) che esprime un vicendevole prendersi cura. Anzitutto i presbiteri sono visti affidati alla comunità: non “sopra”, né semplicemente “accanto”, ma piuttosto “dentro”, nel vivo della comunità ecclesiale: en hymîn (1Pt 5,1). Il secondo en hymîn caratterizza l’imperativo specifico: “Pascete il gregge di Dio che vi è affidato” (letteralmente: che è “in voi”, 1Pt 5,2). Dunque, reciprocità come un vicendevole prendersi cura.
1. Il Dio che è stato il mio Pastore …
Iniziamo il nostro percorso con l’icona di Giacobbe e Rachele, particolarmente suggestiva in chiave di reciprocità pastorale. Giacobbe è il primo che nella Bibbia si rivolge a Dio chiamandolo “mio pastore” e Rachele, la bella pastora, muore donando la vita, figura del Pastore bello che depone la propria vita per le pecore.
Ambientiamoci idealmente in Egitto dove il patriarca Giacobbe è sceso con tutta la sua famiglia. Una storia intricata quella di Giacobbe, figlio di Isacco. Una storia tessuta di lotta (si urtava con suo fratello già nel grembo materno) di inganni e di prevaricazione, di conflitti e di furbizia, di fatica e di lacrime. Dal grembo materno uscì per primo Esaù, ma Giacobbe “teneva in mano il calcagno” del fratello” (Gen 25,26). Un presagio del suo carattere e di ciò che sarebbe diventato: colui che soppianta Esaù carpendone la primogenitura (ricordiamo la famosa minestra di lenticchie!) e poi la benedizione del padre (Gen 27). Una vita errante e tortuosa, segnata da due grandi dolori: la morte della moglie Rachele nel dare alla luce Beniamino e la perdita dell’amatissimo figlio Giuseppe, che credeva sbranato dalle belve mentre era stato venduto dai suoi fratelli per gelosia.
Ormai Giacobbe è vecchio e suo figlio Giuseppe (il primogenito di Rachele,) vuole che il padre benedica i suoi due figli Manasse e Efraim (Gen 48). Il racconto è carico di allusioni, abbiamo a che fare con un rito di adozione (Efraim e Manasse diventano due tribù importanti) e con un testamento spirituale. Notiamo anzitutto un dettaglio: Giuseppe aveva posto i suoi due figli secondo l’ordine di precedenza, il primogenito alla destra e il secondogenito alla sinistra, ma il vecchio padre capovolge la situazione: «Israele stese la mano destra e la pose sul capo di Efraim, che pure era il più giovane, e la sua sinistra sul capo di Manasse, incrociando le braccia, benché Manasse fosse il primogenito» (Gen 48,14). Giuseppe si dispiace, pensa che il padre, ormai vecchio, si è confuso e gli dice: «Non così, padre mio: è questo il primogenito, posa la destra sul suo capo!» (Gen 48, 18). Giacobbe però si rifiuta e risponde: «Lo so, figlio mio, lo so», come a dire: non sono rimbambito, sono pienamente consapevole di ciò che sto facendo. Sei tu, figlio mio, che invece devi entrare in un altro sapere, diverso rispetto alla logica del diritto, un sapere che testimonia la libertà divina: «il minore sarà più grande … ». Insomma, il Dio di Giacobbe capovolge le sorti! Ed ecco la benedizione che ha il sapore di un testamento spirituale e che, come vedremo, comunica l’esperienza viva della divina misericordia:
«Il Dio, alla cui presenza hanno camminato
i miei padri Abramo e Isacco,
il Dio che è stato il mio pastore
da quando esisto fino ad oggi,
l’angelo che mi ha liberato da ogni male,
benedica questi ragazzi!» (Gen 48,15-16).
Mi colpisce il fatto che Giacobbe non si limita a tramandare ciò che Dio è stato per i suoi padri. Egli aggiunge il proprio vissuto, sente il bisogno di comunicare la sua personale esperienza di Dio, il “Pastore” di tutta la sua vita. Bellissimo! È la prima volta che ricorre questo titolo nella Bibbia e a mio avviso, per coglierne appieno il significato, non basta ricorrere al dizionario o al confronto con la cultura egizia che già riferiva a Dio il titolo di pastore. Benché tale confronto sia interessante (ho avuto modo di approfondirlo durante i miei studi a Gerusalemme e ne ho dato una sintesi nel libro “La tenda e il bastone. Figure e simboli della pastorale biblica”, Edizioni Paoline 1992), se vogliamo capire davvero cosa significa per il vecchio Giacobbe che Dio è stato il Pastore di tutta la sua vita, occorre percorrere le grandi tappe del suo cammino perché è dentro i meandri della sua travagliata esistenza che appare il volto buono del Pastore che si prende cura.
2. Giacobbe trasforma la promessa in scommessa
Vi propongo dunque una sorta di percorso a ritroso, osservando come Dio si è comportato con Giacobbe (che è molto diverso da Abramo) e come lo ha “educato” tenendo conto del suo carattere e dei suoi stessi errori.
Partiamo da Betel (Gen 28). Giacobbe sta fuggendo per mettersi in salvo dall’ira del fratello Esaù. È diretto verso la Mesopotamia, terra d’origine dei suoi padri, e precisamente a Paddan-Aram, da Labano, zio materno. Percorre dunque a ritroso l’esodo di Abramo (Gen 12,4-9). Non è difficile immaginare il suo stato d’animo: paura del fratello che trama di ucciderlo, precarietà, insicurezza e timore per i tanti pericoli del viaggio … In questa situazione, nel cuore della notte, Dio gli appare. Gli rivolge la benedizione già fatta ad Abramo e si dichiara suo compagno di viaggio: “Ecco, io sono con te e ti proteggerò dovunque tu andrai; poi ti farò ritornare in questa terra, perché non ti abbandonerò senza aver fatto tutto quello che ti ho detto” (Gen 28,15).
Dio si impegna con una promessa, ma Giacobbe risponde a modo suo, con il condizionale. Notiamo l’insieme: da un lato si meraviglia di quella singolare esperienza avuta in sogno, prende la pietra che gli aveva fatto da guanciale e la erige come una stele, la consacra versando olio su di essa, ma mentre compie questo rito dice delle parole che suonano come una sfida: “Se Dio sarà con me e mi proteggerà in questo viaggio che sto facendo e mi darà pane da mangiare e vesti per coprirmi, se ritornerò sano e salvo alla casa di mio padre, il Signore sarà il mio Dio” (Gen 28,20-21).
Si noti la provocazione. Dio gli ha appena detto: “Io sono con te e ti proteggerò dovunque tu andrai”, e Giacobbe replica con il “se”, sembra sfidare il buon Dio, mette avanti le sue condizioni, solo se tornerà sano e salvo alla casa di suo padre il Signore sarà il “suo Dio”. Come a dire: solo a queste condizioni mi fiderò del tutto, non prima. In altre parole, Giacobbe trasforma la promessa in scommessa. E Dio sta al gioco.
3. Al pozzo di Carran: l’incontro con Rachele
L’incontro di Giacobbe con Rachele avviene presso il pozzo, luogo di appuntamento dei pastori di Carran. La Genesi lo racconta in modo suggestivo, intrecciando vari elementi simbolici. Accanto al pozzo stanno tre pastori di piccolo bestiame che attendono l’arrivo degli altri greggi per rotolare via la grossa pietra che copriva la bocca del pozzo e abbeverare il bestiame. Giacobbe domanda: “Conoscete Làbano, figlio di Nacor?”. Risposero: “Lo conosciamo”. Disse loro: “Sta bene?”. Risposero: “Sì; ecco la figlia Rachele che viene con il gregge”. Egli stava ancora parlando con loro, osserva il narratore, “quando arrivò Rachele con il bestiame del padre; era infatti una pastorella” (Gen 29,4-9).
A questo punto non ci attenderemo forse che Giacobbe si presenti e abbracci la cugina? E invece ecco cosa avviene: “Quando Giacobbe vide Rachele, figlia di Labano, fratello di sua madre... fattosi avanti, fece rotolare la pietra dalla bocca del pozzo e fece bere le pecore di Làbano, fratello di sua madre” (Gen 29,10). Diventa super forte Giacobbe quando vede la bella Rachele, al punto che compie da solo ciò che abitualmente veniva fatto con l’apporto di molti: fece rotolare la pietra che copriva il pozzo e abbeverò le pecore. Solo dopo “Giacobbe baciò Rachele e pianse” (Gen 29,11).
L’amore che fiorisce al pozzo della Parola ha il suo “segno di riconoscimento” nel servizio, nel dare l’acqua. Secondo l’interpretazione rabbinica il pozzo è simbolo della Torah: “da lì ciascuno ha tirato fuori dell’acqua per il suo gruppo, la sua tribù, la sua famiglia” (Midrash Rabbah). L’acqua è dono del Signore, ma per renderla bevibile occorre togliere la pietra dalla bocca del pozzo. Ed è ciò che fa Giacobbe quando vede Rachele, la bella pastora che suscita in lui un impeto che si traduce in servizio. Splendida icona della reciprocità uomo-donna nell’ambito della famiglia e nella più ampia diakonia pastorale.
4. Dammi figli, se no io muoio
Per avere in moglie Rachele, Giacobbe prestò servizio sette anni e “gli sembrarono pochi giorni tanto era il suo amore per lei” (Gen 29,20). Carina questa dichiarazione di amore, credo non dispiacerebbe a nessuna donna. Sette anni di fatica che volano come un lampo tanto era l’attesa! Ma poi, quando giunge il fatidico giorno delle nozze, anziché Rachele viene introdotta nella camera nuziale Lia, quella che “aveva gli occhi smorti”, la figlia maggiore di Labano. Giacobbe si rende conto dell’inganno soltanto al mattino e deve insaccare un amaro scacco: lui furbo ingannatore è stato a sua volta ingannato! Dovrà lavorare al servizio di Labano altri sette anni per avere in sposa Rachele che egli “amò più di Lia” (v. 30).
Ma Rachele era sterile, come già Sara e Rebecca. Le bellissime madri di Israele condividono l’afflizione della sterilità, al punto che Rachele diventa gelosa della sorella Lia, bruttina ma feconda, e grida a Giacobbe: “Dammi dei figli, se no io muoio!” (Gen 30,1). Commenta Lutero: “Non mi ricordo di avere mai letto nulla di simile in alcuna storia. Rachele desidera tanto avere dei figli, da preferire di morire piuttosto che restare sterile” (In Genesim enarrationes). Dio ascoltò questo grido, esaudì Rachele e “la rese feconda” (Gen 30,22). Rachele partorì il suo primogenito e lo chiamo “Giuseppe”. Meraviglia che Giacobbe abbia un debole per questo figlio e lo amasse più di tutti? Era il figlio di Rachele, la donna del cuore! E a questo punto, dopo la nascita di Giuseppe, la storia segna una svolta: Giacobbe decide di far ritorno nella terra di Canaan con tutta la sua tribù e il suo bestiame.
5. Il fratello, la preghiera e la lotta
Saltiamo alcuni passaggi e ci ambientiamo sulle rive dello Yabbok, un affluente del Giordano. Sono passati più di vent’anni da quando Giacobbe era fuggito per mettersi in salvo dall’ira di suo fratello Esaù, cui aveva carpito la benedizione. Ora sta tornando con tutto il bestiame che si era procurato al servizio di Labano, con la numerosa servitù, con tutti i suoi figli e le sue mogli Lia e Rachele. Ma i messaggeri informano che al di là del fiume è in agguato suo fratello con quattrocento uomini. Che ne sarà allora di tutto ciò che la vita gli ha dato? Che ne sarà delle sue mogli e dei suoi bambini?
Giacobbe affronta la paura dell’incontro invocando Dio con una intensa preghiera e poi con le armi dell’astuzia e dell’abilità diplomatica. Egli non può permettersi di affrontare il fratello che avanza armato. Cerca dunque di prevenire la catastrofe facendo leva sui sentimenti di umanità, sul buono che infondo all’animo deve pur esserci anche in suo fratello. Divide la sua gente in due schiere, in modo che se viene sconfitto un accampamento si salvi almeno l’altro. E poi manda avanti un corteo disarmato di donne e bambini dei simbolici doni, con l’ordine ai servi di rispondere così alla domanda di chi fosse il bestiame: “Di tuo fratello Giacobbe; è un dono inviato al mio signore Esaù; ecco egli stesso ci segue” (Gen 32,19). Egli pensava infatti: “Lo placherò con il dono che mi precede e in seguito mi presenterò a lui; forse mi accoglierà con benevolenza” (Gen 32,21).
Merita attenzione questo modo di affrontare il conflitto con il fratello, e non solo per la sottile diplomazia ma perché fa leva sui sentimenti di nobiltà e fierezza di Esaù, che infatti reagirà in modo sorprendente e non si lascerà vincere in generosità. Ma notiamo che prima di tutto questo c’è un rivolgersi a Dio da parte di Giacobbe, con una preghiera che non nasconde i sentimenti di paura. Giacobbe disse: «Dio del mio padre Abramo e Dio del mio padre Isacco, Signore, che mi hai detto: “Ritorna nella tua terra e tra la tua parentela, e io ti farò del bene”, io sono indegno di tutta la bontà e di tutta la fedeltà che hai usato verso il tuo servo. Con il mio solo bastone avevo passato questo Giordano e ora sono arrivato al punto di formare due accampamenti. Salvami dalla mano di mio fratello, dalla mano di Esaù, perché io ho paura di lui: che egli non arrivi e colpisca me e, senza riguardi, madri e bambini!» (Gen 32,10-12).
Sulla via del ritorno Giacobbe comincia dunque a rendersi conto che Dio gli ha dato molto più di ciò che lui aveva chiesto a Betel, non solo cibo, vestito e salute, ma ricchezza di figli e di bestiame. Tuttavia c’è ancora qualcosa che deve essere superato prima di tornare a Betel per dichiarare vinta la scommessa e riconoscere definitivamente il Dio dei padri come il proprio Dio. Al di là del fiume c’è l’ombra minacciosa del fratello, o meglio: nell’animo di Giacobbe c’è la grande paura di Esaù. È da questa paura che il patriarca chiede di essere liberato.
Come risponde Dio a questa preghiera? Mi piace collegare la risposta divina con il racconto che segue, la misteriosa lotta di Giacobbe. Dio abilita ad affrontare il fratello attraverso un misterioso corpo a corpo, che impegna tutta la notte. Dopo che Giacobbe fece passare il guado dello Iabbok alla sua famiglia e tutti i suoi beni erano sull’altra riva, egli rimase “solo” e “un uomo lottò con lui fino allo spuntare dell’aurora” (Gen 32,25). Giacobbe non desiste, continua a lottare anche quando il misterioso personaggio gli colpisce l’articolazione del femore. Non vuole lasciarlo andare senza essere prima benedetto (insaziabile il nostro Giacobbe, non gli basta l’avere carpito la benedizione di suo padre): «Non ti lascerò, se non mi avrai benedetto!». Gli domandò: «Come ti chiami?». Rispose: «Giacobbe». Riprese: «Non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele, perché hai combattuto con Dio e con gli uomini e hai vinto!» (Gen 32,28-29).
Questa lotta corpo a corpo con il misterioso personaggio in cui Dio si nasconde e al contempo si rivela, è un’icona suggestiva che si presta a molteplici letture. Nel libro della Sapienza viene interpretata in chiave spirituale, come preghiera insistente: “gli assegnò la vittoria in una lotta dura, perché sapesse che più potente di tutto è la pietà” (Sap 10,12). Sta il fatto che questa dura lotta non indebolisce Giacobbe ma lo rafforza e lo abilita a trovare la giusta strategia per affrontare il fratello e risolvere un conflitto durato più di vent’anni.
5. La bella pastora che muore donando la vita
A questo punto però occorre tornare a Betel perché Dio che ha vinto la scommessa, come riconosce Giacobbe quando ordina alla sua famiglia: «Eliminate gli dèi degli stranieri che avete con voi, purificatevi e cambiate gli abiti. Poi alziamoci e saliamo a Betel, dove io costruirò un altare al Dio che mi ha esaudito al tempo della mia angoscia ed è stato con me nel cammino che ho percorso» (Gen 35,2-3).
Ecco chi è il Pastore di Giacobbe! Un Dio che si fa compagno di viaggio, che ti rispetta, ti custodisce e percorre tutte le tue strade (non solo quelle dritte, ma anche le buie e tortuose), che ti raduna dalle tue dispersioni, che ti fa ritornare e attende che tu lo riconosca. La pietra memoriale su cui Giacobbe aveva versato l’olio consacratorio si trasforma a questo punto in un “altare” che sancisce l’alleanza, dove il Dio di Giacobbe/Israel è riconosciuto da tutta la famiglia.
Ed è proprio sulla via del ritorno da Betel che si compie l’ultimo atto della vita di Rachele, che muore dando alla luce il suo secondogenito: “Mancava ancora un tratto di cammino per arrivare ad Èfrata, quando Rachele partorì ed ebbe un parto difficile. Mentre penava a partorire, la levatrice le disse: «Non temere: anche questo è un figlio!». Mentre esalava l’ultimo respiro, perché stava morendo, essa lo chiamò Ben-onì (= figlio del mio dolore), ma suo padre lo chiamò Beniamino” (Gen 35,16-18). Rachele, la bella pastora, muore dando alla luce il figlio del suo dolore, che Giacobbe chiama prontamente Beniamino, ovvero “figlio della destra, figlio di benedizione”.
È una morte feconda quella di Rachele, la bella pastora, prefigurazione suggestiva di Gesù, “il pastore bello che dà la vita” (Gv 10,11). La tomba di Rachele sulla strada di Betlemme è il monumento alla vita che sgorga dalla morte. Ed è questa scena che il vecchio Giacobbe ricorda prima di benedire i due figli di Giuseppe in Egitto (Gen 48,7).
6. “Per fede Giacobbe morente benedì i figli di Giuseppe…”
Abbiamo percorso a grandi linee il cammino di Giacobbe che giunto alla fine della sua vita dichiara: “Dio è stato il mio pastore da quando sono venuto al mondo fino ad oggi” (Gen 48,15). Percorrendo le tappe salienti di questa vita errabonda, abbiamo potuto renderci conto della concretezza di questa dichiarazione sulle labbra del vecchio patriarca.
Sorprendentemente la Lettera agli Ebrei riprende proprio questo dettaglio per fare l’elogio della fede di Giacobbe. Non dice (come forse ci attenderemo): “Per fede Giacobbe lottò con Dio”, bensì: “Per fede, Giacobbe, morente, benedisse ciascuno dei due figli di Giuseppe …” (Eb 11,21).
La fede rende capaci di guardare avanti e benedire... La fede che Giacobbe trasmette ai figli di suo figlio è maturata strada facendo, nel suo andare e tornare, guidato dalla fedeltà del suo Pastore.
Ma i figli di Giacobbe/Israel hanno recepito questa testimonianza di fede?
Se leggiamo la benedizione di Gen 48,15 nel più ampio contesto della Bibbia possiamo notare che alla traditio corrisponde la redditio, come attesta il Salmo di Davide: “Il Signore è il mio pastore non manco di nulla” (Sal 23,1). L’esperienza di Giacobbe è diventata effettivamente patrimonio dei suoi figli, esperienza spirituale di Israele e della Chiesa. Anche se la strada passa per una valle oscura (che evoca la morte), il credente non teme alcun male. Non perché è astuto e intelligente. Ma perché può dire: “Tu sei con me” (Sal 23,4).
Sr Elena Bosetti
Leggi anche: Il pastore dell’Esodo. Mosè e Miriam: guida pastorale e profezia
Leggi anche: La Comunità Cristiana e i Presbiteri. L'esortazione di Pietro
Leggi o scarica anche lo studio su Mosè e Gesù, "il Pastore grande" di sr. Elena Bosetti
________________
Elena Bosetti, nata a Pressano di Lavis (TN) il 14 agosto 1950, è suora di Gesù buon Pastore, della Famiglia Paolina.
Dottore in teologia biblica, è autrice di numerose pubblicazioni scientifiche e divulgative tradotte in più lingue e ha commentato per diversi anni il Vangelo nel programma “A sua immagine - Le ragioni della speranza” (Rai Uno).
Già docente di ecclesiologia e di esegesi del NT alla Pontificia Università Gregoriana e in altri Atenei romani, insegna all’Istituto di Teologia per la Vita Consacrata “Claretianum” (Roma) e all’Istituto Superiore di Scienze Religiose “C. Ferrini” (Modena).
Collabora con diverse Riviste di carattere teologico e pastorale. Si dedica al ministero della Parola e alla formazione biblica, in Italia e all’estero.
Ha conseguito presso la Pontificia Università Gregoriana (Roma) il baccalaureato in Filosofia (1973) e la licenza in teologia con specializzazione in dogmatica (1978). Ha frequentato lo Studium Biblicum Franciscanum di Gerusalemme (1982-84) e trascorso vari periodi di ricerca presso l’École Biblique. Nel 1988 ha conseguito il dottorato in teologia biblica presso la Pontificia Università Gregoriana, con la tesi «Poimēn kai Episkopos: la figura del pastore nella Prima Lettera di Pietro (2,18-25; 5,1-4)».
Tra le sue pubblicazioni:
- Il Pastore. Cristo e la chiesa nella Prima lettera di Pietro (Supplementi alla Rivista Biblica, 21) EDB, Bologna 1990.
- Yahweh Shepherd of the People. Pastoral Symbolism in the Old Testament, St Pauls, Slough (UK) 1993.
- Cantico dei Cantici: “Tu che il mio cuore ama”, San Paolo, Cinisello Balsamo (Mi) 2001.
- con A. Colacrai (edd.), Apokalypsis. Percorsi nell’Apocalisse di Giovanni. In onore di Ugo Vanni, Presentazione di Carlo M. Martini, Cittadella Editrice, Assisi 2005.
- Donne della Bibbia: bellezza intrighi fede passione, Cittadella Editrice, Assisi 2009.
- Meditating with Scripture: John's Gospel, The Bible Reading Fellowship, Abingdon (UK) 2010.
- Sandali e bisaccia. Percorsi biblici del “prendersi cura”, Cittadella Editrice, Assisi 2010.